Vogliamo davvero dei robot realistici?
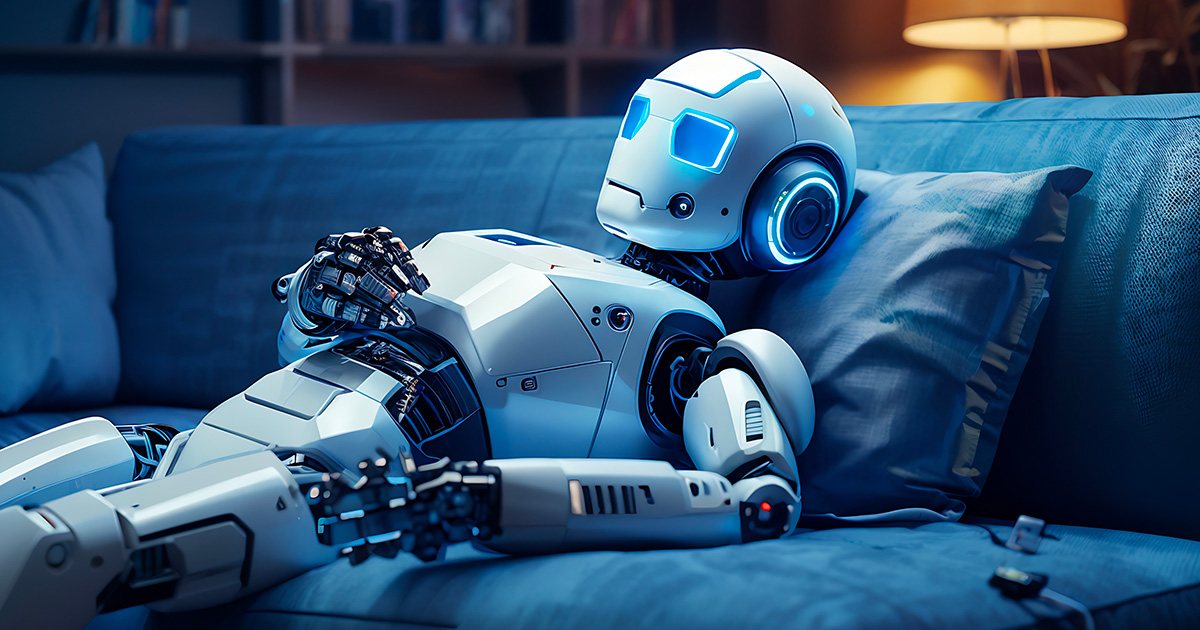
Vi trovate in una stanza con un robot. Ha occhi che sembrano umani, un sorriso appena accennato, i suoi movimenti vi ricordano qualcuno che conoscete. Eppure, c’è qualcosa che non torna. È come quando si vede una statua di cera un po’ troppo realistica e per un istante ci si convince che stia per muoversi, ma nel caso del robot questa sensazione è più forte, perché può muoversi davvero. A quel punto si comincia a sentire una sensazione di disagio, che può essere più o meno lieve, perché nel nostro cervello è in atto un conflitto: da una parte ci sembra di avere di fronte un essere umano, dall’altra qualcosa stride, come se questo robot stesse trascinando non il gesso, ma direttamente il suo dito metallico su una lavagna. Ci troviamo spiazzati, e più o meno inconsciamente ci chiediamo: “È una persona o no? Dovrei parlarci o chiamare un esorcista?”.
L’”unheimlich” di Freud e Jentsch
Questa sensazione non scaturisce solo alla vista di un robot. Rimandiamo al concetto di perturbante (tedesco: unheimlich), formalizzato da Freud, ma individuato in precedenza, come “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare” e ulteriormente precisato dal suo collega Ernst Jentsch che come esempio calzante riporta proprio l’incertezza intellettuale legata al “dubbio che un essere apparentemente inanimato sia vivo davvero e, viceversa, il dubbio che un oggetto privo di vita non sia per caso animato” (Zur Psychologie des Unheimlichen, 1906).
L’”uncanny” di Masahiro Mori
A questo punto entra in scena una teoria affascinante della robotica, quella dell’Uncanny Valley (potremmo tradurla con un evocativo “valle del perturbante”), formulata nel 1970 da Masahiro Mori, un ingegnere giapponese specializzato in robotica e pubblicata in un articolo sulla rivista Energy intitolato Bukimi no Tani Genshō ("Il fenomeno della valle del perturbante"), dove Mori descrive come la somiglianza dei robot con gli esseri umani influisca sulla risposta emotiva di questi ultimi. Secondo questa teoria, più un robot somiglia a un essere umano, più aumenta il nostro senso di empatia e familiarità, ma solo fino a un certo punto. Superata una certa soglia di somiglianza, il piacere estetico inizia a calare bruscamente, trasformandosi in disagio o addirittura paura.
Più un robot sembra una persona, più notiamo le differenze sottili: una mano troppo rigida, uno sguardo vuoto o un sorriso che non è un sorriso, come quello della Gioconda ma più inquietante. Questo scarto tra l’attesa di qualcosa di vivo e la percezione di qualcosa che invece non lo è ci manda in tilt, come avevano spiegato Freud e Jentsch.
“ Siamo sicuri che superare l'uncanny valley abbia senso, o rischiamo di metterci in casa dei robor che ci spaventano e verranno abbandonati come spesso succede con Alexa?
Il nome "uncanny valley" deriva dal grafico che rappresenta questa teoria: ci sono due assi, su quello orizzontale si misura la somiglianza con l’essere umano, su quello verticale la nostra risposta emotiva, dal calore dell’empatia al gelo del rifiuto. Il risultato? Una curva che sale, crolla vertiginosamente quando entriamo nella “valle” – il punto più perturbante, occupato non a caso da zombie e cadaveri – e risale solo quando la somiglianza diventa indistinguibile da un essere umano reale. Nel caso dei robot, per quanto siano sempre più realistici, questo non è ancora successo, anche se gli ingegneri da anni cercano di evitare l’uncanny valley senza che resti quel fastidioso brivido lungo la schiena.
Una nuova tecnica per cercare di superare l’uncanny valley
In questo senso sembra promettente il lavoro di un gruppo giapponese che ha pubblicato un paper in cui spiega la tecnica che hanno usato per rendere più credibili e naturali i movimenti facciali dei robot umanoidi. Al posto del metodo “patchwork” utilizzato fino a questo momento, hanno sviluppato un sistema che si basa su movimenti a onda. In pratica, invece di programmare i movimenti del viso come una lista di istruzioni fisse, hanno creato un sistema che genera dinamicamente i comandi per ogni parte del viso del robot. Questo sistema si basa su "onde decadenti", cioè segnali che si affievoliscono progressivamente nel tempo, e che sono combinati in modo da produrre espressioni fluide e realistiche.
La tecnica patchwork si basava su registrazioni di movimenti che venivano rimescolati e riutilizzati, come se si stessero incollando pezzi di un puzzle. Questo era un problema durante le transizioni, e lo sanno bene anche i tecnici che hanno lavorato al film tratto dal gioco Final Fantasy, che è stato un flop anche per questo motivo (oltre che per una scarsa aderenza al gioco, c’è da dire).
I movimenti nel metodo tradizionale vengono registrati creando delle sequenze predefinite, progettate manualmente da designer o basate su movimenti umani reali catturati tramite tecnologie di motion capture: l'individuo indossa una tuta speciale con dei marcatori, rilevati da telecamere o sensori che tracciano con precisione i movimenti dei muscoli. Quando si tratta di catturare espressioni facciali, si utilizzano telecamere ad alta risoluzione e piccoli marcatori sul viso, posizionati in punti chiave come le sopracciglia, le guance e le labbra.
Nel caso dei robot, questi movimenti venivano memorizzati e combinati per creare le espressioni, ma questa tecnica aveva grossi limiti: le transizioni tra le espressioni risultavano rigide e innaturali, perché non c'era una connessione fluida tra i movimenti, quindi era impossibile rappresentare stati emotivi complessi o cambiamenti graduali, perché il sistema poteva solo riprodurre ciò che era stato registrato in precedenza.
Rispetto alla robotica degli anni Settanta a cui faceva riferimento Mori, come dimostra anche il paper citato, sono stati fatti molti passi in avanti, ma non abbastanza da superare l’uncanny valley. A questo punto bisogna anche chiedersi non solo se sia un obiettivo realistico, ma auspicabile. Insomma, ha senso continuare a inseguire l’idea di un robot che sembri il nostro gemello metallico?
Ci servono davvero dei robot identici a noi?
Secondo Paolo Dario, docente emerito di biorobotica e ingegnere di fama internazionale, possono esserci varie controindicazioni: “Il robot ideale – spiega – dovrebbe ricordare il classico maggiordomo inglese, che sta quasi sempre zitto, ma anticipa i tuoi bisogni. Non deve sembrare intelligente, deve essere un esecutore: una macchina che sa aiutarti nei compiti quotidiani senza mai mettersi in competizione con te”. Una macchina di questo tipo sarebbe utile per semplificare i compiti quotidiani ed eviterebbe anche di sollevare i timori legati a robot troppo simili agli esseri umani o troppo intelligenti.
“Dobbiamo anche pensare – aggiunge Dario – che un robot con espressioni umane molto credibili può essere utilizzato per ingannare gli umani, e quindi quello che dobbiamo chiederci è se vogliamo introdurre nella società, e nella vita quotidiana, qualcosa che sia in grado di ingannarci. L’uncanny valley secondo me in questo senso ci ha già dato delle indicazioni molto chiare su quello che le persone vogliono veramente: perché dovremmo dividere la nostra quotidianità con una macchina che ci provoca disagio?”.
Chi produce robot di servizio, secondo Dario, non dovrebbe cercare di replicare l’essere umano, ma di costruire qualcosa in grado di supportarlo, lasciando alle persone il tempo per concentrarsi su ciò che li rende differenti dalle macchine.
Gli sviluppi più auspicabili, insomma, dovrebbero riguardare la coesistenza tra robot e umani, bilanciando innovazione e necessità pratiche e mantenendo un occhio vigile sulle implicazioni etiche e culturali. Naturalmente questo non esclude la ricerca, e lavori come quello citato possono essere estremamente interessanti per chi studia questa materia, ma più a livello teorico che pratico, altrimenti si rischia di finire come quando la Renault mise sul mercato la R11, la macchina parlante, che fu un discreto flop: gli ingegneri possono avere idee molto innovative, ma non è detto che queste idee vengano apprezzate anche da chi dovrà usare gli oggetti che hanno progettato.
Come suggerisce Dario, forse la vera domanda non è “Come supereremo l’uncanny valley?”, ma piuttosto “Abbiamo davvero bisogno di farlo?”. E non è una domanda retorica: tutto dipende dagli obiettivi per cui si decide di introdurre le macchine nella nostra quotidianità, sapendo che questa scelta porterà delle conseguenze.









