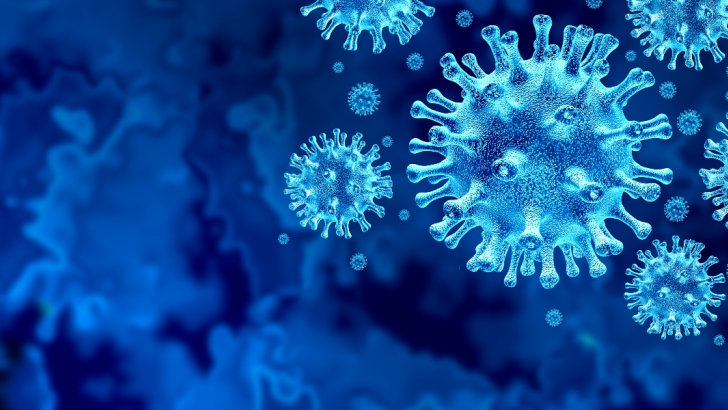Covid-19, fattori genetici ed immunologici in quasi il 15% dei casi gravi
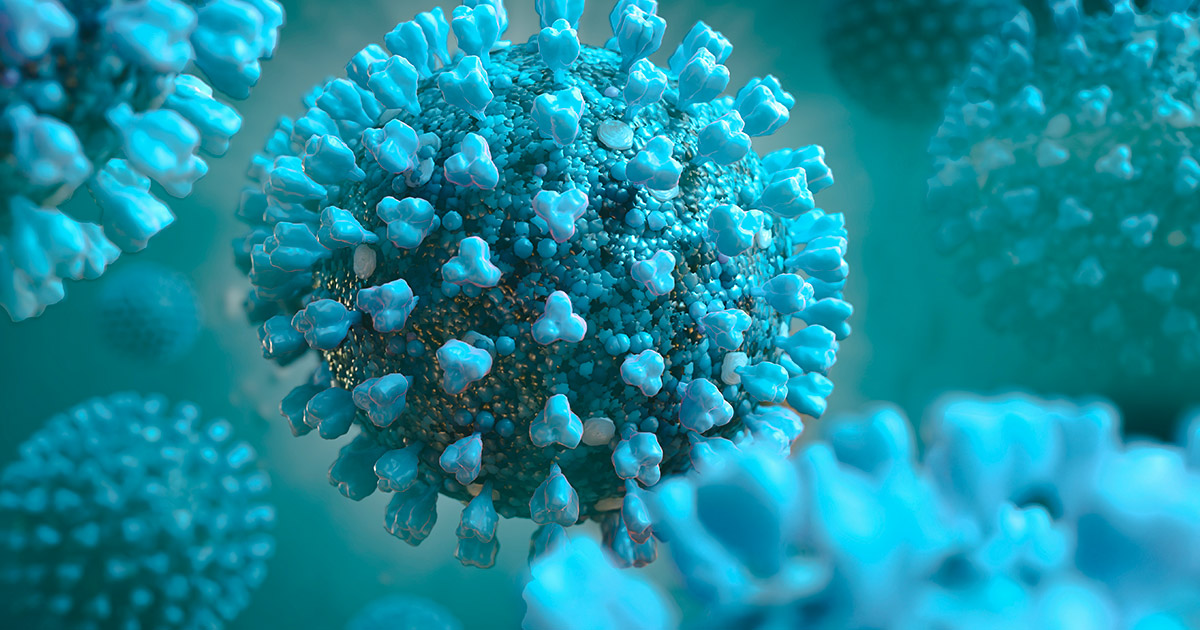
Davanti alla pandemia Covid-19 uno degli interrogativi a cui la ricerca ha provato sin da subito a dare una risposta riguarda l’estrema variabilità dell’infezione da virus SARS-CoV-2, tanto aggressiva verso alcuni pazienti, a volte anche giovani e senza comorbidità, quanto estremamente blanda in altre persone che, solo grazie ai test sierologici o al monitoraggio di tamponi ed esami salivari, scoprono di aver incontrato il patogeno.
Da tempo gli scienziati hanno capito che la risposta al virus è molto individuale e adesso, grazie ai risultati di due studi pubblicati su Science, si è arrivati a comprendere che questa variabilità è strettamente legata a fattori genetici e immunologici e che quasi il 15% delle forme gravi di Covid-19 dipende proprio da queste cause. I due studi fanno parte di un ampio progetto di ricerca condotto dal Consorzio internazionale di genetica Covidhge, una realtà che comprende oltre 50 centri di sequenziamento e centinaia di ospedali in tutto il mondo e al quale partecipa anche l’Italia, attraverso il Laboratorio di genetica medica dell’università di Roma Tor Vergata, l’Istituto San Raffaele di Milano, l’ospedale Bambino Gesù di Roma e l’Istituto di genetica e biofisica "A. Buzzati-Traverso" del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igb).
Two papers published online this week in Science, about hidden immune weakness in gravely ill #COVID19 patients, explain nearly 14% of severe cases of the disease—a “remarkable” development. @pulitzercenter https://t.co/dqzHqXbebM
— News from Science (@NewsfromScience) September 24, 2020
Entrambi gli studi, coordinati da Jean-Laurent Casanova, genetista di malattie infettive della Rockefeller University, hanno individuato nella ridotta funzionalità dell'interferone di tipo I, molecole proteiche che aiutano a regolare l'attività del sistema immunitario, il fattore chiave che può facilitare un'evoluzione severa della malattia. In circa il 10% dei pazienti sani in cui l'infezione evolve in forme gravi tutto ha origine da un comportamento errato degli anticorpi che vanno erroneamente ad attaccare l'interferone I al posto del virus, secondo meccanismi tipici delle malattie autoimmuni. In un altro 3,5% dei casi severi è invece un mutazione genetica a limitare la produzione dell'interferone I. Sono lavori complementari e che si rinforzano a vicenda perché entrambi sottolineano la relazione esistente tra una parte dei casi gravi di Covid-19 e il funzionamento anomalo, o l’assenza, del sistema di difesa costituito dagli interferoni.
In particolare, in uno studio gli scienziati del consorzio internazionale Covid Human Genetic Effort, hanno analizzato campioni di sangue di 987 pazienti gravemente malati di tutto il mondo e hanno scoperto che oltre il 10% di loro presentavano livelli elevati di auto-anticorpi che, invece di colpire il patogeno, andavano a bersagliare l'interferone I, impedendone l'azione antivirale. Questi anticorpi sono invece risultati scarsi nella popolazione generale, presentandosi solo nello 0,33% di oltre 1200 persone sane testate, e non sono stati rilevati in nessuna delle 663 persone con infezione lieve o asintomatica da SARS-CoV-2 che andavano a costituire il gruppo di controllo.
Alcuni ricercatori - precisa su Science Meredith Wadman in un articolo che raccoglie i primi commenti ai due studi da parte di immunologi di fama internazionale - avvertono che lo sviluppo di anticorpi che neutralizzano l'interferone potrebbe essere una conseguenza di forme gravi di Covid-19 e non la sua causa. Gli autori dello studio sottolineano però che in alcuni casi la presenza degli anticorpi è stata riscontrata anche in campioni di sangue antecedenti all'infezione e Jean-Laurent Casanova definisce improbabile che il corpo possa generare rapidamente gli alti livelli di auto-anticorpi rilevati dal suo team di ricerca. La coautrice Isabelle Meyts, immunologa pediatrica presso gli Ospedali universitari di Leuven in Belgio, parla di scoperta sorprendente perché "non c'è mai stata alcuna malattia infettiva spiegata a questo livello da un fattore nel corpo umano. E non è una coorte isolata di europei. I pazienti provengono da tutto il mondo, tutte le etnie", ha dichiarato a Science.
Another “tour de force” which will have gigantic impact on our approach to #COVID19 no doubt.
— Isabelle Meyts (@IsabelleMeyts) September 24, 2020
Congratulations to the team! https://t.co/T9vwDqg3QD
Un altro dato rilevante è racchiuso nel fatto che il 94% dei pazienti con anticorpi che attaccano l'interferone è risultato essere di sesso maschile e questo potrebbe aiutare anche a spiegare perché gli uomini corrono un rischio maggiore di sviluppare forme severe di Covid-19.
Lo studio su forme gravi di Covid-19 e meccanismi immunologici
Abbiamo approfondito i risultati di questo studio insieme al professor Lorenzo Piemonti, direttore del Diabetes Research Institute del San Raffaele e docente di Endocrinologia all'università Vita-Salute San Raffaele, tra gli autori della ricerca che si è concentrata sullo studio dei processi immunologici che rendono meno efficace la risposta al virus SARS-CoV-2 e possono favorire un decorso grave dell'infezione. "Se noi riusciamo a capire i meccanismi con cui il virus sviluppa la sua sindrome clinica si possono trovare dei farmaci che siano specifici e non più mutuati dal trattamento di altre patologie", ci ha spiegato il professor Piemonti che ha aggiunto come sia già in corso anche un trial clinico incentrato sull'utilizzo degli interferoni per potenziare la risposta immunologica nei pazienti che ne hanno bisogno.
L'intervista completa al professor Lorenzo Piemonti tra gli autori dello studio pubblicato su Science che ha indagato i fattori immunologici che possono essere alla base di oltre il 10% dei casi gravi di Covid-19. Servizio e montaggio di Barbara Paknazar
"Il tema della risposta individuale a SARS-CoV-2 è, accanto alla ricerca di soluzioni come il vaccino, un elemento davvero centrale nella gestione di questa malattia. Questa variabilità - introduce il professor Lorenzo Piemonti - può essere legata a tanti fattori che si possono raggruppare in tre grandi categorie. Una riguarda il virus stesso, se cambia e se acquisisce o perde competenze di un certo tipo. La seconda è la capacità di trasmissione collegata all’ambiente e quindi ad esempio le condizioni di temperatura e umidità, il fatto di essere al chiuso o all’esterno, la presenza di inquinamento atmosferico. Il terzo fattore è l’ospite e i nostri studi si sono concentrati proprio su questo. Noi già all’inizio dell’epidemia abbiamo capito che ci sono delle caratteristiche dell’ospite, grossolanamente definibili come cliniche, come l’età, il sesso o la presenza di comorbidità, che potevano essere associate ad un andamento diverso della malattia. Ormai ci sono degli algoritmi che vengono utilizzati proprio per stratificare il rischio da questo punto di vista. Adesso sta arrivando una seconda ondata di informazioni che hanno richiesto più tempo per essere indagate perché sono più complesse nella loro origine e nella modalità di studio: si tratta dell’analisi approfondita della risposta del nostro sistema immunitario al virus. Questa risposta è condizionata da molti fattori tra cui la nostra identità a livello genetico e la storia, non necessariamente genetica, che abbiamo acquisito a livello immunologico durante la nostra vita. Mi riferisco ad esempio allo sviluppo di auto-immunità, disregolazioni del sistema immunitario che possono comportare dei difetti nella capacità di risposta davanti a un’infezione come SARS-CoV-2. Negli studi pubblicati su Science sono emerse queste due caratteristiche: da una parte il fatto che esistano dei geni che regolano un sistema come quello degli interferoni, che è molto importante e funziona come una sorta di direttore di orchestra che condiziona la risposta al virus e quando non è adeguata permette al virus di svilupparsi in una forma molto più severa. Dall’altra parte abbiamo rilevato anche la presenza alcune forme di autoimmunità ed è un meccanismo molto curioso dove si vanno a sviluppare degli anticorpi contro le citochine o dei mediatori dell’immunità stessa, come nel caso degli anti interferoni".
I risultati di questi lavori di ricerca - ci spiega il professor Piemonti - sono il frutto dell'impegno di un Consorzio, con oltre 60 istituzioni che si sono messe in rete per cercare di dare delle risposte grazie a un tipo di collaborazione che consente di studiare in maniera sistematica tanti casi. "E’ un modo con cui la scienza sa rispondere e mettere a disposizione della medicina e della società la sua expertise per risolvere questo problema. La nostra partecipazione allo studio è nata, da un certo punto di vista, in modo un po’ indipendente in quanto noi avevamo osservato la presenza di questi anticorpi in una casistica relativa al nostro Istituto e abbiamo incrociato la stessa informazione che veniva rilevata dal primo autore del lavoro, Paul Bastard della Rockfeller University. L’idea è stata quella di mettere insieme questi dati e la costituzione del consorzio Covidhge ha permesso di coinvolgere molti centri italiani ed esteri che hanno messo insieme il materiale biologico disponibile per suffragare questo tipo di ipotesi. Abbiamo così raggiunto dei numeri tali che ci consentono di affermare che circa il 10% delle persone che sviluppano forme gravi di Covid-19 presentano questa autoimmunità, cioè anticorpi che inibiscono la risposta contro il virus perché neutralizzano l’attività degli interferoni".
Un risultato che a livello di conseguenze pratiche apre la strada a due possibilità. "Le persone che hanno questi anticorpi - entra nel dettaglio il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele - potrebbero essere inserite all’interno di terapie più aggressive contro il virus oppure si potrebbero trattare questi pazienti con degli interferoni, quindi con la molecola che manca, e vedere se in questo modo si riesce a superare il deficit. Nel nostro Istituto c’è anche un trial in corso che è nato prima della pubblicazione perché avevamo già ipotizzato in precedenza di utilizzare gli interferoni per potenziare la risposta immunologica nei pazienti che ne hanno bisogno e vedremo nel tempo se i risultati ci daranno ulteriore supporto. L’altro aspetto che vorrei sottolineare è l’avanzamento dei nostri studi sulla patogenesi: oggi abbiamo tecniche, sia nella genetica che nella capacità di studiare le proteine o l’RNA, che permettono di approfondire questi meccanismi in modo estremamente profondo. Se noi riusciamo a capire i meccanismi con cui il virus sviluppa la sua sindrome clinica si possono trovare dei farmaci che siano specifici e non più mutuati da altre condizioni".
L'analisi di un campione di controllo composto da oltre 1200 individui sani ha valutato che questi auto-anticorpi sono presenti solo nello 0,33% della popolazione generale, con una prevalenza quindi di 15 volte inferiore a quella osservata nei pazienti con forme gravi di Covid-19. Questi risultati suggeriscono che la popolazione generale potrebbe essere sottoposta a screening per questi anticorpi. E dallo studio è emerso in modo estremamente chiaro che sono soprattutto gli uomini a sviluppare anticorpi diretti contro il sistema immunitario. "Il dato più impressionante - afferma il professor Lorenzo Piemonti - è che il 90% di questi soggetti è di sesso maschile e questo potrebbe spiegare perché la forma più grave di Covid-19 sia più presente tra gli uomini. Qui si aprono alcune domande e ci si chiede se la parte del nostro genoma che determina il sesso possa in qualche modo contribuire allo sviluppo di questi anticorpi. A questo interrogativo saranno dedicati ulteriori studi nei prossimi mesi. Però quello che ha colpito di più chi come noi studia l’autoimmunità è che alcuni soggetti apparentemente non avevano sviluppato una malattia evidente di tipo autoimmune: gli anticorpi contro gli interferoni di solito li ritroviamo in sindromi molto particolari e rare che determinano la presenza di alcune malattie autoimmuni, spesso associate tra di loro. In questo caso, invece, i pazienti non presentavano i tipici segni di queste malattie autoimmuni ed è come se esistesse una popolazione in cui questo tipo di difetto non si manifesta in condizioni normali, se non in qualche caso, ma si presenta quando il sistema immunitario viene forzato dall’infezione virale e questo toglie dalla latenza il deficit. Anche questo sara oggetto di ulteriori ricerche".
Abbiamo poi chiesto al professor Piemonti perché i pazienti diabetici corrono rischi maggiori davanti all'infezione da SARS-CoV-2. "Abbiamo studiato l’impatto che il diabete ha sulla gravità della malattia e siamo arrivati alla conclusione che il paziente con diabete ha un rischio di morte che è due o tre volte superiore rispetto alla persona non diabetica in caso di infezione da SARS-CoV-2. Sulla base di quanto abbiamo capito finora il motivo è prevalentemente legato ai valori alti di glicemia. La ragione per la quale avere una glicemia alta predispone ad una forma più aggressiva di malattia è materia di studio e discussione. Esistono dei dati, soprattutto in vitro e nei modelli, che dicono che alti livelli di glucosio predispongono ad una risposta infiammatoria maggiore e questo potrebbe essere uno dei meccanismi importanti per determinare la gravità della malattia. L’infezione da SARS-CoV-2 ha delle componenti diverse che si vengono a sovrapporre: esiste cioè un danno diretto, che è dovuto al fatto che le cellule, spesso quelle cellule dell’epitelio delle vie respiratorie, vengono colonizzate dal virus e muoiono. Ma c’è anche un danno riflesso che è legato all’innesco di una cascata infiammatoria massiva e in alcuni soggetti le complicazioni più gravi sono date proprio dall’eccesso di questa risposta". Le buone notizie, rileva il direttore del Diabetes Research Institute del San Raffaele sono che "tenendo sotto controllo la glicemia questo rischio aggiuntivo associato alla malattia tende a ridursi" e che "nel caso di pazienti giovani, ad esempio bambini con diabete di tipo 1, non è stato rilevato alcun rischio aggiuntivo e quindi possiamo tranquillizzare le famiglie da questo punto di vista". "Con l’aumentare dell’età - precisa però Lorenzo Piemonti - il rischio diventa crescente, sia nelle persone con diabete di tipo 1 sia nei soggetti con diabete di tipo 2. E sicuramente un paziente sopra ai 65 anni con diabete deve avere un’attenzione particolare: non ha maggiori probabilità di infettarsi, ma qualora dovesse accadere corre maggiormente il rischio di incorrere in una forma severa".
E grazie a un approccio innovativo solitamente usato per lo studio dell’autoimmunità nel diabete di tipo 1, un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha mappato la risposta anticorpale di 509 pazienti con Covid-19 ricoverati presso l’Istituto e ha identificato una classe di anticorpi molto efficaci nel combattere l’infezione: la presenza di questi anticorpi nel sangue è associata a una riduzione della mortalità di oltre il 60%. La ricerca, pubblicata sul Journal of Clinical Investigation, ha portato alla scoperta che gli anticorpi più efficaci sono quelli che riconoscono una regione relativamente piccola della proteina Spike, la proteina che permette al virus di agganciarsi alle cellule ed infettarle. Oltre a rilevare gli anticorpi per SARS-CoV-2, i ricercatori del San Raffaele hanno testato il siero dei 509 pazienti anche per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi contro altri virus, in particolare quelli dell’influenza stagionale e altri coronavirus più comuni, i responsabili dei raffreddori stagionali. "Abbiamo potuto verificare - afferma il professor che, in caso di infezione da SARS-CoV-2, si riaccende anche la memoria contro gli altri Betacoronavirus incontrati in precedenza". Si tratta quindi di una conferma agli studi supportano l'esistenza di una cross-reattività e che suggeriscono un ruolo importante delle precedenti infezioni da coronavirus nella risposta contro SARS-Cov-2. Per quanto riguarda infine l'impatto del nuovo coronavirus su persone che avevano contratto già in un recente passato il virus influenzale è emerso che "avere avuto una recente infezione da virus dell’influenza non sembra peggiorare le probabilità di guarigione in caso di COVID-19" ma, chiarisce Piemonti, "questo non vuol dire che non si debba fare il vaccino antinfluenzale. I vantaggi sono elevati e vanno oltre al discorso della protezione perché si estendono alla facilitazione dei sistemi diagnostici".
Lo studio su forme gravi di Covid-19 e fattori genetici
Il secondo studio ha invece sequenziato il DNA da 659 pazienti Covid-19 in condizioni critiche e da 534 soggetti con malattia lieve o asintomatica. I ricercatori hanno esaminato 13 geni, scelti perché i loro difetti compromettono la produzione o l'uso dell'interferone di tipo I e hanno scoperto che nel 3,5% dei pazienti in cui la malattia aveva avuto un decorso grave otto di quei geni presentavano mutazioni rare, responsabili della minore produzione dell'interferone I. All'interno del gruppo di controllo non è invece stata riscontrata nessuna mutazione. Un risultato che conferma la solidità del progetto di ricerca.
L'indagine dei meccanismi patogenetici del Covid-19 è fondamentale, spiega il professor Giuseppe Novelli, responsabile dei laboratori di Genetica medica dell'università Roma Tor Vergata, "perché apre la strada allo screening dei pazienti ad alto rischio e alla terapia personalizzata, pensiamo ad esempio all'impiego di interferone e alla plasmaferesi per eliminare gli anticorpi tossici che una parte dei pazienti sviluppa e che aggravano i sintomi".
Il professor Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di Genetica medica dell'università Roma Tor Vergata parla dello che ha indagato i fattori genetici alla base di alcune forme gravi di Covid-19. Servizio e montaggio di Barbara Paknazar
"L’elemento centrale - afferma il professor Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di Genetica medica dell'università di Roma Tor Vergata - è capire quali caratteristiche dell’ospite condizionano la risposta al virus perché, come sappiamo, spaziamo da forme asintomatiche a intermedie fino a un decorso gravissimo, ma ci sono anche forme addirittura inesistenti, cioè persone che pur essendo esposte non contraggono il virus. Noi a partire da marzo abbiamo iniziamo a studiare per cercare di capire quali potessero essere le basi genetiche di questa grande variabilità di risposta e finalmente siamo arrivati ad alcune conclusioni. Sequenziando tutto il genoma di queste persone in cui Covid-19 aveva sviluppato sintomi gravi, ben selezionate per fenotipo, abbiamo potuto scoprire che il 3,5% dei pazienti presentava delle mutazioni a livello di geni importanti, quelli che hanno a che fare con la produzione e con il funzionamento di tutta la catena legata agli interferoni. Sappiamo bene che in tutte le malattie infettive, batteriche e virali, la prima linea di difesa sono proprio gli interferoni perché fanno parte di quella che viene definita immunità innata e che sono fondamentali perché attivano una catena di risposte che porta all’eliminazione dell’invasore. Dal nostro studio abbiamo quindi scoperto che il 3,5% di persone in condizioni critiche a causa di Covid-19 era invece privo di questa risposta immediata che consente di distruggere o rallentare l’azione del virus. Questo ci suggerisce di impiegare gli interferoni in un percorso terapeutico per i pazienti che sono privi di queste molecole".
"Il secondo studio - prosegue Novelli - è collegato e ci dice che esiste un altro 10% di persone che si ammala gravemente e che non ha un difetto genetico nella produzione o nel recepire l’interferone, ma addirittura produce anticorpi contro gli stessi interferoni. Al momento ancora non sappiamo perché queste persone producono auto anticorpi: in passato avevamo scoperto che ci sono dei casi rari di persone che hanno difetti genetici e producono anticorpi contro gli interferoni ma sono malattie rarissime e infatti nel nostro studio questi casi non sono più di tre, cioè una minima parte di questo 10%. Per questi pazienti la situazione è diversa perché non possiamo pensare di utilizzare farmaci a base di interferoni in quanto si scatenerebbe una risposta infiammatoria anche grave. E al riguardo, proprio in questi giorni è iniziata una discussione all’interno del Consorzio, con i 250 laboratori di tutto il mondo che ne fanno parte, per valutare un possibile protocollo clinico. Un’idea che abbiamo è quella della plasmaferesi che ci consentirebbe di eliminare questi auto anticorpi. Serve però un protocollo approvato e sperimentato".
Sarà adesso importante capire quali sono le cause all'origine dei meccanismi autoimmunitari. "Noi sappiamo che alcune malattie come la sclerosi multipla o il lupus sono legate alla produzione degli auto anticorpi, che sono appunto alla base delle malattie auto immuni, ed è stato anche visto che il bersaglio possono essere anche gli interferoni. Occorre capire perché vengono prodotti questi auto anticorpi ed è chiaro che ci sono motivi genetici alla base. Io penso che una dellle prime cose da fare sia studiare bene i geni dell’HLA, antigene leucocitario umano, in questi soggetti e vedere se c’è qualcosa che simula o confonde il proprio dal non proprio", spiega il direttore del laboratorio di Genetica medica dell'università di Roma Tor Vergata.
"Oggi - conclude il professor Giuseppe Novelli - puoi arrivare a questi risultati sono attraverso uno studio multicentrico perché servono grandi numeri ed è necessario mettere insieme casistiche diverse ma ben selezionate. Il Covidhge sta dando questi risultati perché ha un team di genetisti ed immunologi molto bravi ed è coordinato da Jean-Laurent Casanova che ha una solida esperienza e lavora alla Rockfeller University da cui, come sappiamo, proviene anche uno dei vincitori del Premio Nobel per la scoperta del virus dell’epatite. Questo Consorzio è nato a febbraio e tra quelli di cui faccio parte è uno dei più attivi: ci colleghiamo settimanalmente in rete e discutiamo dei risultati che ognuno di noi sta ottenendo nei rispettivi laboratori e poi li condividiamo dopo aver firmato accordi di privacy e segretezza. Tutto questo è fondamentale per supportare gli studi di una elevata significatività statistica".