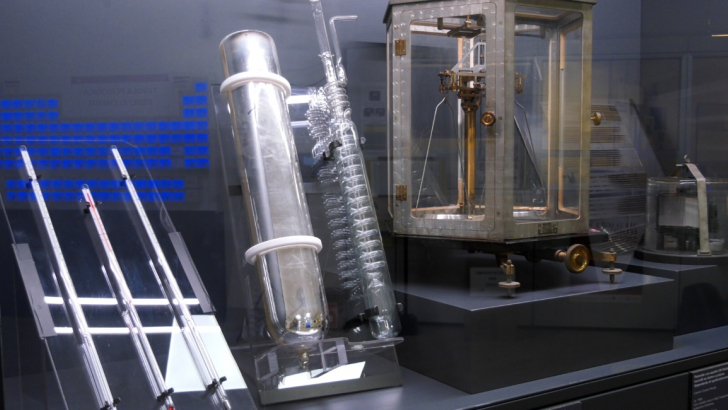Quando Padova aprì le sue aule agli ebrei

Particolare del diploma di laurea di Samuele Coen, 1702. Centro per la storia dell’Università di Padova, Raccolta diplomi, n. 33.
C’è stato un tempo in cui Padova era l’unico luogo in Europa dove un giovane poteva coronare gli studi universitari a prescindere dalla propria confessione o fede religiosa. Nell’ambito della politica pragmatica della Serenissima l’ateneo patavino aveva infatti escogitato un sistema che permetteva anche a studenti protestanti, ortodossi ed ebrei di conseguire l’agognato titolo di studio senza incorrere nella censura della Chiesa romana. Una storia in parte già nota, ma che riemerge con forza e nuovi dettagli dalle pagine del volume Ebrei, Medicina e Università di Padova, curato da Edward Reichman e Fabio Zampieri per i tipi della Padova University Press, con il contributo del Centro per la storia dell'Università di Padova.
Il libro trae origine da una mostra sui diplomi di laurea degli studenti ebrei tenutasi nel 2022 presso il Museo della Padova Ebraica, in seguito arricchitasi di un ciclo di conferenze: il risultato è un’opera corale “che intreccia tre grandi storie: quelle del’ebraismo, della medicina e dell’Università di Padova”, ha spiegato durante la presentazione del volume Dennj Solera (Università di Siena). “L’ateneo padovano non si limitava a laureare studenti ebrei, ma adottava una serie di accortezze per farli sentire a loro agio, in un contesto europeo che spesso andava nella direzione opposta”.
Stratagemmi e diplomi “neutri”, segni di un liberalismo pragmatico
A Padova infatti, come ricorda lo storico della medicina Fabio Zampieri nell’introduzione del volume, venne sviluppata una soluzione elegante per aggirare la bolla papale In Sacrosancta, emanata da Pio IV nel 1564, che imponeva la professione scritta di fede cattolica come requisito per accedere ai titoli accademici. La formula prevedeva che la laurea venisse conferita non in una cerimonia alla presenza del vescovo che richiamava le liturgie cattoliche, ma da autorità esterne: i conti palatini in quanto emissari dell’imperatore – titolo che fu assegnato anche ad ebrei, che poterono così laureare dei correligionari – e in seguito a partire dal Seicento il cosiddetto Collegio Veneto, espressione diretta della sovranità della Serenissima. Un modo per aggirare i vincoli mantenendo l’essenza e il prestigio del titolo.
“ C’è stato un tempo in cui Padova era l’unico luogo in Europa dove un giovane ebreo poteva laurearsi senza rinunciare ufficialmente alla propria fede
I diplomi rilasciati agli studenti ebrei erano inoltre redatti con cura particolare: scomparivano ad esempio i riferimenti espliciti alla Trinità, la formula “In Christi nomine” veniva sostituita da “In Dei nomine” e le date non riportavano più “Anno Domini”, ma espressioni neutre come “currente anno”. In un caso, quello del medico Leo Cantarini, laureato nel 1623, il diploma lo cita persino con l’appellativo Rabbi: un riconoscimento straordinario per l’epoca, come sottolinea il medico e storico della medicina americano Edward Reichman, che ha individuato e studiato molti questi documenti dispersi negli archivi di mezzo mondo. “Questi slittamenti minimi ma significativi nei diplomi sono il segno di una tolleranza notevole negli anni in cui in Europa si istituzionalizzano i ghetti”, osserva Solera.
La tolleranza padovana non nasceva tanto da un sentimento di libertà religiosa, quanto da motivi molto pratici: gli studenti stranieri – e quelli ebrei in particolare – rappresentavano infatti una fonte di prestigio per la città e per la Repubblica di Venezia, oltre che di un certo indotto economico. Lo stesso regno d’Inghilterra, secondo quanto riferisce Solera, si rivolgeva all’ateneo patavino per formare i propri medici: Elisabetta I scrisse al doge per chiedere l’invio di dottori, in particolare ebrei, perché quelli di Padova erano considerati i migliori d’Europa. Alcune famiglie ebraiche inviarono a Padova generazioni intere di studenti: i Luzzatto di San Daniele in Friuli contarono per esempio sedici laureati in due secoli, un dato non comune nemmeno nelle casate cattoliche più prestigiose. Galileo Galilei, docente a Padova, presenziò personalmente a pochissime cerimonie di laurea: una di queste fu di uno studente ebreo.
Leggi anche: Medicina a Padova nei secoli: gli ebrei e l'università
Dall’emancipazione alle leggi razziali
Nel XIX secolo, con il pieno riconoscimento dei diritti civili e religiosi, la presenza ebraica all’Università e nella città di Padova divenne ancora più fitta e attiva: non si trattava più solo di studenti, italiani o stranieri, ma di una classe dirigente ebraica italiana di altissimo livello culturale. Nomi come quelli dei rettori Emilio Morpurgo e Vittorio Polacco, oltre a quelli di Luigi Luzzatti, Donato Donati, Tullio Levi Civita, Bruno Rossi e Tullio Terni segnarono la storia dell’ateneo e del Paese, così come quello di Leone Wollemborg, fondatore della prima cassa rurale in Italia; gli ebrei padovani ricoprirono incarichi pubblici, partecipando attivamente alla vita politica e civile.
La Prima guerra mondiale vide una forte partecipazione degli studenti ebrei, per molti aspetti “più italiani degli italiani”, come evidenzia la storica Rosanna Supino in una delle sezioni del volume. Paradossalmente, pochi anni dopo quello stesso Stato avrebbe emanato le leggi razziali.
“ I diplomi “neutri” degli studenti ebrei raccontano una storia di convivenza, interrotta dalla violenza delle leggi razziali
Il legame plurisecolare fra comunità ebraica e Università di Padova venne spezzato infatti nel 1938. Come ricostruisce Giulia Simone, che del tema si occupa da diversi anni, a Padova le leggi razziali furono applicate con particolare zelo. Il 9 agosto arrivò la circolare ministeriale di Bottai che ordinava il censimento di tutti gli ebrei. Il rettore Carlo Anti si mosse rapidamente: furono colpite subito le posizioni più fragili – precari ed emeriti – e poi via via il personale e gli studenti. Padova, un tempo esempio di apertura, divenne barbaramente efficiente nell’emarginare, spiega Simone. Oltre 800 persone furono censite, 51 allontanate dall’ateneo.
Tra i casi più tragici quello di Tullio Terni, del quale si occupa il saggio di Gaetano Thiene. Anatomista di fama internazionale e vincitore di un prestigioso finanziamento Rockefeller, fu doppiamente epurato: prima dal regime fascista e poi dopo la fine della guerra dal mondo scientifico, che prese a pretesto la sua iscrizione al partito fascista per rifiutargli la riammissione nell’Accademia dei Lincei. Il 25 aprile 1946, a un anno dalla Liberazione, Terni si tolse la vita con una fiala di cianuro.
Leggi anche: Shoah, sei pietre davanti all'ateneo per non dimenticare l'orrore
Riflettere sulle luci e sulle ombre
“Ebrei, Medicina e Università di Padova è un libro che ha il coraggio di guardare la storia in faccia, con luci ma anche con ombre”, ha detto durante la presentazione Alberto Zanatta (Università di Padova), sottolineando la ricchezza di dettagli e aneddoti raccolti nel volume.
A distanza di secoli, queste storie ci restituiscono un’immagine complessa: una Padova straordinariamente aperta e insieme drammaticamente vulnerabile alla violenza politica. Una città che, nei secoli, ha saputo accogliere e valorizzare intelligenze “altre”, ma che nel Novecento ha ceduto alla logica dell’esclusione.
“Fare cultura significa contrastare la violenza e tenere alta la speranza”, ha ricordato Marta Nezzo. Riscoprire la storia degli studenti ebrei di medicina a Padova non è solo un esercizio erudito: è un modo per capire chi siamo stati e chi vogliamo essere, come università e come società.

Un altro particolare del diploma di Samuele Coen