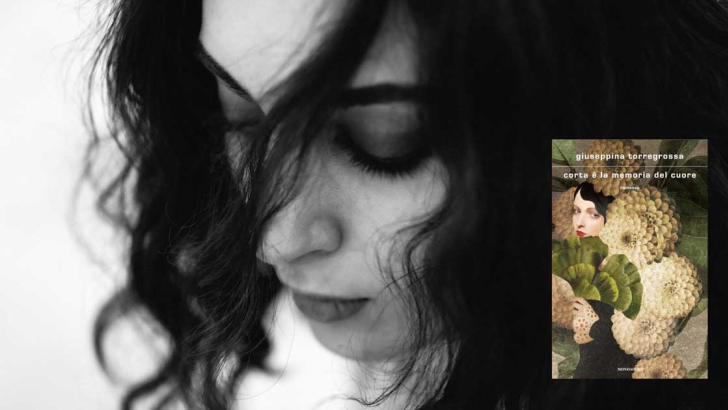La parola femminista, una disamina di Vanessa Roghi

Certe volte i libri servono per mettere ordine. Per interrompere il flusso della vita e attivare quello della coscienza. Servono cioè a riflettere, a prendere la giusta distanza e a permettere di ricostruire un fenomeno, che – di contro – sarebbe solo vissuto, e, per come fa la vita, vissuto anche con una certa dose di caos. La distanza che serve al saggista (ma anche al lettore che quel certo libro lo fa suo) non è quella che il romanziere ricerca quando sulla pagina riporta la trasfigurazione di fatti a lui realmente accaduti, anzi. Può addirittura stare completamente immerso nell’esperienza personale, che diventa sociale se non addirittura politica: il gesto della distanza si manifesta nella libertà della mente di ricostruire un senso. Si manifesta nel gesto della scrittura. Anche solo a partire dalla cronologia: in fondo la storia non la comprendiamo forse a partire dal disporre sulla linea del tempo i fatti realmente accaduti?
È questo ciò che fa Vanessa Roghi nel suo saggio per Mondadori La parola femminista in cui l’autrice guarda all'evoluzione del termine e al suo periodo di oblio, e, partendo dalla sua esperienza di donna (di ragazza e di bambina), unita a quella di molte altre donne intervistate, e vagliandola con l’occhio della studiosa avvezza, traccia uno skyline.
Che è fatto prevalentemente di ossimori.
Dopo anni di lotte, “nel 1987 Fiorella Mannoia partecipò a Sanremo con Quello che le donne non dicono: un addio definitivo alla parola femminista. Erano finiti i tempi di “l’utero è mio e me lo gestisco io”; ora le donne cantavano di essere complicate da sempre, sempre lì, in attesa di un maschio, uomo, capitano, a corteggiarle, a fischiare dalle automobili, a portare loro le rose e semmai a mandarle”. Quante volte l’abbiamo cantata, questa canzone, senza renderci conto del suo portato?
Altre manifestazioni invece ci sono apparse, e ci appaiono, evidentemente in antitesi a un pensiero sensibile alla posizione che le donne hanno e vorrebbero avere e in qualche modo ci scandalizzano: “In pochi anni l’orizzonte pubblico ha smesso di usare la parola femminista, se non come parola di scherno, e sono arrivati programmi come Non è la rai a ricordarci il nostro posto nel mondo e in TV: a bordo piscina o seminude sui pattini, ma solo se carine, le altre tra il pubblico, a guardare o a piangere”. Eppure il fenomeno è più ampio e ascrivibile a un cambiamento sociale che non si concentra necessariamente e solo sulla polarizzazione legata al genere. Scrive Roghi, parecchie pagine dopo: “Non è la rai non vince in alcun modo il primo premio della classifica della cosiddetta “TV spazzatura”, perché facendo un giro nella programmazione televisiva degli anni a seguire c’è poco da ridere: è la TV del dolore a occupare quasi ogni spazio. Si piange sempre, al telefono, in studio. I volti fintamente costernati, dispiaciuti, di presentatori e presentatrici la cui ragione di esistere consiste in quella faccia da mostrare di fonte a una tragedia è la cifra dominante”.
Roghi, in questo saggio, fa così. Ci racconta il nostro mondo – quello che è stato, quello che è adesso e la direzione che mostra di aver intrapreso – senza leggerlo in un’ottica necessariamente femminista ma ne delinea le tendenze, che sono indipendenti dalla lente con cui si osservano accadimenti e nessi causali. Il punto di vista, però, resta sempre una questione chiave e lo sottolinea: “Il femminismo, tra le altre cose, ci ha insegnato anche questo: a rivendicare le ferite, il punto di vista da cui si guarda, da cui si parla. La non neutralità di ogni discorso, anche del discorso storico”.
Ecco quindi che l’oggetto della riflessione femminista altro non è che affare di tutti, non delle femministe o delle pensatrici femministe o delle scrittrici femministe, perché, per esempio, l’effetto che ha avuto Candy Candy sulla formazione dell’individualità delle bambine degli anni Settanta e Ottanta non è trascurabile, anche per chi si disinteressa o non si sente rappresentato dal femminismo; o perché “al di là della polemica spiccia contro quello che viene considerato un eccesso del “politicamente corretto” [a proposito del catcalling] rimane, più serio, il problema del riconoscere le molestie o persino la violenza quando la si incontra”.
Al contempo Roghi ci mostra come una certa vulgata della disamina dell’affermazione femminile produca dei falsi miti, letti come tappe di emancipazione, ma che non sono altro che frutto di processi economici, per esempio. “Potremmo discutere, ma c’è già chi lo fa egregiamente, di una “brandizzazione” insopportabile […] Abbiamo centinaia di pubblicazioni sull’empowerment delle ragazze, sulle bambine ribelli, sulle donne che hanno fatto la differenza. Forse è il caso di discutere sull’efficacia di molte di queste pubblicazioni, a partire dal tipo di femminismo che incarnano, che, senza dubbio non ritengo interessante, anzi, spesso sinceramente dannoso”.
Perché di femminismo non ce n’è uno solo, da sempre. E, negli anni, ne sono nati altri, dando nuova voce alla parola femminismo. Leggendo il saggio di Roghi li si incontra tutti, con le relative testimonianze, che sono diventate pietre miliari della storia di questo tentativo di guardare al mondo: dal Manifesto di rivolta femminile del 1970 di Carla Lonzi, Carla Accardi ed Elvira Banotti in cui la rivendicazione dell’uguaglianza diviene la rivendicazione della differenza (“La donna è altro rispetto all’uomo. L’uomo è altro rispetto alla donna. L’uguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna a più alti livelli”) al celeberrimo Dalla parte delle bambine di Elena Gianini Belotti cui fa da controcanto il più recente Ancora dalla parte delle bambine di Loredana Lipperini, ai testi di Michela Murgia e di Vera Gheno, solo per citarne una minima parte.
I nodi cruciali non sono cambiati: l’educazione, il rapporto con il corpo e la sua oggettivazione, i diritti fondamentali – dalla maternità all’aborto –, la posizione della donna in un mondo che ha digerito il patriarcato come unico modello possibile. Sembra incredibile che Francesco Alberoni nel 1984 scrivesse incontestato: “Ogni donna ha cercato di essere più attraente per farsi scegliere dall’uomo più potente. […] I maschi, parallelamente, hanno sviluppato qualità come l’ostentazione del loro coraggio e della loro forza. Hanno preso a carico le donne ed i figli, e si sono sentiti responsabili del loro benessere”, eppure c’è chi lo crede un meccanismo biologico.
Vanessa Roghi inserisce la sua riflessione tessendo la tela della complessità, dello sguardo corale e individuale, della disamina sociale e sociologica che infine si dimostra politica. Chi scrive la ringrazia, indipendentemente da che fine farà la parola femminista.
“ Il femminismo, tra le altre cose, ci ha insegnato anche questo: a rivendicare le ferite, il punto di vista da cui si guarda, da cui si parla. La non neutralità di ogni discorso, anche del discorso storico Vanessa Roghi
L'intervista a Vanessa Roghi, autrice de La parola femminista
Analizzi, nel saggio, cos’è stato e cos’è il femminismo a partire dal fatto che “ci siamo persi per strada la parola femminista”. Ed effettivamente solo una parte delle donne oggi si riconosce in quel movimento, nonostante le istanze femministe siano universali. Perché accade? Cosa c’è di allontanante nella parola femminista?
La parola femminista non è mai stata una parola nella quale si riconoscevano la maggior parte delle donne, nemmeno nel momento in cui il movimento femminista ha riempito le piazze: mi riferisco alla metà degli anni Settanta. È sempre stato un movimento, quello femminista, che pur prendendo la parola in nome di tutte le donne ha dovuto combattere le paure, i pregiudizi, la diffidenza di quelle donne che sentivano messe in pericolo consuetudini, comfort zone, o, semplicemente, una cultura troppo lontana da quella rappresentata dal separatismo per esempio. Infatti molte donne impegnate in politica, anche in partiti di sinistra, storicamente più vicini a certe battaglie, non necessariamente si dicevano femministe. Penso per esempio a Rossana Rossanda, forse, fra le donne della sua generazione, quella che ha fatto il percorso più interessante “verso” le altre, spesso più giovani, che ponevano temi per lei inediti come quello del corpo.
Oggi i femminismi sono per fortuna tornati a riempire le piazze e tante sono le voci che nel dibattito pubblico portano istanze che possiamo ascrivere all’universo femminista. Sono femminismi non sempre d’accordo fra di loro, ma del resto era così anche negli anni Settanta e Ottanta. Con una differenza sostanziale però: intorno non ci sono movimenti politici “amici”, ma in gran parte nemici. E una diffidenza cresciuta in modo esponenziale, insieme a un uso disinvolto della parola per cui anche in contesti reazionari ci si dice femministe. Insomma una bella confusione.
Non è possibile, vista l’ampiezza del tema, discutere qui di quanto pesino, rispettivamente e proporzionalmente, nella formazione dell’individuo, ciò che è innato e ciò che è appreso; ma immaginando che ciascuno sia comunque figlio di una Weltangschauung, in che modo possiamo guardare alle diverse generazioni di donne (tu ne hai intervistate, nel saggio, alcune per ciascuna) le quali, ognuna a suo modo e con i propri strumenti, hanno reagito (e tuttora lo fanno) a un mondo che, comunque lo si guardi, confina l’essere donna dentro degli stereotipi? Mi spiego meglio: chi ha avuto come modello Candy Candy o da adolescente guardava “Non è la rai” ha davvero un approccio e dei retaggi diversi da chi, per esempio, è cresciuta in tempi di campagne contro il body shaming, più recenti?
Senza dubbio diversa è la cassetta degli attrezzi che ogni generazione ha per reagire alle stesse cose, perché identici sono gli ostacoli che la società patriarcale pone alle donne: segregazione formativa, lavorativa, familiare, molestie, violenze, e così via. Se io da ragazzina avevo ben pochi strumenti culturali per reagire alla molestia, oggi le ragazze vivono in un mondo in cui se ne parla di più e non è più universalmente accettata come qualcosa di inevitabile che prima o poi succede a ogni donna. Io mi sono sempre sentita impotente di fronte al body shaming, per esempio. Oggi le ragazze, molte ragazze non lo sono più.
Femministe, ciascuna a suo modo e senza definizione a volte, sono state (alcune) scrittrici. Anche inconsapevolmente. Da Simone De Beauvoir a Chimamanda Ngozi Adichie, passando per Virginia Woolf e le stesse sorelle Brontë, che, scrivendo sotto pseudonimo maschile, sono state pubblicate. Cosa ci dicono i romanzi delle lotte di affermazione femminile? Madame Bovary (“…c’est moi” diceva Flaubert, di lei) può essere considerata in parte la dimostrazione che gli uomini hanno accesso all’universo interiore delle donne?
Oddio volendo gli uomini hanno accesso anche all’universo interiore dei procioni, così le donne. Il tema non credo sia che possiamo capirci e anche raccontarci egregiamente, ma che, come scriveva Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé, per secoli sono stati gli uomini a raccontare le donne e mai, dico mai, viceversa. Questo dobbiamo ammetterlo qualche bias cognitivo l’ha sicuramente generato e ancora ne paghiamo le conseguenze.
Vanessa, possiamo sfatare il mito della donna in carriera, per favore? Dell’empowerment e della affermazione a tutti i costi (“da sola, perché da sola mi basto”)?
Ho scoperto che l’espressione “donna in carriera” nasce in Italia nel 1980, la conia una imprenditrice e segna in modo indelebile il nostro immaginario degli anni Ottanta. Così si intitolerà il film di Mike Nichols del 1988 il cui titolo originale è invece Working girl; questo per dire che si afferma una cultura che vede nel lavoro femminile una sfida da vincere a ogni costo, il soffitto di cristallo da sfondare e tutte quelle cose lì.
Ecco: intanto sfondare il soffitto di cristallo lasciando cadere sulla testa di altre donne le schegge di vetro non è per niente femminista. E poi, comunque, in questa retorica del farcela non si è mai affermata una uguale affermazione della necessità di far stare gli uomini a casa a prendersi cura dei figli, dei genitori anziani e così via.
Nessuno si basta da solo.
Il tuo saggio è uscito nel 2024. Che feedback hai ricevuto? Dalle lettrici, ma anche dai lettori, più o meno giovani, e magari dalle istituzioni?
È stato molto bello presentarlo in giro per l’Italia con generazioni diverse di donne e una grande sorpresa la voglia di discutere insieme. Provo una gratitudine immensa verso chi l’ha letto e ci ha ragionato al punto da volerne poi continuare a parlare anche con me. Il libro è, come recita il sottotitolo, “una storia personale e politica” e alterna la narrazione saggistica alla ricostruzione di alcuni momenti della mia storia personale, che poi ogni donna vive: la presa di coscienza del corpo, le mestruazioni, il primo rapporto sessuale, la discriminazione sul lavoro, il parto, l’aborto, la menopausa. Ma da storica ho cercato di mettere in dialogo questi momenti miei con quelli analoghi di altre donne e del tempo in cui accadevano, per cui alla fine il libro è diventato anche un tentativo di ripercorrere gli ultimi cinquant’anni della storia italiana alla luce di una parola: la parola “femminista”.