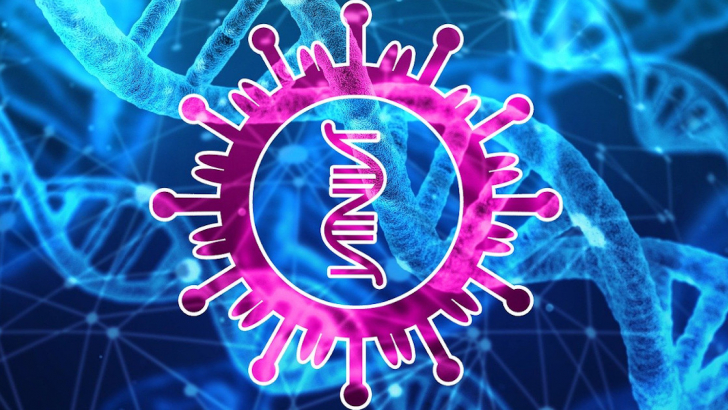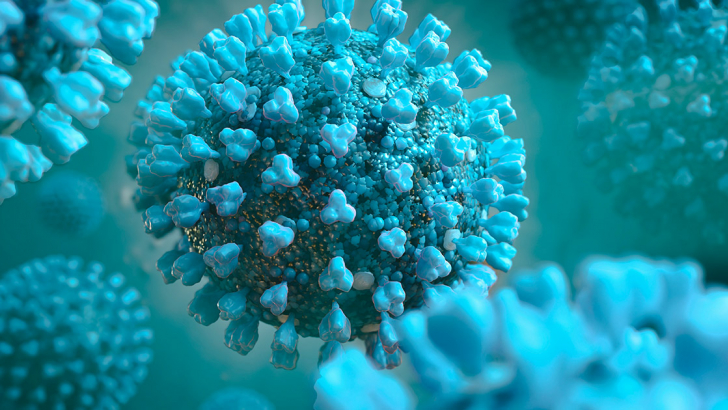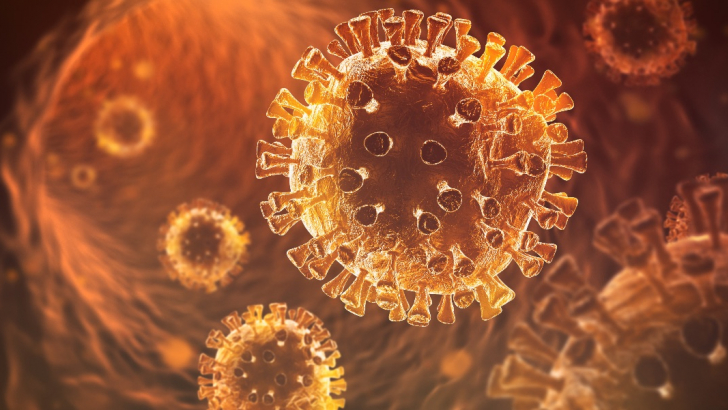SCIENZA E RICERCA
Dai Neanderthal agli interferoni: le variabili genetiche nella risposta a SARS-CoV-2

I ricercatori che da oltre un anno lavorano per cercare di comprendere ogni aspetto del nuovo coronavirus e i medici che lo combattono tra le corsie degli ospedali di tutto il mondo si sono presto resi conto che gli ormai noti fattori di rischio in grado di incidere sul decorso clinico del contagio non spiegavano completamente l’estrema variabilità della risposta individuale a SARS-CoV-2.
E’ risaputo che il progredire dell’età e la presenza di comorbidità, come diabete, obesità e ipertensione, possono predisporre a una forma severa di Covid-19. Tuttavia esistono casi, seppur limitati, di persone di giovane età e in buona salute che hanno rischiato la vita e che talvolta non sono riuscite a superare l’infezione. Sappiamo che anche i fattori climatici e ambientali hanno un loro ruolo, almeno per quanto riguarda la maggiore o minore dispersione delle particelle virali: se la trasmissione parte da una quantità limitata di virioni, come accade più facilmente nella stagione estiva, è più probabile che il nostro sistema immunitario sia in grado di allontanare la minaccia ed è per questo motivo che l’uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento fisico sono delle forme fondamentali di protezione.
Nella risposta individuale al patogeno entra però in gioco anche il nostro corredo genetico. Un fattore che non è modificabile in anticipo, visto che non possiamo scegliere di cambiarlo, ma sul quale stanno proseguendo studi molto importanti che hanno l’obiettivo di individuare nei database genetici i fattori che influenzano la gravità di Covid-19 e, al tempo stesso, capire i meccanismi dei “resistenti”, cioè di coloro che pur vivendo con una o più persone positive, non si infettano.
Tra le principali risultati dell’anno che si è appena concluso c’è uno studio firmato dal consorzio internazionale di genetica Covidhge, a cui ha partecipato anche il laboratorio di Genetica medica dell'università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Questo lavoro, pubblicato ad ottobre su Science, è stato inserito da Nature nella top ten delle 10 scoperte scientifiche più rilevanti del 2020: lo avevamo già approfondito qui su Il Bo Live ed è una ricerca, sviluppata attraverso due filoni complementari, che ha messo in luce come quasi il 15% delle forme gravi di Covid-19 siano dovute a cause genetiche e immunologiche legate ad anomalie nel funzionamento dell'interferone di tipo I, una molecola chiave nella regolazione del sistema immunitario.
LEGGI ANCHE:
Un altro ambito di studi ha invece posto l'attenzione verso un'epoca decisamente remota: gli eventi di ibridazione tra homo sapiens e Neanderthal e la possibilità che proprio l'eredità genetica dei nostri antichi parenti rappresenti un fattore di rischio per Covid-19. Secondo un lavoro condotto da Svante Pääbo e Hugo Zeberg, pubblicato su Nature, alcune varianti genetiche presenti sul cromosoma 3, arrivate a noi a partire dal DNA dei Neanderthal, sono associate ad un rischio triplo di dover ricorrere alla ventilazione meccanica in caso di contagio con il virus SARS-CoV-2. Più recentemente i due autori hanno realizzato un nuovo studio, in questo caso si tratta di un preprint, che ha approfondito il ruolo di un particolare enzima di derivazione neanderthaliana, chiamato dipeptidil peptidasi-4 (DPP4), che potrebbe facilitare l'ingresso del patogeno nelle cellule umane. Il legame di questo enzima con il virus della MERS era già noto, mentre per SARS-CoV-2 la conclusione rimane provvisoria e altri gruppi di ricerca non hanno segnalato il gene DPP4 nei database genetici con cui indagano sui fattori che influenzano la gravità di Covid-19.
LEGGI ANCHE:
Abbiamo chiesto al professor Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di Genetica medica dell'università Roma Tor Vergata e tra gli autori dello studio internazionale che ha individuato in alcune irregolarità nella produzione e nel funzionamento degli interferoni la causa di quasi il 15% delle manifestazioni severe di Covid-19, di spiegarci che peso può avere la variabilità genetica nel condizionare il decorso dell'infezione e se possono essere messi a punto farmaci e trattamenti terapeutici in grado di compensare eventuali anomalie.
Intervista al professor Giuseppe Novelli, direttore del laboratorio di Genetica medica dell'università di Roma Tor Vergata, sul ruolo dei fattori genetici nel decorso dell'infezione da SARS-CoV-2. Intervista e montaggio di Barbara Paknazar
“La variabilità genetica individuale ha un peso molto elevato”, introduce il professor Novelli spiegando che un articolo, recentemente pubblicato da Human Genomics e di cui lo scienziato italiano è il primo autore, ha fatto il punto sulla conoscenza maturata nei primi sei mesi della pandemia e ha rilevato che fino a questo momento il virus non ha acquisito una maggiore patogenicità attraverso le mutazioni che si sono diffuse. “Anzi, alcune mutazioni sembrano associate a un’infezione più lieve”, sottolinea Novelli precisando però che “queste valutazioni non sono applicabili alla variante inglese per la quale sono necessari ulteriori studi”.
Il ragionamento è dunque valido per le principali varianti che si sono diffuse nei mesi scorsi, come D614G diventata prevalente in Europa e già responsabile della prima ondata pandemica primaverile. "E' stato osservato un effetto sulla diffusione e sulla trasmissibilità, ma non sulla gravità della malattia. Allora è chiaro che se la responsabilità di questa variabilità del decorso clinico dell'infezione non può essere ricondotta al virus dobbiamo identificarla in altri fattori e, in particolare, nell'ospite", puntualizza Novelli.
Il sesso, l'età e la presenza di comorbidità sono caratteristiche importanti ma alcune persone si ammalano seriamente pur non rientrando nelle categorie ritenute più in pericolo. "Essere maschi è associato ad un rischio maggiore, così come essere anziani o la presenza di malattie come diabete, arteriosclerosi o ipertensione. Ma ci sono anche pazienti giovani che possono andare incontro a una forma grave di Covid-19 pur non presentando nessuno dei fattori di rischio noti. E' proprio sulla base di questa osservazione che sono stati costituiti una serie di consorzi internazionali che hanno permesso di stabilire l'esistenza di una certa suscettibilità genetica. Un risultato che non è giunto inaspettato perché lo si era già visto in molte malattie infettive, come l'Aids, la lebbra e la tubercolosi".
"La variabilità genetica fa parte dell'evoluzione degli umani e di tante altre specie di fronte all'attacco di un intruso come un virus o un batterio: ognuno di noi risponde in maniera diversa e abbiamo potuto stabilire che il 10% delle persone che si ammalano della forma grave di Covid-19 hanno un difetto genetico legato alla produzione o al funzionamento degli interferoni che sono la prima linea di difesa verso i virus. Di conseguenza le persone che sono geneticamente incapaci di produrre una difesa efficace incorrono in maggiori rischi.
Alcuni lavori di ricerca si sono concentrati su ACE2, il recettore chiave del virus SARS-CoV-2. "Siamo andati a vedere se ACE2 è diverso nelle varie persone ma non abbiamo trovato cambiamenti genetici rilevanti in tutte le popolazioni del mondo. Ad avere un ruolo non è quindi la qualità del recettore ma la quantità. I giovani ne esprimono di meno e quindi sono meno a rischio, almeno per le forme di virus che conoscevamo fino a pochi giorni fa, e lo stesso accade nella popolazione asiatica che tende geneticamente ad avere una minore quantità del recettore ACE2", approfondisce il direttore del laboratorio di Genetica medica dell'università di Roma Tor Vergata.
Altri studi hanno posto invece l'attenzione sui gruppi sanguigni o sull'antigene leucocitario umano (HLA). Il gruppo A sembra essere più a rischio di forme gravi, mente il gruppo 0 avrebbe una minore probabilità di ammalarsi in modo serio. "E poi non dobbiamo dimenticare che davanti all'azione di un virus sono moltissime le proteine che entrano in gioco, dall'ingresso fino all'uscita dalla cellula. Con questa variabilità ognuno di noi può rispondere in maniera diversa. Ci sono anche lavori che hanno posto l'attenzione non su un singolo gene ma su particolari regioni cromosomiche, come quella sul cromosoma 3", prosegue Novelli.
Quest'ultimo riferimento ci conduce verso un'epoca lontana, quella che vide homo sapiens ibridarsi con i Neanderthal ricevendo così parte del loro corredo genetico. Un'eredità che è racchiusa in circa il 2% del DNA delle popolazioni non africane e che davanti a SARS-CoV-2 sembra costituire uno svantaggio. Il professor Novelli però ridimensiona la "responsabilità" dei nostri antenati: "ogni gene ha un certo peso nel dare la suscettibilità alla malattia: i geni legati agli interferoni pesano molto, mentre quelli dei gruppi sanguigni hanno un impatto molto inferiore. La regione del terzo cromosoma si è mantenuta simile nel corso del tempo, perché è stata ritrovata simile nel DNA dei neanderthaliani, ed evidentemente ha un suo ruolo altrimenti non si sarebbe conservata tale. In quella sequenza ci sono dei geni che, in caso di contagio con il virus SARS-CoV-2, potrebbero avere un effetto ma il loro peso non è elevato e questo lo si evince facilmente andando ad indagare quante volte li si ritrova tra i pazienti gravi rispetto a quelli meno gravi. Se si è obesi o ipertesi il rischio di ammalarsi seriamente è molto più alto rispetto a quello associato alla variazione nel cromosoma 3".
"Studiare i motivi per i quali questa sequenza si è conservata è importante dal punto di vista biologico ma ai fini clinici conta poco. Da un punto di vista pratico non farei un test per vedere se questi geni sono presenti perché un test genetico, oltre ad essere valido, deve essere utile".
L'ambito di ricerca legato al rapporto tra eredità neanderthaliana e Covid-19 ha poi indagato in modo specifico il gene DPP4, un enzima anch'esso derivato dai neanderthal e che si ipotizza possa facilitare l'ingresso del virus nelle nostre cellule. Va precisato che gli studi al riguardo sono contrastanti e alcuni avevano escluso un ruolo di questa proteina davanti a SARS-CoV-2. Nel preprint pubblicato su bioRxiv Svante Pääbo e Hugo Zeberg affermano che il rischio di sviluppare complicazioni gravi potrebbe raddoppiare o addirittura quadruplicare tra le persone che hanno l'aplotipo di Neanderthal nel locus DPP4 e i ricercatori stimano che tra l'1% e il 4% degli europei e degli asiatici abbia ereditato una versione neanderthaliana di questo gene. Un aspetto potenzialmente rilevante è che l'enzima DPP4 svolge un ruolo chiave nel metabolismo del glucosio ed è un bersaglio dei farmaci contro il diabete.
"In questo filone di ricerca ci sono degli aspetti interessanti e anche noi abbiamo studiato questo gene in termini di espressione, di quantità di messaggero che produce. Il peso rilevato non è però così significativo per poter fare di questo enzima un riferimento. E se non lo puoi usare come marcatore o per farmaci o per indicare una prognosi non serve a nulla. E' quindi ancora tutto da definire e ci sono anche dati contrastanti".
E a proposito di farmaci che agiscano in base alla variabilità individuale, magari compensando quelle caratteristiche genetiche che indeboliscono la capacità dell'organismo di reagire al contagio, Novelli spiega che è in fase di avvio un progetto per poter creare un trial clinico a partire dalle scoperte sull'interferone di tipo I. "E' una molecola che conosciamo da trent'anni e che possiamo somministrare addirittura tramite aerosol. Insieme al consorzio Covidhge vogliamo identificare su scale internazionale le persone più a rischio e scegliere che tipo di terapia fare. Ad alcuni pensiamo di poter eseguire una plasmaferesi: il problema di una parte dei pazienti su cui abbiamo condotto la nostra ricerca è che l'interferone viene sì prodotto, ma poi finisce per essere distrutto dagli auto-anticorpi. L'idea è quindi quella di pulire il plasma da questi auto-anticorpi. Stiamo cercando di mettere a punto un protocollo di studio e di raccogliere le adesioni di ospedali che siano in grado di supportare la plasmaferesi. Potrebbe essere una strategia anche per il futuro perché le persone che si ammalano sono ancora molte e dobbiamo avere armi per curare la malattia, non solo per prevenirla come è possibile fare con i vaccini".
Fin qui abbiamo parlato di come alcuni dei nostri geni possano metterci in difficoltà in caso di esposizione al virus SARS-CoV-2 ma cosa contraddistingue invece chi non sviluppa sintomi o addirittura chi, pur avendo vissuto a stretto contatto con uno o più familiari positivi, non si è mai infettato? Nel DNA di queste persone c'è qualcosa che contribuisce a proteggerle dal virus?
"Con il Consorzio abbiamo lanciato un progetto che ha l'obiettivo di studiare i soggetti resistenti, cioè persone che sappiamo aver avuto un'esposizione al virus, certa e prolungata, ma che non sono risultate contagiate. Abbiamo avviato un programma con l'aiuto della fondazione Lorenzini di Milano e stiamo raccogliendo su base volontaria il DNA di questi soggetti che possono quindi rivolgersi al mio centro e donare il proprio sangue affinché possa essere studiato. Il comitato etico del policlinico Tor Vergata l'ha approvato un paio di settimane fa e il progetto in Italia è partito, così come è iniziato in tutto il mondo nell'ambito del consorzio. Stiamo già analizzando il DNA di queste persone per vedere se esiste un fattore comune di resistenza perché potrebbe essere molto importante. Per l'Aids è stato così: abbiamo scoperto che una parte di popolazione, tra il 5% e il 10%, non si infettava e oggi abbiamo un farmaco che è stato costruito proprio simulando questa resistenza. Anche nel caso di SARS-CoV-2 potrebbe essere quindi di grande utilità scoprire la base genetica delle persone resistenti al contagio".