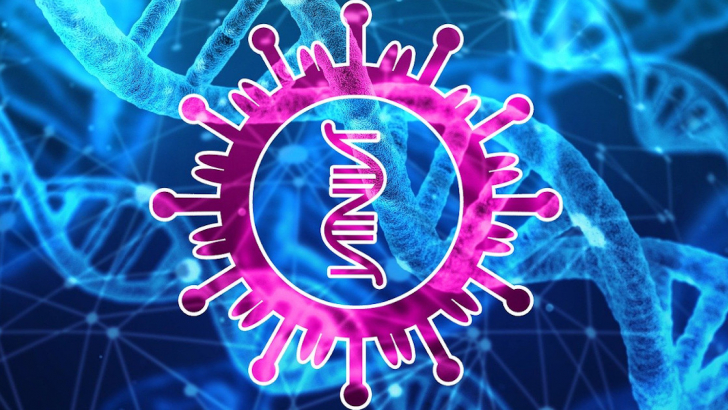Covid-19: alcuni geni ereditati dai Neanderthal possono aumentare il rischio di forme gravi di malattia
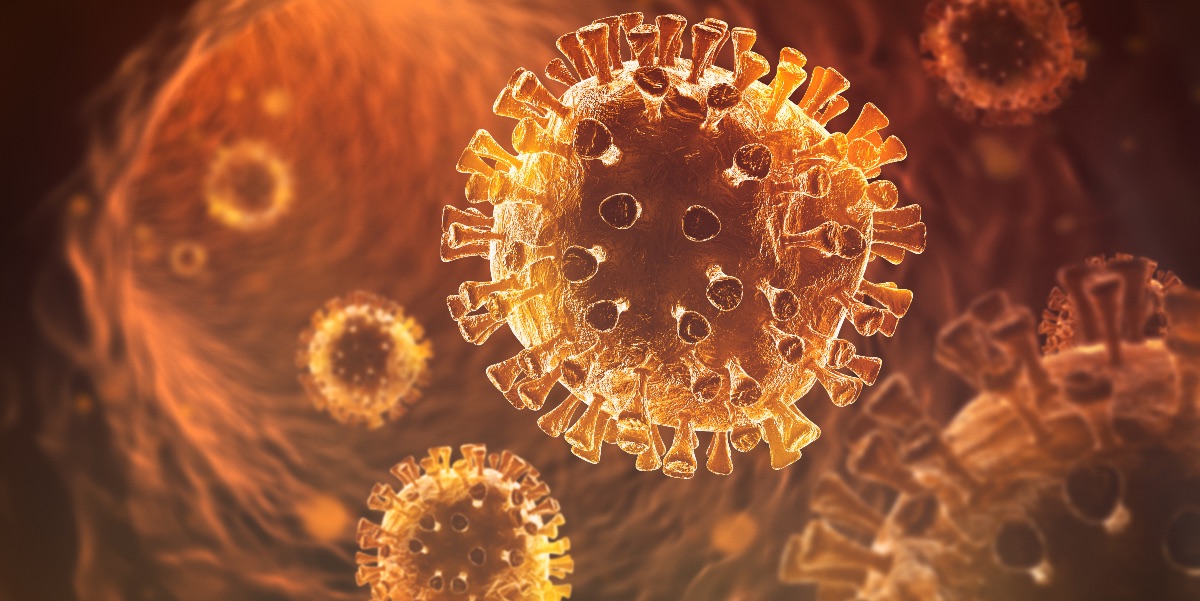
Fino a una ventina di anni fa tendevamo a rappresentare la nostra evoluzione come qualcosa di lineare, un percorso che, prima di portare al sopravvento di Homo Sapiens, poteva al massimo aver contemplato contatti sporadici e di breve durata con specie ritenute inferiori e più arcaiche, come i Neanderthal: un po’ l’immagine stereotipata dell'ominide che progressivamente migliora la sua posizione eretta e dismette l’uso della clava o quella dell'albero i cui rami si biforcano e non si incontrano più.
Abbiamo invece ormai appurato che nel corso della storia ci sono stati molteplici eventi di ibridazione che hanno portato nel DNA della popolazione non africana circa il 2% del precedente corredo genetico neanderthaliano. Un’eredità che oggi sembra avere un ruolo, purtroppo svantaggioso, davanti all’infezione da SARS-CoV-2 e che si aggiunge agli altri fattori di rischio già noti, come l’età avanzata, l’obesità e la presenza di comorbidità.
L’estrema diversità del decorso della malattia è stato sin dall’inizio uno dei grandi interrogativi che caratterizza questa pandemia. Il virus può restare silente e non dare evolvere mai in alcun sintomo, ma in alcuni casi è capace anche di aggredire l’organismo in forma sistemica, colpendo molti organi e provocando una grave insufficienza respiratoria che può portare alla morte.
I ricercatori hanno compreso che anche alcuni fattori genetici ed immunologici sono direttamente coinvolti nel decorso dell’infezione: ne avevamo già parlato in questo articolo dove si spiegava come alcune anomalie nel funzionamento degli interferoni fossero alla base di circa il 15% dei casi gravi di Covid-19.
A questa scoperta se ne è aggiunta una probabilmente più inaspettata, visto che ci riporta a circa 60 mila anni fa. E' in quel momento che iniziò la più recente fase di incrocio tra Homo sapiens e Neanderthal e uno studio coordinato da Svante Pääbo e Hugo Zeberg, recentemente pubblicato su Nature, ha osservato che alcune varianti genetiche presenti sul cromosoma 3, associate ad un rischio triplo di dover ricorrere alla ventilazione meccanica, sono state ereditate proprio dal DNA dei Neanderthal.
Genetic variants that are associated with the risk of severe COVID-19 may have been inherited from Neanderthals, according to a paper in Nature. This is just one of many risk factors for severe disease, and others include advanced age and being male. https://t.co/Dq6OI0rtga pic.twitter.com/oosNGQKU2f
— Nature (@nature) September 30, 2020
Gli studiosi dell'Istituto tedesco Max Planck sono partiti dai risultati di due precedenti lavori: il primo, arrivato sulle pagine della prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, è frutto di una collaborazione internazionale messa a punto dal Severe Covid-19 GWAS Group ed è stato condotto su quasi 2000 pazienti ammalati in forma grave di Covid-19, ricoverati in sette ospedali di Italia e Spagna. L'analisi dell'intero genoma di questi pazienti, e il confronto con i dati dei circa 2.200 soggetti del gruppo di controllo, oltre a indicare che i pazienti con gruppo sanguigno A hanno un rischio quasi doppio di ammalarsi in modo serio, ha permesso di identificare uno specifico cluster genico, il 3p21.31, quale fattore che induceva un decorso clinico più critico. Allo stesso risultato era arrivato anche un lavoro del COVID-19 Host Genetics Initiative su oltre 3000 pazienti ospedalizzati.
Partendo dall'osservazione di questi dati Svante Pääbo e Hugo Zeberg hanno scoperto, analizzando un database online di genomi arcaici di tutto il mondo, che la specifica sequenza genetica riscontrata in molti pazienti gravemente ammalati era presente in modo molto simile in un uomo di Neanderthal vissuto in Croazia 50.000 anni fa. Si tratta, in particolare, di una specifica combinazione di sei geni sul cromosoma 3, vale a dire un aplotipo di loci che in genere vengono ereditati insieme. Non è ancora chiaro perché questi geni costituiscano uno svantaggio davanti all'infezione da SARS-CoV-2 e questo fattore di rischio può sorprenderci in quanto sappiamo che il patrimonio genetico dei nostri antichi parenti ci ha permesso di essere più protetti davanti a diverse infezioni ed è probabile che in passato anche questo aplotipo sia stato vantaggioso.
La sequenza genetica che potrebbe far sviluppare una forma grave di Covid-19 ha inoltre una particolare distribuzione geografica e risulta presente nel Dna di circa la metà degli individui in Asia meridionale e nel 16% degli europei, mentre è molto più rara nell'Asia orientale e in Africa. La più alta frequenza di portatori si verifica in Bangladesh, dove più della metà della popolazione (63%) porta almeno una copia dell'aplotipo a rischio.
“È sorprendente che il patrimonio genetico dei Neanderthal abbia conseguenze così tragiche durante l'attuale pandemia. Il motivo deve adesso essere indagato il più rapidamente possibile", ha dichiarato Svante Pääbo, scienziato svedese che nel 2010 è riuscito nell'impresa di ricostruire l'intero patrimonio genetico dell'uomo di Neanderthal e che oggi dirige il Max Planck di Lipsia. Al riguardo il coautore dello studio Hugo Zeberg, genetista che lavora al Karolinska Institute di Stoccolma, ha spiegato al Guadian che "si sta cercando di individuare quale gene è il giocatore chiave, o se ci sono diversi giocatori chiave, ma la risposta onesta è che non sappiamo quali sono i fattori critici nel Covid-19". Un'ipotesi su cui si sta lavorando è che questi geni possano avere un ruolo nella risposta immunitaria e nei meccanismi usati dal virus per entrare nelle cellule umane.
Questo aplotipo che oggi si sta rivelando svantaggioso davanti al virus SARS-CoV-2 potrebbe aver protetto i Neanderthal da alcune altre malattie infettive che oggi non esistono. Alcuni dei geni che abbiamo ricevuto in eredità sono utili, mentre alcuni sono dannosi, ha spiegato Zeberg aggiungendo che "Questa è stata un'arma a doppio taglio."
Ne è convinto anche Luca Pagani, professore di antropologia molecolare al dipartimento di Biologia dell'università di Padova, che ha approfondito il fenomeno dell'introgressione adattativa. "Questo aplotipo, per essere presente con una tale frequenza, deve aver avuto una pressione positiva dal punto di vista selettivo, da quando è stato ereditato 60 mila anni fa ad oggi, probabilmente perché esercitava una funzione positiva che oggi non conosciamo, magari migliorando la difesa nei confronti di qualche altro patogeno. Per un certo periodo della storia avere questo aplotipo era qualcosa di utile e vantaggioso. Adesso, invece, davanti a SARS-Cov-2 sta diventando un problema e se ragioniamo in chiave evolutiva potremmo aspettarci che la presenza di questo aplotipo tra un migliaio di anni tenderà ad abbassarsi", ha spiegato Pagani.
L'intervista completa al professor Luca Pagani, docente di antropologia molecolare dell'università di Padova. Servizio e montaggio di Barbara Paknazar
"Quello di Zeberg e Pääbo - introduce il professor Luca Pagani - è uno studio a valle: i due autori sono partiti dai risultati trovati da altri ricercatori che, dopo aver confrontato pazienti con un decorso più o meno grave di Covid-19, avevano scoperto che alcune regioni del genoma sono associate alla possibilità che la malattia si manifesti in una forma più severa. L’informazione di partenza è quindi che una persona che ha queste varianti geniche ha una probabilità più alta di sviluppare una sindrome più grave in caso di contagio da nuovo coronavirus. Zeberg e Pääbo si sono accorti che la variante umana associata a questi sintomi gravi era molto simile a quella di alcuni Neanderthal, umani arcaici i cui progenitori si sono separati dalla nostra storia evolutiva circa 600 mila anni fa e dall’Africa, dove tutti eravamo ad evolverci, si sono diretti verso l’Eurasia differenziandosi in varie popolazioni. Il motivo per cui ci interessano è che ci permettono di scoprire i risvolti evolutivi di un'umanità parallela".
Gli eventi di ibridazione tra popolazioni umane antiche scoperti dai genetisti negli ultimi anni hanno ridisegnato la nostra storia evolutiva, come ripercorre Francesco Suman in questo articolo su Il Bo Live in cui ricostruisce le ultime scoperte scientifiche sull'evoluzione di tutto il genere Homo. Il più antico evento di ibridazione mai registrato tra due popolazioni umane arcaiche è avvenuto circa 700 mila anni fa quando i Neandersovani, antenati di Neanderthal e Denisova, hanno lasciato l'Africa e si sono incrociati con una popolazione euroasiatica del genere Homo, probabilmente erectus, che era fuoriuscita dal continente africano molto tempo prima, circa 1,9 milioni di anni fa.
Luca Pagani si sofferma sull'ondata migratoria più recente che portò Homo sapiens ad incontrare Neanderthal e Denisova fuori dal continente africano. "Sappiamo che quando alcuni umani sono usciti dall’Africa circa 60 mila anni fa hanno incontrato i Neanderthal e si sono ibridati con loro e sappiamo anche che circa il 2% del genoma di tutti gli umani al di fuori del continente africano contiene pezzetti di Neanderthal. In realtà questa è una media ma ci sono alcune regioni del genoma in cui nessun umano ha dei pezzi di Dna neanderthaliano, magari perché conferiva degli svantaggi molto forti e la selezione li ha quindi rimossi dal nostro genoma". Si fa riferimento a questo fenomeno con la definizione di deserti neanderthaliani e la sua controparte è che "ci sono delle regioni dove invece la presenza è molto maggiore del 2%: un esempio è quello del gruppo di geni TLR 1-10, che fa parte di un meccanismo che regola l’immunità innata e che è stato individuato in un’elevata percentuale di europei. Questa specifica sequenza del Dna è stata ricevuta non da antenati sapiens ma da antenati Neanderthal", spiega il docente di antropologia molecolare.
L'incorporazione permanente di geni da un gruppo geneticamente distinto è definita introgressione, un fenomeno che ha una natura adattativa. "Il trasferimento di pezzi di Dna da Neanderthal a Homo Sapiens - entra nel dettaglio il professor Pagani - è avvenuto mediante ibridazione e il meccanismo adattativo ha fatto sì che questi geni, ricoprendo probabilmente un ruolo positivo, aumentassero di frequenza. Tutto questo era già noto. La novità di questo studio è che anche una di queste regioni genomiche, associate alla maggiore o minore gravità di Covid-19, potrebbe aver seguito questo percorso. Un alto numero di persone, in particolare nell’Asia meridionale, risulta avere questo aplotipo neanderthaliano che rende potenzialmente più esposti a una forma grave di Covid-19 e l’implicazione importante va individuata proprio nella frequenza elevata con cui si riscontra questa sequenza in alcune popolazioni".
Queste varianti geniche di origine neanderthaliana sono invece molto rare in Africa e ci si è domandati se questo fattore potesse contribuire a spiegare perché finora il virus SARS-CoV-2 sembra aver colpito quella parte del mondo in maniera molto meno aggressiva. Il docente di antropologia molecolare dell'università di Padova preferisce però essere molto cauto sull'argomento. "Sull’Africa, considerate le note difficoltà diagnostiche, non sono del tutto sicuro del fatto che l’apparente ridotto impatto della malattia sia dovuto esclusivamente a fattori biologici. Ritengo che possa esserci una sottostima diagnostica: basta considerare il fatto che in Italia, durante il caos della prima ondata, si pensa che i casi riscontrati erano un decimo di quelli effettivi", afferma Pagani.
E quanto al motivo per il quale la frequenza di questo aplotipo è così alta nel sud dell’Asia e molto meno in Europa "è con tutta probabilità legato a fattori ambientali. Quella sequenza deve aver rappresentato solo un moderato vantaggio per chi ne era portatore nel nostro continente, mentre al contrario in Asia il vantaggio potrebbe essere stato significativamente maggiore".
I geni che abbiamo ereditato dai nostri antenati possono quindi essere stati a volte utili e altre volte meno. Di sicuro dobbiamo ringraziare il Dna neanderthaliano per averci fornito i Toll-Like Receptor, proteine molto efficaci nel proteggere l'organismo.
"Il TLR 1-10 è parte di un meccanismo immunitario importante che reagisce appena il nostro organismo entra in contatto con un patogeno ignoto. Si tratta di un’ottima difesa iniziale prima che subentri l’immunità successiva con lo sviluppo di anticorpi specifici. Alcune varianti di questo gene sono frutto di introgressione adattativa ed è un altro caso di aplotipo neanderthaliano che ha avuto un’alta frequenza in Europa e in Asia", spiega il professor Pagani. Per quanto riguarda invece i geni dannosi il docente precisa che ci sono due modi di intendere la questione. "Alcuni erano così svantaggiosi che oggi non li vediamo perché i sapiens che si erano ibridati con Neanderthal e avevano ricevuto queste sequenze dannose a lungo termine non hanno lasciato prole e quindi oggi in molte regioni del genoma vediamo solo sequenze sapiens. Ci sono invece altre regioni che sono passate nel nostro genoma, erano utili o neutrali e poi si sono rivelate dannose in un secondo momento. La certezza in queste affermazioni dipende però dalla certezza che abbiamo noi nell’associare una regione genetica a un determinato fenotipo o comportamento".
Tornando allo studio che ha collegato l'aplotipo ereditato dai Neanderthal con un rischio tre volte maggiore di dover ricorrere alla ventilazione meccanica in caso di contagio con il virus SARS-CoV-2 sembra ancora presto per trarre conclusioni nette e definitive. Lo sostiene, sempre su Nature, un'analisi firmata da Yang Luo, docente alla Harvard Medical School di Boston, scrivendo che "è affascinante pensare che l'eredità genetica dei nostri antenati potrebbe svolgere un ruolo nell'attuale pandemia", ma "l'impatto sottostante del DNA ereditato sulla risposta del corpo al virus non è chiaro". Yang Luo ricorda poi che "la disuguaglianza sociale e le sue ripercussioni possono probabilmente spiegare una percentuale maggiore del rischio di morte per COVID-19 rispetto al DNA derivato da Neandertal" e che "sebbene i geni coinvolti nella risposta COVID-19 possano essere ereditati, i fattori e i comportamenti sociali (come il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine) sono sotto il nostro controllo e possono ridurre efficacemente il rischio di infezione".
Il professor Pagani concorda sulla necessità di approfondire maggiormente il rapporto tra i geni neanderthaliani e il decorso clinico di Covid-19 e precisa che una correlazione non implica necessariamente una causalità. Secondo lo studioso uno stimolo importante che arriva dal lavoro di Pääbo e Zeberg riguarda la necessità di aumentare la dimensione cosmopolita delle popolazioni umane coinvolte nelle ricerche scientifiche, senza quindi limitarsi agli studi che spesso si focalizzano solo su cittadini europei o americani di origine europea.
"L'articolo in questione non è risolutivo rispetto alle nostre conoscenze sull’interazione tra genoma e Covid. E’ un ottimo caso di evidenza di una regione genetica che ha una storia evolutiva abbastanza particolare perché è rientrata nel nostro genoma tramite i Neanderthal, è una regione che evidentemente ha avuto un successo evolutivo prima del Covid perché è a frequenze molto più alte di quel 2% che potevamo aspettarci. E poi un’altra conclusione interessante dell’articolo è che avere oggi a disposizione pannelli di popolazioni umane cosmopolite, quindi non i soliti studi che coinvolgono cittadini europei o statunitensi, ma avere una buona prospettiva su quale è la genetica delle popolazioni dell’India, del Pakistan, del Bangladesh, della Cina e così via, può essere importante non solo da un punto di vista antropologico ma anche epidemiologico. Grazie a questi pannelli di popolazione adesso sappiamo che in Bangladesh e in India il Covid potrebbe causare problemi particolarmente gravi perché c’è una grande abbondanza di portatori di questo specifico aplotipo. E’ una conclusione molto rilevante che ci dice quanto sia fondamentale avere sempre in mente la variabilità umana perché poi in momenti problematici, come quelli che stiamo vivendo adesso, ci torna utile".