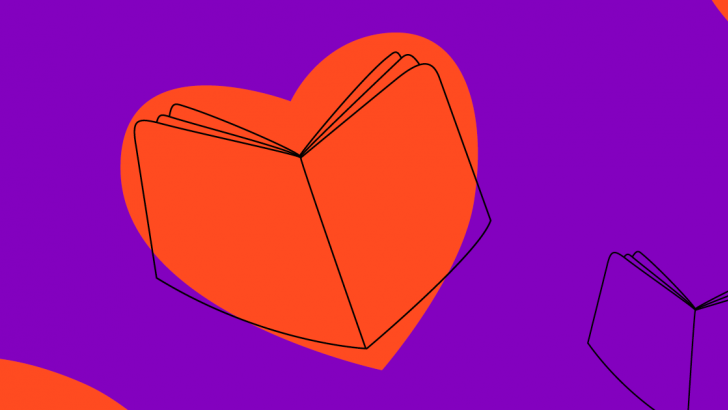Il Madrigale senza suono vale a Tarabbia il Premio Campiello

È stata la volta buona: finalista (e premio della Giuria dei letterati) nel 2016 con Il giardino delle mosche, Andrea Tarabbia, bolognese classe 1978, con Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri, 384 pagine) – romanzo, anche questo, premiato dalla critica –, finalmente il Premio Campiello lo vince. E il libro è eccezionale.
Discostandosi dalla maggior parte della tradizione letteraria contemporanea italiana, Tarabbia scrive un romanzo storico che nulla ha del ripiegamento ombelicale di tanta letteratura che viene data alle stampe, ma richiama alla mente opere grandi, I promessi sposi, per dirne una (non a caso si aprono, questo come quello, con lo “stratagemma del manoscritto”).
Quattro anni e mezzo gli ci sono voluti per documentarsi sulla vita di don Carlo Gesualdo da Venosa, madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, e per trovare la lingua e la forma del “suo canto”. L’ambizione del progetto si concretizza: Tarabbia dà vita, con la parola in prosa, a un componimento che è, a tutti gli effetti, un canone di voci come è un madrigale, appunto.
Ammettendo che la forma sia sostanza, l’autore racconta infatti di aver trovato una storia, quella del celebre principe, che si presta alla sua ricerca linguistica e formale: i personaggi si passano il testimone nel racconto, in un susseguirsi di voci che si richiamano, di situazioni che si rassomigliano, di personaggi che potrebbero essere scambiati l’uno per l’altro. Ma c’è di più: non è la trama – ossia le vicende storiche – l’obiettivo vero e proprio del raccontare, ma il modo in cui si racconta e il contesto, il dettaglio, la sfumatura, il sottotesto.
C’è una scena – quella in cui Gesualdo viene persuaso dallo zio a uccidere la moglie, la bella Maria d’Avalos che lo tradisce con Fabrizio Carafa – in cui ai commensali viene servito uno stufato zoccoli di cavallo. Ebbene: per mangiare gli zoccoli i protagonisti li lanciano contro la parete perché si rompano, e il lettore in una qualche misura è colpito forse più da questa bizzarra usanza che dalla decisione di ordire un delitto. E quando il doppio omicidio si compie, ed è una sorta di carneficina operata per mezzo di archibugi, ripetute coltellate, veemenza e rabbia, la scena è disturbata dalla presenza di un gabbiano che sbatte rumorosamente contro la finestra nel tentativo di entrare, attratto dall’odore del sangue.
Tarabbia dice di aver “chiamato” queste scene, mentre scriveva, come “la scena degli zoccoli”, “la scena del gabbiano” e così per altre affini, perché quegli erano gli aspetti che voleva si fissassero nella mente dei lettori. E in effetti il romanzo è su più livelli: la vicenda; il contesto storico; i dettagli grotteschi; le parabole di ciascun personaggio (e ce ne sono di ogni tipo, tra cui streghe e esseri bestiali rinchiusi nelle segrete), ma, sopra tutti, la musica.
A raccontare sono in due: Stravinsky (che è, di fondo, l’alter ego dello scrittore), compositore che riportò in auge, nel Novecento, l’opera di Gesualdo dedicandogli un “Monumentum” nella Basilica di San Marco a Venezia e Gioachino, personaggio d'invenzione, il servo storpio del principe Carlo, che scrive in fretta furia le memorie del suo padrone, di cui è stato letteralmente l’ombra, prima che quest’ultimo, che si sta lasciando morire di dolore (e di atonia intestinale), infine muoia.
Tra Gioachino e Gesualdo c’è un dialogo, verso la fine, che così recita:
“Gioachino, dimmi: tu hai mai amato la mia musica?”
“Lo sapete padrone: si ama soltanto ciò che si capisce”.
[…] “Io ho cercato di mettere mondi dentro questi suoni, e controsuoni, che ho fatto. Dimmi: ci sono riuscito?” […] “Questi mondi che io ho cercato, Gioachino, sono anche figli tuoi: tu mi facesti leggere libri che non si potevano leggere, e dentro questi libri si dicevano meraviglie, il mondo era più complesso di come io lo immaginavo e lo sapevo, era santo ed eretico insieme, era fluido e mutevole, era bello e feroce […] Io sono colpevole: volevo una musica mai ascoltata prima, che non avesse toni, che vagasse nell’infinito e nell’indistinto […]. Di questo sono colpevole: di aver voluto mondi e di non aver creato che quello che già c’era”.
Scambiando due parole con Andrea Tarabbia, si può immaginare che egli possa sentire su di sé la medesima colpa, ma questa è la virtù dei grandi: creare mondi infiniti senza esserne mai soddisfatti, e nel far ciò, però, divertirsi. Il madrigale senza suono, quello di Stravinsky su Gesualdo, quello che Gesualdo stesso compone in fin di vita, è anche, senza dubbio, quello dell’autore, che è riuscito a trasformare la prosa in poesia, e financo in musica.
“ volevo una musica mai ascoltata prima, che non avesse toni, che vagasse nell’infinito e nell’indistinto