In Salute. Epatite: un progetto in Burkina Faso per la lotta alla malattia
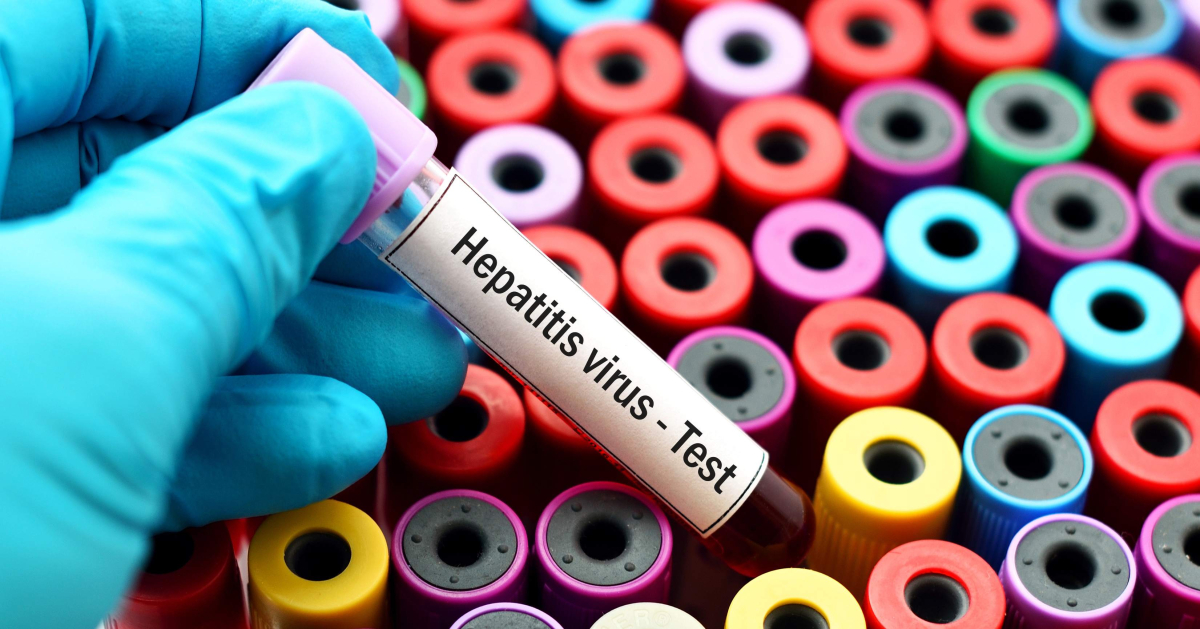
Foto: Adobe Stock
Senza un’azione urgente, si stima che l’epatite virale causerà 9,5 milioni di nuove infezioni, 2,1 milioni di casi di cancro al fegato e 2,8 milioni di decessi entro il 2030, a livello globale. Esiti che, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, potrebbero essere evitati con un’estensione della vaccinazione contro l’epatite B, con un migliore accesso alla prevenzione, diagnosi e trattamento per l’epatite B e C e campagne di sensibilizzazione. A questo scopo l’Oms ha definito una strategia di intervento con l’obiettivo di eliminare l’epatite virale come problema di salute pubblica entro cinque anni (Global Health Sector Strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections for the period 2022-2030), ma le azioni a livello globale risultano essere in ritardo.
L’Africa è una delle regioni in cui la patologia è più diffusa e proprio in questo contesto si inserisce un progetto recentemente avviato dall’università di Padova per la prevenzione, diagnosi e trattamento dell’epatite B e C. Finanziato con 3 milioni di euro dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, sarà implementato in Burkina Faso in partenariato con Medici con l’Africa Cuamm e l’Istituto superiore di Sanità in stretta collaborazione anche con il Ministero della Salute locale e l’Oms. Ne abbiamo parlato con Giovanni Torelli, programme manager di Medici con l’Africa Cuamm, e Francesco Paolo Russo, professore di gastroenterologia del dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’ateneo padovano.
Gli obiettivi dell’Oms per il 2030
I ceppi del virus dell’epatite sono cinque (A, B, C, D ed E) e tutti possono causare malattie del fegato, ma differiscono per modalità di trasmissione, gravità dell’infezione, distribuzione geografica e metodi di prevenzione. L’epatite B e C, in particolare, rappresentano insieme la causa più comune di cirrosi epatica, cancro al fegato e decessi legati all’epatite virale. Ebbene, il piano d’azione dell’Oms punta a ridurre le nuove infezioni da epatite a 520.000 casi all’anno e i decessi correlati all’epatite a 450.000 entro il 2030, che significa una riduzione del 90% nell’incidenza e del 65% nella mortalità rispetto al 2015.
Se questi sono gli obiettivi, vediamo qual è la situazione attuale. Nel 2022, circa 304 milioni di persone nel mondo convivono con un’epatite cronica di tipo B o C, nella stragrande maggioranza dei casi epatite B (oltre l’80%). I decessi sono 1,3 milioni: circa 3.500 persone al giorno. In più di 60 Paesi, il tasso di mortalità legato all’epatite supera i 20 decessi ogni 100.000 abitanti, che è il doppio rispetto al traguardo fissato dall’Oms per il 2025. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le popolazioni delle regioni del Pacifico occidentale e dell’Africa, dove il peso della malattia è particolarmente grave.
Solo il 13% delle persone affette da epatite B e il 36% di quelle affette da epatite C nel 2022 hanno ricevuto una diagnosi e il numero di chi viene curato è ancora più basso: il 3% di chi soffre di epatite B e il 20% di chi soffre di epatite C. Secondo gli obiettivi fissati per il 2025 le diagnosi invece dovrebbero raggiungere il 60% e le persone trattate il 50%.
Un punto cruciale è la prevenzione della trasmissione dell’epatite B di madre in figlio: ad oggi 129 Paesi hanno adottato politiche di screening prenatale e 147 hanno introdotto la vaccinazione contro l’epatite B alla nascita. A livello mondiale, però, solo il 43% dei neonati riceve effettivamente questa dose di vaccino subito dopo la nascita. Inoltre poco più della metà dei 194 Stati membri dell’Oms ha raggiunto una copertura del 90% per il ciclo completo di vaccinazione infantile contro l’epatite B.
Agire in Africa: il progetto in Burkina Faso
Come si è detto l’Africa è tra le regioni più colpite dalla malattia: circa il 6% della popolazione, 65 milioni di persone, convive con l'epatite B cronica, solo Ruanda, Algeria e Zambia hanno una prevalenza inferiore al 2%. L'epatite C cronica invece colpisce circa lo 0,7% della popolazione, cioè 8 milioni di persone. Nella regione africana si registra più del 20% dei decessi mondiali dovuti all’epatite (310.000) e la mortalità è più elevata nei Paesi con un'alta prevalenza di epatite B cronica.
La percentuale di persone che arriva a una diagnosi e poi viene curata rimane molto bassa: meno del 5% e del 6% per l'epatite B cronica e rispettivamente il 13% e il 3% per l'epatite C cronica. Il Ruanda è l’unico Paese ad aver identificato clinicamente più del 60% dei casi e trattato oltre la metà delle persone infette. Sebbene l’Africa registri il 60% delle nuove infezioni da epatite B a livello globale, presenta la copertura vaccinale alla nascita più bassa al mondo, pari al 17%.
Il quadro rapidamente descritto, aiuta a comprendere meglio il peso dell’iniziativa coordinata dall’università di Padova, che avrà la durata di tre anni e si concentrerà principalmente sul Centro ospedaliero universitario di Bogodogo, a Ouagadougou. Le attività sul campo non sono ancora iniziate a causa delle complesse procedure di autorizzazione in Burkina Faso, che coinvolgono varie istituzioni e richiedono numerosi passaggi burocratici, ma un referente del Cuamm è sul posto e sta seguendo l’iter di registrazione.
Nuove linee guida e screening delle donne in gravidanza
“In alcune zone dell’Africa, come il Burkina Faso, si raggiungono prevalenze di epatite molto elevate – osserva Francesco Paolo Russo –. Da alcuni studi a livello locale è emerso che in certe aree si arriva anche ad avere il 10% della popolazione positiva per l’epatite B, che sembra rappresentare un problema ben più rilevante rispetto all’epatite C”. Il rischio aumenta significativamente nei gruppi vulnerabili, come le donne in gravidanza.
Secondo il docente il progetto costituisce un significativo intervento di cooperazione sanitaria internazionale, per il rafforzamento del sistema sanitario burkinabè nella lotta contro le epatiti virali. “Insieme all’Oms definiremo le nuove linee guida nazionali del Burkina Faso per lo screening, la presa in carico e il trattamento delle persone affette da epatiti virali, ma anche dei loro familiari. Il passo successivo sarà quello di lavorare in collaborazione all’Istituto superiore di Sanità per la creazione di un percorso informatizzato per la gestione dei pazienti all’interno dell’ospedale”.
Russo spiega che l’obiettivo principale del progetto, in particolare, è quello di effettuare lo screening delle donne in gravidanza per l’epatite virale, garantendo la presa in carico non solo delle mamme, ma anche di bambini e bambine al momento della nascita, e dei familiari. “L’intento cioè è di evitare da un lato che la donna sviluppi una patologia cronica del fegato, dall’altro che il neonato venga infettato; ma anche prevenire le infezioni interfamiliari, che si trasmettono tra persone a stretto contatto con una paziente positiva. Verosimilmente in famiglie dove c’è una donna positiva, è molto probabile che ci siano altri componenti infetti”.
Necessaria una rete a livello locale
“Nell’ospedale di Bogodogo vengono gestiti circa 9.000 parti l’anno, soprattutto i più complicati – continua Russo –. Questi, però, non corrispondono ad altrettante donne seguite nel tempo, che completano l’iter con il parto. Per questo motivo è necessario individuare le gestanti molto prima. È necessario creare una rete a livello locale, e in questa direzione il Cuamm sta dando un contributo importante. Purtroppo la situazione geopolitica del Burkina Faso non è semplice: non ci consente di spostarci al di fuori della capitale, dove invece ci sarebbero altri centri potenzialmente adatti a collaborare. Siamo quindi concentrati su Ouagadougou e sull’ospedale universitario di Bogodogo, ma grazie al Cuamm abbiamo individuato altri punti di riferimento all’interno della capitale, dove potremo avviare il percorso di presa in carico e invio delle donne in gravidanza all’ospedale”.
Approfondisce Giovanni Torelli del Cuamm: “Il progetto prevede una serie di attività non solo pratiche, tecniche e mediche di screening e terapie, ma include anche il supporto alla struttura sanitaria, al personale, e la formazione per l’implementazione di questi programmi. Gran parte del progetto ruoterà intorno all’ospedale universitario, ma sarà necessario identificare anche le strutture dello stesso distretto che si occupano di antenatal care, cioè della cura prenatale, che poi riferiscono all’ospedale le eventuali donne in gravidanza risultate positive. La parte relativa allo screening dunque verrà estesa anche ad altri centri sanitari, magari di livello inferiore, ma comunque appartenenti al distretto, che faranno da tramite verso l’ospedale. Qui verranno poi svolte le attività di ricerca dei contatti, monitoraggio, cura, vaccinazione, formazione, e anche di fornitura di reagenti e attrezzature”. Come equipaggiamenti diagnostici, test, farmaci e sistemi informatizzati per la gestione delle cartelle cliniche.
Il progetto si concentra nella capitale, ma intende aprirsi anche alle associazioni locali, come Assaut-Hépatites. “L'obiettivo è quello di offrire formazione non solo al personale medico e accademico strutturato, ma anche alle associazioni di pazienti, affinché possano poi operare anche al di fuori del contesto ospedaliero della capitale”. Solo attraverso la formazione infatti si possono mettere gli operatori del settore nelle condizioni di seguire autonomamente i protocolli anche dopo che il progetto sarà concluso.
Un problema di cultura, formazione e disponibilità di farmaci
Le ragioni che fanno dell’Africa una delle aree a livello mondiale in cui è maggiormente diffusa l’epatite sono varie, secondo Giovanni Torelli. “C’è innanzitutto una scarsa conoscenza del problema e delle modalità di trasmissione. Manca dunque educazione di base”. Incide poi l’assenza o il limitato utilizzo dei farmaci per la cura e il controllo della malattia, che riducono significativamente anche la possibilità di trasmissione.
“C’è carenza di vaccini, disponibili spesso in maniera saltuaria, e i protocolli vaccinali non vengono rispettati”. Per questo il progetto intende introdurre tutta una serie di percorsi che facilitino un utilizzo più regolare e continuativo. “Introdurremo la regola della vaccinazione entro le 24 ore dalla nascita, perché spesso bambini e bambine, dopo il parto, tornano nei villaggi e vengono persi di vista. Intendiamo fare formazione alle associazioni locali, che sono più capillarmente diffuse nel territorio, proprio perché anche i richiami non vadano persi”. Conclude il medico del Cuamm: “È dunque un problema di cultura, di formazione, e anche di disponibilità di farmaci e vaccini. Se non si interviene, il problema resta”.
SPECIALE EPATITI:












