A quando un reality che veda la morte dei concorrenti?
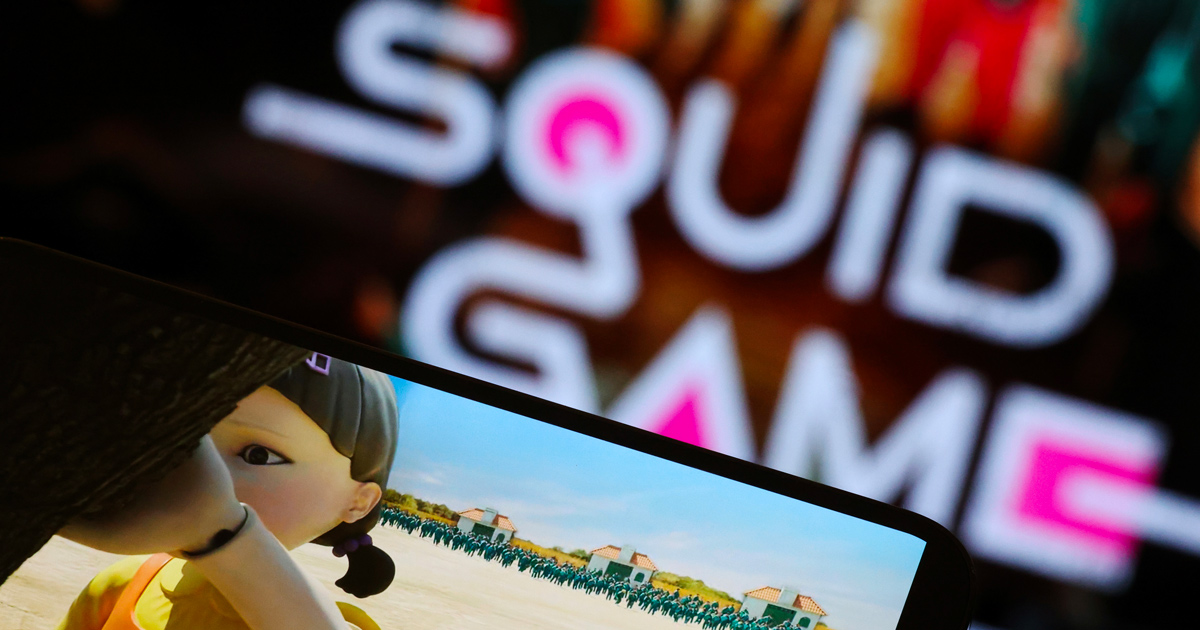
Foto: Reuters
La notizia non ha scosso nessuno, eppure dovrebbe. Netflix sta terminando le riprese di Squid Game: The Challenge, un reality basato sulla propria serie tv omonima. Per i pochi al mondo che non lo sapessero, Squid Game è una serie sudcoreana in nove episodi, commissionata da Netflix e uscita sulla piattaforma streaming a settembre 2021, sulla base di un progetto concepito anni prima, e mai realizzato, del regista Hwang Dong-hyuk. La prima stagione della serie, realizzata con costi limitati (in totale circa 21,4 milioni di dollari), è stata un successo planetario, il prodotto originale Netflix più visto al mondo, con un miliardo 650 milioni di ore di streaming scaricate nei primi 28 giorni di programmazione. Alcune stime ipotizzano che gli introiti prodotti a qualsiasi titolo dalla serie abbiano fruttato a Netflix circa 900 milioni di dollari.
Di cosa parla Squid Game? Sul piano dei contenuti, la trama si ispira a un genere vetusto, il survival: un gruppo di persone sono poste di fronte a una minaccia che comporta una lotta per sopravvivere, anche a costo di uccidersi tra loro. In questo caso (sottogenere ugualmente logoro) la minaccia non è una catastrofe naturale, un’entità soprannaturale o un killer sconosciuto, ma un’organizzazione di sadici ricconi che architetta un orribile gioco, reclutando 456 persone in difficoltà economiche e promettendo una somma favolosa a chi arriverà primo: al prezzo, scopriranno i partecipanti, di morire tutti tranne il vincitore, massacrati da giochi collettivi che ne provocano la progressiva decimazione.
Molto è stato scritto sul perché del trionfo di un prodotto del genere, le cui qualità artistiche ed estetiche, a dispetto dei tanti lodatori, sono davvero modeste. E molto fa riflettere che la serie più vista al mondo abbia come principale filo conduttore una violenza estrema, sadica, che implica negli spettatori un puro, ininterrotto voyeurismo (chiunque abbia amore per il cinema avverte dopo pochi minuti la povertà creativa della sceneggiatura). Squid Game avrà, ovviamente, seguito in una seconda stagione, che Netflix programmerà a fine 2023 o inizio 2024. Per promuoverla, la piattaforma ha ideato un reality in 10 puntate ispirato alla serie: 456 veri concorrenti, selezionati sulla base di un casting mondiale, partecipano a prove che richiamano quelle mortali della serie. Il premio (vero anche questo) per il vincitore è davvero allettante: 4,56 milioni di dollari.
Il set scelto per le riprese è un hangar alle porte di Londra, presso una ex base della Royal Air Force. Malgrado la riservatezza assoluta cui sono tenuti i concorrenti, nelle scorse settimane sono filtrate alcune notizie. Alcuni dei partecipanti, che hanno rilasciato dichiarazioni sotto anonimato, hanno definito “inumano” il trattamento ricevuto. Per una prova, sostengono, sono dovuti rimanere una giornata nell’hangar a temperature sottozero, costretti a rimanere immobili anche per mezz’ora. Lamentano di non aver ricevuto informazioni sufficienti su ciò che li attendeva, e avanzano il sospetto che le prove fossero truccate, con alcuni concorrenti selezionati ad hoc per avanzare alle prove successive. Netflix, con una nota, ha smentito che non vi fossero adeguate condizioni di sicurezza, ma ha dovuto ammettere che tre concorrenti sono ricorsi all’intervento del medico durante le riprese.
Al momento non è possibile capire quanto di vero ci sia in queste accuse, e quanto possa far parte di una strategia di marketing: ma poco importa, in fondo. Il punto è che il reality “modello Squid Game” costituisce (per ora) il punto più basso del progressivo imbarbarimento della cultura dello show business: una deriva avviata con certe maratone giornalistiche che documentavano, in diretta e senza filtri, la sofferenza di esseri umani, giungendo infine al reality, nuovo genere televisivo di “realtà apparente” che, dal Grande Fratello in poi, ha utilizzato persone come cavie, sottoponendole allo sguardo del pubblico mentre le impegnava nelle attività più varie o le osservava nelle situazioni più intime.
Il cinema aveva previsto con largo anticipo ciò che sarebbe accaduto. Opere come L’asso nella manica di Billy Wilder, sullo sciacallaggio truccato da giornalismo, o La morte in diretta di Bertrand Tavernier, sullo sfruttamento mediatico della malattia terminale di una donna, avevano chiarito molti decenni fa come l’industria dei media avrebbe presto o tardi ceduto all’intuizione di sfruttare al massimo pulsioni come la curiosità morbosa, la commiserazione o il cinismo, facendo sì che il pubblico non le rivolgesse più verso personaggi di finzione, ma persone in carne e ossa, manipolate dagli autori di copioni che lasciavano agli spettatori un’illusione di realtà.
Squid Game: The Challenge passa, in questo senso, una linea rossa. Nei quasi ventiquattro anni che ci separano dal debutto, nei Paesi Bassi, della prima edizione di Big Brother in tv (1999) abbiamo visto di tutto: reality su malattie, deformità, sesso in tutte le varianti, sfide di qualunque tipo, sport estremi: l’intimità più profonda e le tappe fondamentali della vita sceneggiate e rese spettacolo. Se la sofferenza reale dei protagonisti, fisica o psicologica, preesistente o indotta, è sempre stata un ingrediente fondamentale, c’era ancora un tabù inviolabile: la morte dei concorrenti. Netflix varca, sia pure simbolicamente, questa soglia: la grande sfida di The Challenge rispecchia perfettamente le prove letali della fiction (secondo le testimonianze, i concorrenti sono dotati di sacche con un liquido che simula il sangue, in modo che l’eliminazione dalla gara passi attraverso la rappresentazione della loro uccisione, con l’esplosione della sacca). Siamo davvero sicuri che, anche se sadico, questo sia solo un gioco?









