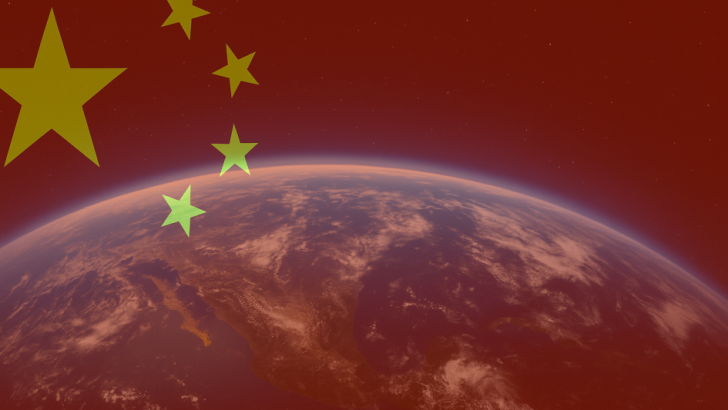Scacchiere asiatico: cosa sta succedendo tra Cina e Taiwan

Una esercitazione militare a Taiwan. Foto: Reuters
L’esibizione muscolare della Cina, con 156 aerei da combattimento che tra l’1 e il 4 ottobre hanno sorvolato i cieli a ridosso di Taiwan (nella sua area di difesa e identificazione, ADIZ, una sorta di zona-cuscinetto a 35 miglia nautiche dalle coste), è senza alcun dubbio un gesto di sfida, e non soltanto verso i “separatisti” taiwanesi. Il presidente cinese Xi Jinping sta battendo da anni sul progetto di riunificazione della Grande Cina, come se la “macchia” di quell’isolotto, a 180 km dalle sue coste, che dal 1949 ha scelto di separarsi dalla madrepatria (fondando la Repubblica di Cina), non fosse più tollerabile.
L’aveva ribadito già due anni fa (luglio 2019), al Congresso del Popolo, presentando il Libro Bianco, il piano di difesa nazionale: «Non rinunceremo all’uso della forza nel tentativo di riunificare Taiwan con la terraferma: adotteremo tutte le misure militari necessarie per sconfiggere i “separatisti”». E visto che i separatisti non cedono, non si arrendono, non piegano la testa (anzi, alzano la voce proprio per trasformare la questione in scontro internazionale), ecco salire la temperatura delle minacce. Quasi assaporando l’ipotesi (o testandone le conseguenze) di un’invasione. «L’unificazione in modo pacifico è più in linea con l’interesse generale della nazione cinese, compresi i compatrioti di Taiwan», ha detto Xi pochi giorni fa, ammorbidendo i toni, ma non la sostanza, parlando a un evento per i 110 anni dalla rivoluzione che rovesciò l’ultima dinastia imperiale, nel 1911. «Ma nessuno dovrebbe sottovalutare la ferma determinazione, la ferma volontà e la forte capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale. Il compito storico della completa riunificazione della madrepatria deve essere adempiuto, e sarà sicuramente adempiuto». L’offerta di Pechino è un principio simile a quello attuato a Hong Kong, “un paese, due sistemi”, garantendo una certa quota di autonomia (ma si è visto com’è andata a finire nell’ex colonia britannica). La risposta di Taiwan, che dopo 72 anni di autonomia non vuol saperne di rientrare sotto il dominio del Partito Comunista Cinese (nonostante sia formalmente riconosciuto da appena 15 nazioni come stato sovrano), non si è fatta attendere.
La presidente Tsai Ing-wen ha promesso che farà di tutto per difendere il suo Paese: «Il percorso che la Cina ha tracciato non offre né uno stile di vita libero né democratico per Taiwan, per i nostri 23 milioni di persone. Non ci piegheremo alle pressioni della Cina». Mentre il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, ha prima definito la situazione “la più grave degli ultimi 40 anni”, per poi indicare un orizzonte ben preciso: «La Cina avrebbe già ora la capacità di invadere Taiwan, ma non inizierà facilmente una guerra, dovendo prendere in considerazione molte altre cose. Entro il 2025 sarà in grado di organizzare un’invasione su larga scala». Tra le “molte altre cose” da considerare, al netto delle ripercussioni internazionali, Pechino dovrà risolvere anche il problema di una limitata capacità di rifornimento in aria, che attualmente limita l’azione dei suoi caccia. Come scrive il sito East Asia Forum, in un’interessante analisi: «Nessuna forza aerea - non importa quanto siano moderni i suoi caccia o quanto bravi i suoi piloti - può prevalere senza una buona logistica. I generali dell'Aeronautica dell’Esercito di Liberazione del Popolo (PLAAF) lo sanno bene».
La partita, com’è evidente, è assai più ampia del perimetro dello stretto di Formosa, che separa Taiwan dalla Cina. Una partita destinata a coinvolgere molti altri attori. Il presidente taiwanese Tsai Ing-wen l’ha ben spiegato firmando un appassionato editoriale sulla rivista statunitense Foreign Affairs: «Il rifiuto di Taiwan di arrendersi, il suo persistente abbraccio della democrazia e il suo impegno ad agire come stakeholder responsabile (anche quando la sua esclusione dalle istituzioni internazionali lo ha reso difficile) stanno ora spronando il resto del mondo a rivalutare il suo valore come democrazia liberale in prima linea in un nuovo scontro di ideologie» - scrive Tsai Ing-wen. «Poiché i paesi riconoscono sempre più la minaccia rappresentata dal Partito comunista cinese, dovrebbero comprendere il valore di lavorare con Taiwan. E dovrebbero ricordare che se Taiwan dovesse cadere, le conseguenze sarebbero catastrofiche per la pace regionale e il sistema di alleanze democratiche, con il sopravvento dell’autoritarismo sulla democrazia».
Chi si schiera con chi
Gli Stati Uniti si sono immediatamente schierati al fianco di Taiwan, pur senza dichiarare esplicitamente che la difenderanno militarmente in caso di attacco, nel solco di un’ambiguità strategica di fondo che prima o poi dovrà essere risolta (fanno affari con loro sulla base del Taiwan Relations Act, firmato nel 1979, compresa una consistente fornitura di armi, ma non hanno mai riconosciuto formalmente Taiwan come stato sovrano): «Il nostro sostegno e la nostra relazione di difesa con Taiwan rimangono allineati contro l’attuale minaccia rappresentata dalla Repubblica popolare cinese», ha dichiarato martedì scorso il portavoce del Pentagono, John Kirby. «Esortiamo Pechino a onorare il suo impegno per la risoluzione pacifica delle differenze nello Stretto». I funzionari del Dipartimento della Difesa americano hanno poi aggiunto che «l’impegno degli Stati Uniti a Taiwan è solido come una roccia». Il New York Times riporta una riflessione di Evan Medeiros, ex consigliere della sicurezza nazionale sotto la presidenza di Barack Obama: «La questione di Taiwan è diventata un teatro centrale - se non il dramma centrale - nella competizione strategica tra Stati Uniti e Cina». Uno scenario talmente verosimile che da anni, almeno dal 2018, è oggetto di sofisticati war games per testare punti deboli o di forza in un eventuale conflitto su Taiwan tra Stati Uniti e Cina. «Per noi è soltanto una questione di tempo, non di se», aveva detto lo scorso luglio il contrammiraglio Michael Studeman, direttore del comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti alle Hawaii.
Così i blocchi si delineano più chiaramente. Con le recenti manovre di 17 navi da guerra (comprese tre portaerei) di 6 diverse nazioni (Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Paesi Bassi, Canada e Nuova Zelanda) che hanno effettuato manovre congiunte al largo dell’isola giapponese di Okinawa, a nord-est di Taiwan. L’obiettivo, dichiarato, è di mostrare l’impegno per un “Indo-Pacifico libero e aperto”. Anche l’Australia, che il mese scorso ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per l’acquisto di sottomarini a propulsione nucleare (una decisione che molto preoccupa Xi Jinping), ha criticato i voli “di disturbo” dell’aviazione cinese. Oltre all’India, che fa parte del Quad con Usa, Australia e Giappone (appena terminate esercitazioni congiunte nel Golfo del Bengala). E che con la Cina ha problemi serissimi nello stato indiano dell’Arunachal Pradesh, che la Cina rivendica come parte del Tibet meridionale (200 soldati cinesi sono stati arrestati, e poi rilasciati, pochi giorni fa per aver sconfinato senza autorizzazione). All’appello non poteva mancare la Russia, con Vladimir Putin, intervistato dal canale televisivo Cnbc, che si è seduto dalla parte di Pechino: «Penso che la Cina non abbia bisogno di usare la forza», ha detto il presidente russo parlando delle tensioni crescenti nello stretto di Formosa. «La Cina è un’economia enorme e potente e, in termini di parità di acquisto, la Cina è oggi l’economia numero uno al mondo davanti agli Stati Uniti. Aumentando questo potenziale economico, la Cina è in grado di realizzare i suoi obiettivi nazionali. Non vedo alcuna minaccia». Posizione poi ribadita dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov: «Per noi, come per la stragrande maggioranza degli altri Paesi, l’isola appartiene alla Cina. E questa è la premessa da cui procediamo e continueremo a procedere nella nostra politica al riguardo».
I rischi di una “nuova guerra fredda”
Intanto Pechino, attraverso Ma Xiaoguang, portavoce dell’ufficio che si occupa degli affari di Taiwan, ribadisce che le esercitazioni militari dei giorni scorsi sono “una mossa giusta per proteggere la pace e la stabilità”. E che “la causa delle attuali tensioni è stata la collusione del Partito Democratico Progressista (DPP, al governo di Taiwan) con le forze straniere”. Il problema è proprio lì: le forze straniere e il loro potenziale coinvolgimento in caso di un’azione di forza ordinata da Pechino. Non tanto le truppe militari di Taiwan, che sembrano al contrario indebolite, da quando il governo di Taiwan ha gradualmente eliminato l’arruolamento obbligatorio per gran parte dei giovani (anche se da un anno è segnalata la presenza sull’isola di un piccolo contingente di americani con il compito di addestrare truppe locali). E la sproporzione delle forze in campo è lampante (2 milioni di soldati cinesi contro 170mila taiwanesi, per non dire delle dotazioni aeree, missilistiche e navali). Anche se l’ipotesi di trovarsi contro Stati Uniti, Giappone, Australia, e Gran Bretagna, giusto per fare qualche ipotesi, non è una prospettiva che per Xi Jinping possa essere considerata attraente. E soprattutto: per cosa? Per il dominio di un’isola? Per rincorrere il mito della Cina unificata? Per sopire future aspirazioni separatiste di qualche remota regione? O soltanto per questioni economiche (Taiwan è leader mondialenella produzione di semiconduttori, qui un approfondimento)? D’accordo, non siamo ancora al punto di non ritorno: in fondo si è trattato di voli di avvertimento, una minaccia plateale e (finora) innocua. Ma se si fosse verificato un minimo incidente, anche involontario? Qualsiasi scintilla, in una simile situazione, rischia di innescare un incendio di proporzioni incalcolabili.
Insomma, la partita vera si gioca sull’asse Cina-Stati Uniti, ma il bianco ce l’ha Pechino, spetta comunque al presidente Xi la prima mossa. E se non muove, la scacchiera rimane intatta, così com’è. L’editorialista William A. Galston ha riassunto così la situazione, pochi giorni fa, sul Wall Street Journal: «Nessuna persona sana di mente vuole la guerra tra Cina e Stati Uniti, ma una combinazione di ambizioni contrastanti, errori di calcolo strategici e percezioni errate reciproche potrebbe portarci in una situazione rischiosa. Soprattutto se l’America non prende le misure necessarie per convincere il signor Xi che non siamo ciò che lui crede che siamo: un potere in declino, privo dei mezzi e della volontà per difendere i nostri amici». E’ giusto “abbaiare”, fa parte della grammatica diplomatica. Ma resta una domanda: gli Stati Uniti sarebbero davvero disponibili a imbarcarsi in una guerra di queste proporzioni (con il rischio che possa diventare anche nucleare) dopo l’imbarazzante e disordinato ritiro dall’Afghanistan per la difesa di Taiwan? Vale il rischio (come si chiede anche Foreign Policy)? Soprattutto: a chi conviene? Tra Cina e Stati Uniti è in corso una “nuova guerra fredda”. Ma il pericolo di uno scontro aperto non sembra immediato (la settimana scorsa Biden e Xi hanno concordato il rispetto e la prosecuzione del Taiwan Relations Act): prima di passare alle armi (e nessuno tra i contendenti, oggi, sarebbe pronto per passare all’azione), le diplomazie hanno un lungo lavoro davanti.