Scienziati e giornalisti, convivenza difficile
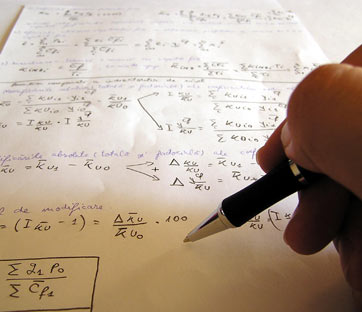
Cheerleader o cane da guardia? Il titolo è provocatorio, le colonne quelle di Nature di qualche tempo fa, oggetto del dibattito (sempre attuale) la professione del giornalista scientifico.
Cosa si aspetta un ricercatore da un giornalista, ci si chiede, al di là della capacità di cogliere la notiziabilità del suo lavoro e di scriverne correttamente il nome? “Non molto” risponderebbero probabilmente alcuni. Mentre altri considerano il giornalismo scientifico una sorta di “servizio pubblico” che esiste solo per informare le masse delle nuove scoperte scientifiche. Solo una minoranza ne intuisce il significato più profondo e coglie l’occhio critico con cui il giornalista guarda alla sfera pubblica, scienza inclusa. “La società ha bisogno di vedere che la ricerca viene esaminata e rigurgitata se è il caso, proprio per dare fiducia alla scienza stessa, e i giornalisti sono una parte essenziale di questo processo”.
In un faccia a faccia tra il giornalista Fabio Pagan e lo studioso Francesco Gnesotto, si è recentemente dibattuto su questi temi a Padova durante un convegno organizzato nell’ambito del master in comunicazione delle scienze. Precisione, correttezza, aderenza alle parole degli studiosi, chiede lo scienziato. Ma incalza il giornalista: “Correttezza e precisione, certo. Fino a un certo punto però: non deve essere un mito. Chi fa il giornalista deve raccontare una storia, anche quando si tratta di una ricerca. La storia si fa leggere, entra nella mitologia”. E continua: “Il giornalista non deve essere il trombettiere, il portavoce dello scienziato. Non deve limitarsi a tradurre, ma deve raccontare. Deve entrare nella rete del personaggio, perché la scienza è fatta da uomini e donne che portano il proprio vissuto all’interno dei laboratori”. Il giornalista può farsi anche watchdog, un cane da guardia che vigila sull’attività degli scienziati, anche se in Italia non è così facile. Per ragioni di tempo, di disponibilità, di interesse dei giornali ad avere un giornalista specializzato in ambito scientifico. “Chi scrive di scienza deve raccontare anche cosa avviene dietro le quinte”, argomenta Pagan. Il “ventre oscuro della scienza” lo ha chiamato Susan Watts della BBC, intervenuta qualche tempo fa al Cambridge Science Festival.
Giornalismo scientifico è cosa diversa dalla comunicazione della scienza, sottolinea la giornalista. Quest’ultima mostra al largo pubblico quanto possa essere interessante la scienza raccontando la scoperta di un nuovo materiale, di una nuova cura. Suscita “meraviglia”. Ma la meraviglia non basta e spetta al giornalista scientifico andare oltre, per capire se dietro a un nuovo studio esistano profitti non dichiarati, conflitti di interesse o bufale.
È il caso, per citarne uno, di Andrew Jeremy Wakefield che sosteneva la relazione tra autismo e somministrazione del vaccino trivalente (rosolia, morbillo, parotite) con uno studio pubblicato nel 1998 su The Lancet. Una vicenda su cui investigò il reporter Brian Deer e che si concluse con il ritiro dell’articolo da parte della rivista scientifica poiché considerato fraudolento. Nel frattempo, tuttavia, i media avevano dato spazio alla notizia. Molti genitori avevano deciso di non vaccinare i propri figli.
È il rischio della corsa allo scoop, la volontà di arrivare primi, la tendenza a spettacolarizzare la notizia che a volte caratterizza un certo tipo di informazione scientifica sui media. Al contrario serve cautela, perché le nuove scoperte hanno spesso la necessità di essere sottoposte a ulteriori sperimentazioni e conferme che necessitano di tempi lunghi.
Che si tratti di comunicazione della scienza o di giornalismo, per riprendere il ragionamento di Susan Watts, in entrambe i casi è necessario chiedere molti “perché” e confrontarsi con scienziati a volte timidi e riluttanti o che più semplicemente parlano a fatica del proprio lavoro. Ma un giornalista in più deve essere coraggioso abbastanza per scovare ciò che la gente non vuole che si sappia. “Abbiamo bisogno di un giornalismo – puntualizza Watts – che ponderi i valori e i vizi della scienza”.
In tutto ciò si deve fare i conti con i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni in questo ambito professionale. “Ho vissuto 40 anni di storia del giornalismo scientifico in Italia – ricorda Pagan – e ciò a cui stiamo assistendo oggi è una trasformazione antropologica di questa figura”. All’inizio i professionisti erano pochi, tutti strutturati all’interno di un giornale e con tutte le sicurezze economiche che ne derivavano.
Pagan osserva che negli ultimi 20 anni, anche per merito o responsabilità dei corsi specialistici istituiti nelle università, sono sorte nuove figure professionali e una nuova generazione di giornalisti scientifici o aspiranti tali. Al punto che non ci sono mai stati in Italia tanti professionisti del settore come oggi. Ciò tuttavia ha fatto il gioco degli editori che puntano al ribasso. “Stando così le cose – rilancia Pagan – ha senso formare delle figure professionali per un mercato che non solo è più contenuto rispetto al passato ma che si sta riducendo e paga sempre meno? I giornalisti scientifici all’interno delle redazioni stanno sparendo, perché i direttori preferiscono ridurre a contributi esterni, sottopagati, a prescindere dalla qualità”. Eppure queste figure specializzate possono portare un valore aggiunto a una redazione, secondo Susan Watts.
Nonostante questa situazione caratterizzi il giornalismo nel suo complesso, quello scientifico sembra essere il settore più colpito. E paradossalmente, pur con la crisi dell’editoria, non ci sono mai stati in Italia tanti giovani con questa professionalità.
“La cultura scientifica in Italia – ribatte Gnesotto – è carente e noi abbiamo bisogno senz’altro di più mediazione. Dobbiamo preparare i giovani in numero sufficiente per cercare di raggiungere almeno la media europea in questo campo”. Senza contare che il giornalismo scientifico è solo uno degli sbocchi professionali a cui aprono i percorsi universitari specifici.
Ciò che si deve considerare è che la scienza e il giornalismo non sono culture aliene. “Sono costruiti sulle stesse fondamenta – si legge su Nature – la convinzione che le conclusioni necessitino di prove, che le prove dovrebbero essere disponibili a tutti, e che ogni cosa è soggetta a domande”.
Monica Panetto









