Il corpo come luogo dello sfruttamento
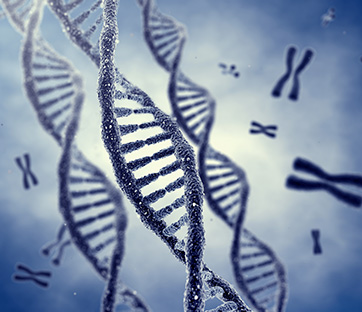
Ricerca sulle cellule staminali, manipolazioni genetiche, sperimentazione di nuovi farmaci, gestazione per altri (nota anche come ‘utero in affitto’) sono alcuni dei temi più dibattuti in questo momento, accomunati dal fatto che riguardano i corpi delle persone e il loro uso economico. Oggi la tecnologia entra sempre più nei nostri stessi processi vitali, e questo ovviamente pone una serie di problemi: da quelli medico-sanitari a quelli etici. Pochi però finora hanno riflettuto sugli effetti nell’economia e nel mercato del lavoro, il punto di vista scelto dalle sociologhe australiane Melinda Cooper e Catherine Waldby nel libro Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera (Derive e approdi 2015).
Biolavoro o lavoro clinico (Clinical Labor), perché questi nuovi processi coinvolgono le funzioni intime delle persone, senza che però al momento queste vedano riconosciuto il loro ruolo di lavoratori. Con una serie di conseguenze molto importanti sul piano di un precariato diffuso, salari bassi e scarsa tutela giuridica. Un nuovo sottoproletariato mondiale composto soprattutto di donne: donne che si sottopongono a stimolazione ovarica, che portano avanti una gravidanza per altri o che devono far fronte a una richiesta crescente di ovuli, sangue cordonale, embrioni da utilizzare per la ricerca o per le varie applicazioni della medicina rigenerativa. Che contribuiscono in maniera essenziale a uno dei settori più in crescita dell’economia mondiale, raccogliendo però solo le briciole di una ricchezza enorme prodotta a partire dai loro corpi.
Lo studio, ricco di dati e di fonti, si sofferma in particolare sulla questione della gravidanza surrogata, uno dei temi oggi al centro del dibattito pubblico. Basti pensare che poche settimane fa alcune associazioni femministe hanno firmato a Parigi un appello per la messa al bando di questa pratica, mentre d’altra parte, anche all’interno dello stesso pensiero femminista, c’è chi la ammette in nome della stessa autoderminazione delle donne.
Certo resterebbe deluso chi si aspetterebbe una difesa a spada tratta della famiglia tradizionale: nell’analisi delle autrici, condotta con gli strumenti della critica marxiana e femminista, la classica famiglia patriarcale non è che l’espressione della vecchia economia industriale, incentrata sulla produzione in larga scala di stampo fordista. Un modello da tempo messo in crisi dalla tecnologia e dall’emancipazione femminile: per questo oggi i tradizionali compiti inerenti alla cura e alla riproduzione, una volta appannaggio della casalinga-moglie-madre, vengono sempre più spesso appaltati all’esterno sulla base delle esigenze della donna lavoratrice. Proprio come è già avvenuto con le aziende, che hanno trasferito all’estero la produzione e portato all’esterno tutti i servizi, dalle pulizie alla mensa.
È successo con le badanti, e oggi rischia di succedere anche con le madri surrogate. L’industria e il lavoro riproduttivo umano insomma, nati negli anni ’70 per curare le difficoltà procreative, assumono oggi nuove caratteristiche: le esigenze lavorative e le pressioni delle stesse corporation (che ritardano l’ingresso stabile nel mercato del lavoro) spingono le donne ad avere figli ad età sempre più tardive, con rischi per la salute e per la fertilità. Questo mentre allo stesso tempo il figlio è sempre più visto e vissuto come realizzazione personale e status sociale. E qui arriva la bacchetta magica del biocapitalismo, che con le moderne tecnologie sfrutta la forza procreativa di donne giovani ma povere, riflesso sul piano riproduttivo di fenomeni economici più ampi come la globalizzazione e l’esternalizzazione dei processi produttivi. E non è un caso, secondo le autrici, che questo mercato nasca e si sviluppi soprattutto negli Usa (precisamente in California) negli anni della Reaganomics, per poi diffondersi nel resto del mondo soprattutto a seguito delle riforme liberiste in campo economico.
Un modello commerciale, che paradossalmente esclude dai maggiori benefici proprio le donne, a causa di un modello mistificante che Coooper e Waldby chiamano ‘la retorica del dono’. L’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per prendere un esempio tra tanti, stabilisce “il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro”. Un tabù, quello della commercializzazione dei tessuti, che però non tutela i soggetti più deboli, ma anzi alla fine si risolve in un espediente per indebolirne la posizione contrattuale.
Del resto, notano le autrici, da sempre le donne povere – si tratti di schiave, prostitute o nutrici per i bambini delle famiglie ricche – sono costrette da una società maschilista a vendere alcune loro funzioni biologiche per sopravvivere. In particolare “le forme di lavoro riproduttivo – scrivono Cooper e Waldby – risentono di questi precedenti storici, proprio perché... strutturate da rapporti di potere postcoloniali e di classe” (p. 62). Non è un caso che spesso oggi che il mercato si rivolga soprattutto alle donne dei paesi poveri o in via di sviluppo, come l’India o la Thailandia, mentre per l’approvvigionamento degli ovuli sono in prima linea i paesi dell’Europa dell’Est, le cui donne sono più ricercate per le loro caratteristiche etniche. Per quanto invece riguarda gli Usa, secondo un rapporto del 2005, le madri surrogate sono generalmente “ventenni o trentenni bianche, cristiane, sposate e con figli propri”, con redditi familiari modesti anche se non bassissimi. Un profiling che serve spesso a venire incontro alle preferenze della clientela, ma anche ad evitare l’accusa di sfruttamento delle minoranze.
La donazione e la gestazione per altri sono di solito sottoposte a contratti secondo i quali la donna perde praticamente ogni diritto sugli oociti e sul feto: se vuol essere pagata dovrà obbedire sotto ogni aspetto ai desiderata dei committenti e sottoporsi agli esami e alle procedure cliniche previste, compreso l’aborto. In questo senso il biolavoro non sarebbe altro, secondo questa visione, che la nuova forma assunta oggi dallo sfruttamento dei corpi, in particolare femminili, con in più un elevato tasso di industrializzazione.
Resta da chiarire in questo quadro il ruolo della bioetica, con i vari organismi e documenti prodotti. Una funzione secondo le autrici troppo spesso ambigua: più di foglia di fico del biocapitalismo che di reale garanzia a favore delle persone, in particolare le più deboli. Uno strumento insufficiente, secondo Cooper e Waldby, senza almeno il riconoscimento della dignità di lavoratore a chi oggi presta il proprio corpo alla scienza e alla tecnica. Volente o troppo spesso costretto dalla povertà.
Daniele Mont D’Arpizio









