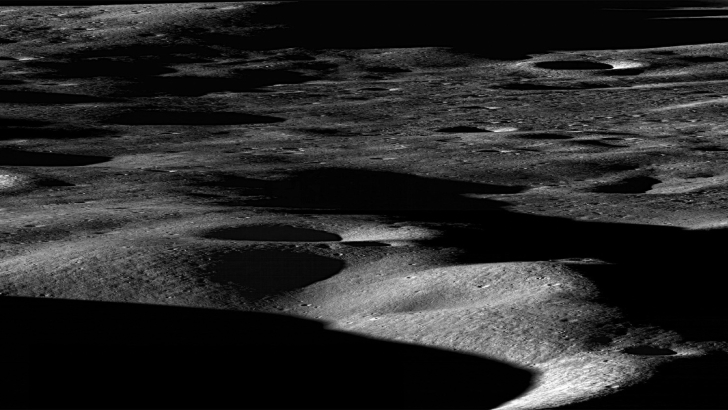La corsa ai satelliti: l'Italia punta all'indipendenza nelle telecomunicazioni

Rappresentazione artistica di satelliti in orbita attorno alla Terra
Negli ultimi anni lo spazio non è più soltanto il luogo della ricerca scientifica o delle missioni di esplorazione. È diventato un’infrastruttura vitale per la vita quotidiana di Paesi, governi e cittadini. Dalle comunicazioni di emergenza alle operazioni militari, dalla gestione delle reti elettriche al coordinamento dei soccorsi durante una calamità naturale, la capacità di trasmettere dati in modo sicuro e continuo può determinare la resilienza di un’intera nazione. Per questo motivo l’Italia ha avviato un programma per costruire e mantenere una rete satellitare autonoma capace di garantire comunicazioni sicure, anche nei contesti più difficili. Nei mesi scorsi, si erano inseguite numerose polemiche politiche: un articolo della legge 89/2025, approvata alla fine di giugno in via definitiva, sembrava un chiaro riferimento alla possibilità che il governo italiano siglasse un accordo con SpaceX per l’uso della sua rete satellitare Starlink. Al netto delle smentite da parte di Palazzo Chigi, il piano italiano per un sistema autonomo smentisce questa ipotesi ma non risolve un problema tutto italiano ed europeo: il ritardo cronico nel dotarsi di dispositivi di questo tipo, decisamente strategici nello scacchiere globale.
Sul panorama globale, tuttavia, l’Italia non si muove da sola. Da una parte ci sono iniziative private che hanno già rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni, come la rete satellitare a bassa orbita della già citata SpaceX, capace di portare internet ad alta velocità in quasi ogni angolo del pianeta. Dall’altra, l’Unione europea ha deciso di investire in un sistema comune che assicuri sovranità e sicurezza: un’infrastruttura che possa servire governi, istituzioni e cittadini con standard di protezione elevati. In questo contesto, il progetto italiano trova la sua collocazione come tassello di una strategia più ampia, in cui coesistono esigenze nazionali, alleanze europee e relazioni con operatori privati.
Perché serve un’infrastruttura autonoma
La crescente instabilità internazionale, unita alla vulnerabilità delle infrastrutture fisiche come i cavi sottomarini, ha reso evidente quanto le comunicazioni satellitari siano strategiche. Nei documenti programmatici del Ministero della Difesa – come il Documento programmatico pluriennale della Difesa 2024-2026 (DPP) – lo spazio è ormai indicato come un “dominio operativo” a tutti gli effetti, al pari della terra, del mare e dell’aria. L’obiettivo è garantire capacità resilienti, ridondanti e sotto pieno controllo nazionale, senza rinunciare alla possibilità di integrarle con quelle degli alleati NATO e dell’Unione Europea.
L’Italia si è mossa su tre fronti principali. Il primo riguarda la continuità delle comunicazioni attraverso satelliti geostazionari, cioè posizionati a circa 36.000 chilometri di quota e in grado di rimanere fermi rispetto a un punto sulla Terra, ideali per fornire collegamenti stabili su vaste aree. Il secondo fronte è la sperimentazione di satelliti in orbita bassa terrestre (Low Earth Orbit, LEO), posti a poche centinaia di chilometri dal suolo, che offrono tempi di latenza molto ridotti e quindi trasmissioni più rapide, particolarmente utili in operazioni tattiche. Il terzo è il potenziamento della sorveglianza spaziale, per monitorare e proteggere i satelliti italiani da rischi come collisioni o interferenze.

Il programma SICRAL 3 e le capacità “ponte”
Il progetto si chiama SICRAL 3, erede diretto dei sistemi geostazionari che da anni garantiscono le comunicazioni militari italiane. Nei piani approvati e discussi in Parlamento – come lo schema di decreto ministeriale A.G. 281 – SICRAL 3 dovrà rafforzare i requisiti di sicurezza, assicurare la continuità del servizio quando i satelliti attuali raggiungeranno la fine della loro vita operativa e affrontare la crescente difficoltà di trovare lanciatori e posizioni orbitali libere. Le missioni prioritarie comprendono il supporto al comando e controllo delle forze armate, la trasmissione di dati tra sistemi terrestri, navali e aerei – compresi i velivoli senza pilota – e l’integrazione con le reti nazionali di comunicazione in fibra ottica in caso di emergenza.
Per coprire il periodo che separa il pensionamento degli asset esistenti dall’entrata in servizio di SICRAL 3, sono state avviate misure “ponte”: un sistema provvisorio per mantenere i diritti d’uso delle frequenze e della posizione orbitale, e un satellite chiamato SICRAL R-1, progettato per operare in banda SHF (Super High Frequency) e garantire il servizio in un arco temporale di transizione.
Accanto a questi asset geostazionari, è in corso la progettazione di una piccola costellazione sperimentale in orbita bassa, pensata per testare collegamenti ad alto flusso di dati e bassa latenza. Un approccio che guarda al futuro, quando le comunicazioni militari e civili potrebbero beneficiare della combinazione di più tipi di orbite, sfruttando i punti di forza di ciascuna. Il tutto a un costo non indifferente: con copertura – si legge nei documenti – totale del ministero della Difesa, la stima è di 767 milioni di euro, di cui 200 aggiungi di recente. Il tutto con appalti interamente nazionali e già siglati Thales Alenia e Telespazio, due tra le più importanti aziende nazionali del settore aerospaziale
Leggi anche: la galassia italiana della space economy
La rete globale di SpaceX
In parallelo al percorso nazionale, il settore privato ha aperto nuove prospettive. SpaceX ha costruito e lanciato migliaia di satelliti in orbita bassa, creando una rete capace di offrire connessioni internet ad alta velocità con tempi di risposta di poche decine di millisecondi. La copertura è globale e il servizio raggiunge ormai milioni di utenti, con applicazioni che vanno dalle aree rurali fino agli scenari di crisi.
Oltre alla versione commerciale, esiste anche una variante per usi governativi e militari (Starshield), dotata di misure di sicurezza aggiuntive e di possibilità di controllo più stretto sui dati. Questa flessibilità ha già dimostrato il suo valore in contesti operativi complessi, ma ha sollevato anche interrogativi sulla dipendenza da un fornitore privato straniero, con tutte le implicazioni politiche e strategiche che ne derivano.

Uno dei razzi Falcon con cui SpaceX lancia i satelliti della rete Starlink
IRIS²: il progetto dell’Unione europea
L’Unione Europea, consapevole della necessità di avere un’infrastruttura sicura e indipendente, ha avviato il programma IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). L’obiettivo è costruire un sistema multi-orbitale – cioè capace di utilizzare satelliti sia in orbita bassa sia in orbite più alte – per garantire servizi sicuri a governi, istituzioni, operatori di infrastrutture critiche e, in parte, anche ai cittadini.
IRIS² si distingue per la sua natura di partenariato pubblico-privato: l’Unione europea fornisce una parte consistente del finanziamento, mentre il resto arriva dagli Stati membri, dall’Agenzia spaziale europea e da operatori industriali. Questo modello mira a mantenere la catena di fornitura e la governance all’interno dell’Europa, riducendo il rischio di dipendenze esterne. La piena operatività è prevista per la fine del decennio, ma i primi servizi governativi dovrebbero essere attivati già nei prossimi anni.
Differenze e implicazioni
Il progetto italiano, IRIS² e la rete di SpaceX si muovono nello stesso settore, ma rispondono a logiche differenti. L’Italia costruisce un’infrastruttura su misura per le proprie esigenze di difesa e sicurezza, con l’obiettivo di controllare ogni anello della catena, dalla messa in orbita alla gestione operativa. L’UE punta a un sistema condiviso, dove più Paesi mettono insieme risorse e capacità per ottenere un servizio comune, riducendo i costi e aumentando la resilienza collettiva. SpaceX offre un servizio già pronto, flessibile e tecnicamente avanzato, ma con la variabile di una governance privata e straniera.
Queste scelte hanno conseguenze dirette anche al di fuori dell’ambito militare. Una rete satellitare autonoma può servire come canale di comunicazione per la protezione civile durante catastrofi naturali, come strumento per mantenere collegati ospedali e scuole in zone isolate o come dorsale di emergenza in caso di attacchi informatici alle reti terrestri.
Una sfida che va oltre la tecnologia
Dietro le antenne e le orbite ci sono anche considerazioni politiche ed economiche. Una costellazione nazionale stimola la filiera industriale interna, dalle grandi aziende fino alle piccole e medie imprese che forniscono componenti, software e servizi di supporto. I progetti europei rafforzano la capacità di negoziare come blocco unico sul piano internazionale e di difendere interessi comuni. I servizi commerciali privati, invece, spingono sull’innovazione e sulla velocità di implementazione, ma possono creare nuove forme di dipendenza.
Infine, c’è un elemento spesso sottovalutato: la gestione dello spazio come risorsa limitata. Le orbite basse sono sempre più affollate e il rischio di collisioni aumenta con ogni nuovo lancio. Ecco perché, parallelamente allo sviluppo di nuove capacità, l’Italia sta potenziando i sistemi di sorveglianza e tracciamento, fondamentali per garantire la sicurezza operativa e la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali.
Nei prossimi anni l’Italia dovrà completare il dispiegamento di SICRAL 3, rendere operative le capacità “ponte” e proseguire la sperimentazione LEO. L’Unione europea lavorerà per portare IRIS² a pieno regime, mentre le reti private continueranno a espandersi e a proporre nuove soluzioni tecnologiche.
Il punto cruciale sarà capire come far convivere queste tre dimensioni – nazionale, europea e privata – in un ecosistema che garantisca sicurezza, resilienza e accesso equo ai servizi. Perché nello spazio, come sulla Terra, la vera forza non sta solo nella potenza delle tecnologie, ma nella capacità di governarle in modo strategico, anche nei momenti più critici.