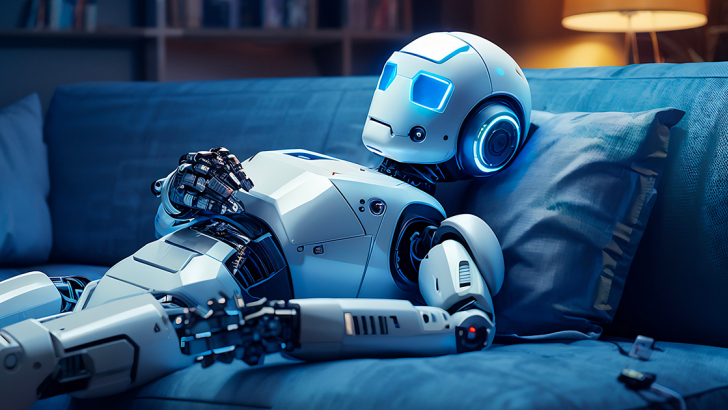Simulacri digitali: una guida critica alla realtà artificiale

Quando nel 1998 è uscito il film The Truman Show di Peter Weir, molte persone hanno fantasticato di vivere in un mondo costruito a loro misura, un mondo in cui un regista dava indicazioni a tutti gli altri personaggi che erano al servizio del protagonista e, soprattutto, della sua storia: il libero arbitrio ne veniva limitato, ma in compenso vivevi in un mondo “costruito intorno a te”, come avrebbe detto una famosa compagnia telefonica. Curiosamente, la realtà di oggi non è poi troppo diversa, ma su larga scala, in modo che non ci rimanga nemmeno la consolazione di essere le star. Quello che sta succedendo assomiglia sempre più a una fiction scritta da un algoritmo: le notizie sembrano trailer cinematografici, le immagini sono generate da AI, le risposte ai nostri dubbi arrivano da chatbot che sembrano sapere cose che noi non sappiamo, quando in realtà si limitano a combinare dati simulando una conoscenza che, in quanto macchine, non possono avere. In questo scenario, Simulacri digitali di Andrea Daniele Signorelli (add editore, 2025) diventa una mappa per orientarsi in una giungla di narrazioni sensazionalistiche, che rischiano di farci perdere di vista i rischi più immediati delle nuove tecnologie.
Signorelli parte da un presupposto chiaro: “Nel grande pubblico – ci spiega – c’è un enorme confusione su cosa sia l’intelligenza artificiale a quali saranno i suoi effetti, ma questa confusione è causata soprattutto da chi dovrebbe fare divulgazione su questi argomenti”. Tra sensazionalismi che fanno sembrare i giornali uffici stampa delle aziende tech e, di contro, millenaristi che non perdono occasione per ripetere il loro motto “moriremo tutti”, il tentativo dell’autore è quello di fare divulgazione senza allarmismi, ma senza nemmeno cadere nell’ingenuità dei vari tecno-entusiasti (che solitamente, guarda te le coincidenze, sono i CEO di aziende del settore).
“ Le persone che lanciano allarmi sul rischio posto dalle AI sono quasi sempre le stesse che questi sistemi li stanno sviluppando: che senso ha? Andrea Daniele Signorelli
Al riparo dal sensazionalismo digitale
Nel libro si affrontano i grandi temi del presente digitale (intelligenza artificiale, deepfake, zero-click web, realtà aumentata, chatbot empatici, immortalità digitale) ma non con l’approccio da “moriremo tutti per colpa dell’AI” o “tutto sarà meraviglioso”. Il tono è critico, ma sempre equilibrato, e anzi, spesso lo è controcorrente: Signorelli rifiuta le narrazioni da fine del mondo, quelle in cui l’intelligenza artificiale assume tratti quasi divini, e smonta con metodo anche la tentazione millenarista della “superintelligenza”.
“Il racconto giornalistico dell’IA – ci spiega – è dominato dal sensazionalismo: si scelgono titoli clamorosi, generando caos dove invece ci sarebbe bisogno di chiarezza, perché i giornali guadagnano dai click. Inoltre buona parte del giornalismo tecnologico si limita a fare da megafono ai comunicati stampa sensazionalistici delle aziende tech, manca uno spirito critico.”
Dal libro risulta evidente che l’autore si è ben inserito in questo vuoto informativo, scrivendo in modo accessibile, ricco di esempi, ma senza rinunciare al rigore, così il testo risulta interessante sia per chi non sa nulla di nuove tecnologie sia per chi le conosce bene ma vuole approfondire per sviluppare meglio il proprio punto di vista. Insomma, è una lettura consigliata a chiunque voglia capire il presente senza farsi travolgere dal rumore.
Le profezie che si autoavverano (e che puzzano di marketing)
Uno dei concetti chiave del libro è quello di “profezia che si autoavvera”: le big tech annunciano una rivoluzione, creano attesa, attraggono investimenti e poi realizzano ciò che avevano previsto, o almeno ci provano, come è successo con il metaverso, ed è proprio da lì che nasce l’idea del libro: “Quando si è cominciato a parlare di metaverso – dice Signorelli – mi si è accesa una lucina, perché è stato un esempio clamoroso di come le big tech creino uno storytelling scollegato dalla realtà.”
Presentato come la prossima grande rivoluzione digitale, destinata a cambiare il modo in cui lavoriamo, socializziamo e consumiamo cultura, il metaverso ha generato investimenti miliardari, convegni, saggi e campagne pubblicitarie, salvo poi sgonfiarsi nel giro di pochi mesi. Oggi se ne parla poco: gli ambienti del metaverso sono semideserti, i visori restano di nicchia e perfino Meta, l’azienda che aveva puntato tutto su questa innovazione, come fa intendere il cambio di nome, sembra aver riallineato la rotta, rimandando il discorso a tempi futuri, magari mutuandolo nella costruzione di una realtà aumentata, strada più praticabile appena ci saranno dei visori adeguati.
La dinamica si sta ripetendo con l’intelligenza artificiale generativa: il futuro viene costruito non tanto con la ricerca, ma con le parole, perché le narrazioni non descrivono ciò che abbiamo al momento, ma servono a orientare il presente sia dal punto di vista economico che politico, per sviluppare un futuro in cui le grandi aziende possano perseguire i propri obiettivi grazie a nuovi finanziamenti.
Quando “Moriremo tutti” è una buona notizia
Nel libro non si parla solo di AI, ma anche delle altre recenti ossessioni della Silicon Valley, tra cui quella della vita eterna ottenuta tramite biotecnologie, digitalizzazione della coscienza o avatar senzienti.
Per ora è ancora fantascienza, ma fa sorgere spontanea una domanda: sarebbe una bella cosa? Dipende dai punti di vista, ma la letteratura e il cinema ci hanno già messi in guardia in tempi non sospetti. Alla base delle ricerche della Silicon Valley si nasconde una visione dell’umano come macchina da ottimizzare, da perfezionare fino all’eliminazione di ogni fragilità, morte compresa. Ma se la eliminiamo, togliamo anche il senso ultimo della vita: il tempo si appiattisce, se diventa eterno, e il desiderio si spegne, perché in realtà la mortalità non è un bug da correggere, ma una condizione che dà valore a ciò che facciamo. Un eterno presente digitale, governato da routine algoritmiche, somiglia più a una prigione che a una conquista, e così, inaspettatamente, il “moriremo tutti” dei tecnofobici suona quasi come una buona notizia.
Anche perché, come scrive Signorelli, diventare immortali non significa provare meno ansia, anzi: in questo ipotetico futuro, la morte non sarebbe totalmente cancellata, ma solo ritardata, anche di molto, oppure sopravviveremo in un’altra forma, trasferendo la nostra coscienza in una macchina. Ma siamo sicuri che rinunciare al corpo sia così secondario? Perché anche se diventassimo immortali rimarremmo danneggiabili: così il rischio di morire per un incidente qualunque diventerebbe insopportabile, perché toglierebbe qualcosa a cui sentiremmo di avere diritto, e magari non riusciremmo più ad accettare il banale rischio di attraversare una strada: se la morte non è più biologicamente necessaria, diventa qualcosa che può solo arrivare dall’esterno, in modo improvviso, ingiusto, assurdo.
L’IA come religione, ma senza paradiso
Un altro tema centrale del libro è il modo in cui l’AI ha assunto nella narrazione tratti quasi spirituali. Si parla di eventi “singolari”, di entità “superiori”, di intelligenze “generali” e il culto dell’intelligenza artificiale sta sostituendo la religione in certi ambienti: il linguaggio usato è escatologico, le promesse sono salvifiche, i leader delle aziende si trasformano in profeti.
Come nella maggior parte dei culti, la divinità non è ben definita, e anzi assume tratti opachi. “Una volta – racconta Signorelli – ho letto un’intervista a Satya Nadella, CEO di Microsoft, in cui, alla domanda 'Cos’è l’intelligenza artificiale generale?', lui ha risposto: 'Nessuno può dirlo'. Naturalmente ne è uscito un articolo che era tutto una celebrazione, quando in realtà è un concetto così remoto che nessuno sa cosa sia, quindi stiamo parlando del nulla”.
Ma se l’AI diventa una sorta di divinità, ci tocca sospendere il metodo scientifico, che alla fede non si applica, e quindi via libera al marketing travestito da mistero, perché quando usciamo dall’ambito scientifico vale tutto, senza possibilità di dibattito. Il problema è che nel frattempo si ignorano criticità molto più immediate: discriminazioni nei modelli, stereotipi di genere, razzismo, sistemi di sorveglianza, predittiva e non. “Il rischio non è che l’IA ci distrugga – commenta Signorelli – ma che venga usata male, da chi ha potere, per rafforzarlo.”
Il futuro del giornalismo
Il libro dedica ampio spazio anche a Google con il suo progetto di “zero-click search” cioè la tendenza a fornire direttamente tutte le informazioni richieste dall’utente nella pagina dei risultati di ricerca, senza bisogno di cliccare su un link esterno. Il problema è che i siti da cui Google prende le informazioni non ricevono visite, e quindi nemmeno entrate pubblicitarie: per quanto continueranno a produrre contenuti utili? E dove andrà a pescare Google quando queste informazioni non ci saranno più?
“ Ciò potrebbe condurci a una versione più piccola di internet, con meno siti, meno contenuti, e di conseguenza una peggiore esperienza per tutti Justin Pot
Amazon, dal canto suo, è invaso da pseudo-libri scritti in massa da intelligenze artificiali: un surrogato che costa meno, si produce più in fretta, ma ha anche un valore esiguo.
Eppure, anche qui, Signorelli non cede alla tentazione del panico, pur essendo giornalista: forse esiste uno spiraglio, e proprio l’invasione di questi contenuti ci renderà più consapevoli. Magari cominceremo a pagare per accedere a contenuti di qualità, a cercare fonti affidabili, a leggere newsletter indipendenti o a tornare nelle librerie vere, in modo da non soccombere all’invasione dei contenuti un tanto al chilo.
Un ruolo importante, in questo nuovo panorama, lo giocherà la reputazione del giornalista: “Il giornalista del futuro sarà anche filtro – dice Signorelli – perché dovrà fare da bussola aiutando i lettori a distinguere ciò che è vero e ciò che non lo è”.
Non sarà comunque una transizione indolore: “In questo processo – chiarisce Signorelli – temo che verrà sacrificato il citizen journalism, cioè quel giornalismo fatto dal basso da persone che grazie a un semplice smartphone potevano documentare e pubblicare quello che succedeva attorno a loro: mano a mano che i contenuti generati automaticamente diventeranno sempre più credibili e sempre più diffusi è ovvio che se non hai una reputazione che ti precede i materiali che posti finiranno per essere facilmente confusi con contenuti generati da AI, quindi questo tipo di giornalismo perderà tutta la sua credibilità. È un peccato, perché così rischiano di essere ignorate realtà fondamentali”.
Un saggio necessario (e scritto bene)
Durante la lettura del libro e la chiacchierata con l’autore, emerge un punto fermo, quasi scomodo nella sua semplicità: non esiste un antidoto miracoloso, nessuna app che ci salvi dal rischio di diventare meno umani o di credere nelle illusioni che l’AI e le aziende leader del settore distribuiscono ogni giorno. L'unica forma di difesa, per quanto possa sembrare deludente, è la consapevolezza.
Essere consapevoli che i sistemi di IA non sono entità pensanti ma strumenti statistici; che rispondono alle nostre domande partendo dai dati che gli abbiamo dato noi, e che seguono le nostre stesse narrazioni; che non apprendono come apprendiamo noi, ma simulano un apprendimento che è frutto di correlazioni e probabilità. Consapevoli che ogni tecnologia con cui interagiamo tende a restituirci un riflesso: di noi, dei nostri comportamenti, delle nostre aspettative, e che questo riflesso finirà per condizionare il nostro modo di pensare, parlare, scrivere e perfino di entrare in relazione gli uni con gli altri.
Non si tratta di demonizzare l'intelligenza artificiale, né di sognare un ritorno nostalgico quanto irrealizzabile a un passato in cui non c’era nulla di tutto ciò. Si tratta di imparare a guardare l’AI per quello che è, senza antropomorfizzarla, senza attribuirle intenzioni che non possiede: solo così possiamo sperare di governarne l'impatto, invece di subirlo.
Il messaggio finale è chiaro: non c'è un'unica via da seguire, e nemmeno un destino già scritto. Non tutto è inevitabile, e proprio per questo è urgente cominciare a discutere, decidere, regolare e immaginare il futuro. Prima che il simulacro prenda definitivamente il posto della realtà.