Le angolature sulla letteratura di Valerio Calzolaio
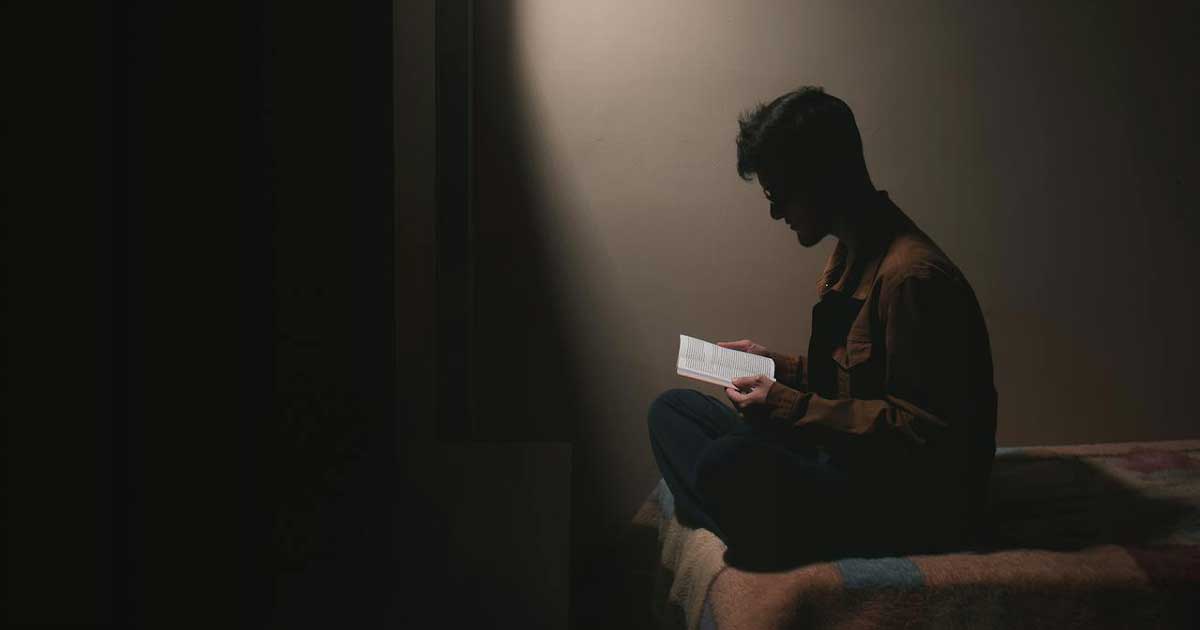
Valerio Calzolaio con Angolature noir, il suo saggio appena uscito per Linea Edizioni, in cui raccoglie molto di quello che ha scritto su questo giornale, fa un’operazione veramente interessante, a riprova che la riflessione sulla scrittura e sulle scritture non è mai fine a se stessa: mette cioè in fila una serie di conoscenze, approfondimenti e punti di vista sulla letteratura gialla e noir (sostanzialmente) contemporanea e, come effetto secondario, ottiene di dare un panorama estendibile alla letteratura tutta.
Certo, leggendolo veniamo a sapere, per esempio, che il primo a nascere è stato il romanzo giallo, e che lo chiamiamo così solo in Italia per opera del colore della copertina della collana Mondadori, mentre nel resto del mondo viene appellato pressappoco sempre come “romanzo criminale” (qui fortunato titolo del fortunato romanzo – e poi della serie – di Giancarlo De Cataldo); che il noir gli è seguito come ampliamento e derivazione però di altro, su tutti l’hard boiled americano, e che, di fatto, oggi domina il mercato (la cosiddetta “globalizzazione del noir”), con la sua disamina della “commedia umana”, oltre che mettendo sulla pagina “l’irrisolta contraddizione mentale e pratica di vari individui in un ecosistema sociale criminale”; nelle sue pagine possiamo leggere vita, opere, scelte e vicende di grandi romanzieri, da Vargas a Izzo, da Agatha Christie a Ed Mc Bain, passando per Pennac, Nesbø, Don Winslow, Qiu Xialong e molti altri; ma c’è, nella penna e nell’occhio critico di Calzolaio, molto di più.
A venire indagato è il gesto primigenio della scrittura e insieme della lettura, portando ora in primo ora in secondo piano la “questione del genere”. Si parte da un dato inconfutabile: “La maggior parte degli individui nostri coevi non legge abitualmente almeno un libro cartaceo ogni mese, nemmeno la maggioranza degli alfabetizzati, nemmeno considerando il tablet o altra tecnologia visuale, per più ragioni. Fra la minoranza che legge, il genere con maggiore mercato globale è il romanzo con criminali e investigatori, killer e poliziotti, e i loro affetti, nella forma di un interrogativo delittuoso e di risposte indagatorie. […] La concorrenza quantitativa del successo del crime è con il “rosa””. Basta guardare le classifiche di vendita: è proprio così. Comprenderne la ragione non è prettamente lo scopo di questo saggio: a ciascuno sta il compito, se vuole, di darsi risposta e forse dovremmo chiederla a un sociologo più che a un critico letterario, o piuttosto, per certi versi, a un esperto di marketing, considerando che gli editori ci mettono del loro nel selezionare, cavalcando una tendenza o approfittando della visibilità offerta da altre forme espressive come il cinema o la traduzione televisiva; in ogni caso Calzolaio chiosa: “Alcuni di noi che prediligiamo narrazioni noir siamo convinti che l’unico genere sia la narrativa (non in forma di versi) di finzione (con mille sottogeneri): la distinzione di fondo è fra saggi e romanzi, poi molto diventa aleatorio e fluttuante. Magari non ci sono romanzi generalisti o di genere, romanzi convenzionalmente mainstream e romanzi di genere, ci sono romanzi lunghi e brevi, scritti da uomini e da donne, nella nostra lingua o tradotti, per ridere e per piangere, belli e brutti (a seconda pure di scelte, gusti, occasioni e casi) che trattano argomenti (narrati come finzione letteraria) che ci interessano più o meno in quella fase della vita di lettori”. E ancora, diverse pagine dopo: “In linea di massima lettori e non lettori sanno cosa differenzia un romanzo da una poesia o da un saggio e, fra romanzi, cosa accomuna romanzi rosa, di fantascienza, gialli, di formazione, storici, d’avventura, fantasy, d’umorismo, horror erotico, noir. O, almeno, quelli del genere che leggono loro e di cui sentono parlare. Qualche volta prendono il libro in mano proprio perché sono interessati al genere presunto; altre volte non lo prendono per l’opposta ragione”.
E allora viene voglia di chiedersi diversi perché – sulla fortuna di un genere, di un autore, di un titolo, o sulla sfortuna della letteratura tutta che, in fatto di mercato, non gode sempre di ottima salute. Calzolaio è chirurgico: “La scrittura non è scienza esatta, dipende dall’incipit che aggancia, da struttura stile trama ritmo che reinterpretano e ristrutturano la realtà: evocare e non enunciare, suggerire senza declamare, non sentenziare, accennare sentimenti rifuggendo il sentimentalismo, muoversi nelle terre di nessuno tra i generi”.
Questa è la grandezza della letteratura. Che ha a che fare con qualcosa di privato e di collettivo contemporaneamente, che permette di tenere insieme il particolare e l’universale (Calzolaio ci insegna anche come questo avvenga nei finali: per induzione, deduzione o abduzione: quest’ultima significa dal caso all’universale), proprio perché la lettura e la scrittura operano nell’universo dell’io e in quello del noi simultaneamente. A questo proposito vale la pena riportare le dell’autore sul legame strettissimo tra queste due attività: “L’uovo è la scrittura e la gallina la lettura, non l’inverso, anche se poi il ciclo è continuo. Abbiamo cominciato a comunicare molto prima di scrivere e a scrivere prima di leggere (e far leggere) quanto avevamo scritto; […] al di là dell’utilità, del dovere e del piacere, il funzionamento del cervello e il susseguirsi dei giorni risultano biologicamente dipendenti dalla lettura (e scrittura)” e infine: “La scrittura attiva una nuova logica del pensare, del comunicare, del trasmettere, non limitata a chi esercita quelle azioni e arti”. E in effetti siamo lettori perché qualcuno scrive e si può essere scrittori a patto di avere un pubblico che legge, ma, tutti insieme, costituiamo una collettività che viene modificata dal gesto della scrittura.
E infatti apriva così la sua introduzione Valerio Calzolaio, dicendo: “Siamo abituati a raccontarci storie [e] abbiamo reso la faccenda molto sofisticata”. Ecco, questo è il bello. Che oltre a seguire quell’istinto di spiegarci la vita attraverso la finzione è possibile anche, come fa Calzolaio, scandagliarla quella sofisticazione, e, una volta in più, approfondire la bellezza del nostro essere umani dotati di linguaggio e fantasia.
“ Siamo abituati a raccontarci storie [e] abbiamo reso la faccenda molto sofisticata Valerio Calzolaio









