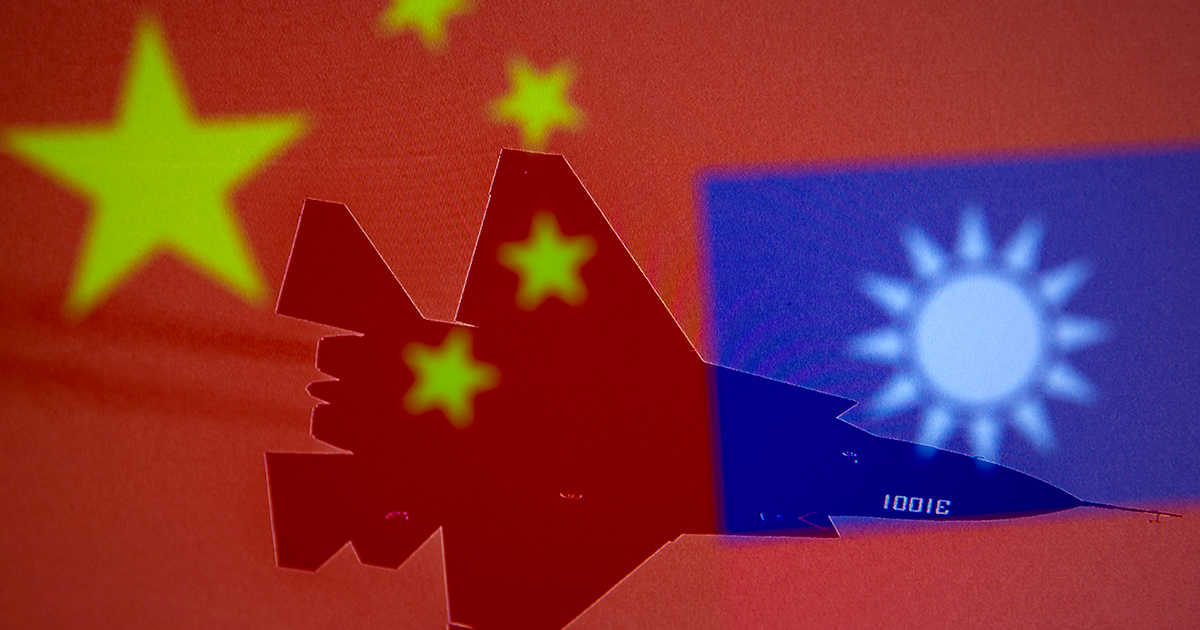
Foto: Reuters
Gli allarmi suonano sempre più insistenti lungo lo stretto di Taiwan (Formosa). Al momento sono soltanto parole, al netto di qualche dimostrazione militare sopra le righe dell’aviazione cinese (28 aerei da guerra hanno violato pochi giorni fa lo spazio aereo dell’isola). Ma la situazione è seria, serissima. Al punto da mandare in fibrillazione le diplomazie di mezzo mondo. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, ha deciso (per ora soltanto a parole) di accelerare sul progetto di riunificare le due Cine: quella comunista del continente e quella democratica e separatista di Taiwan, la ROC, Republic of China (oggi riconosciuta soltanto da 14 dei 193 Paesi dell’ONU, oltre alla Città del Vaticano). «Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina è una missione storica e un impegno incrollabile», ha ribadito Xi con l’abituale enfasi nel suo discorso durante la celebrazione del centesimo anniversario dalla fondazione del partito comunista cinese, a Pechino, in piazza Tiananmen. Ma come? E a quale prezzo? Xi pubblicamente auspica una “riunificazione pacifica” basata sul principio che esiste “una sola Cina”, ma al tempo stesso lancia la sua minaccia al governo separatista di Taiwan e alle forze straniere: «Nessuno dovrebbe sottovalutare la risolutezza, la volontà e la capacità del popolo cinese di difendere la propria sovranità nazionale e l’integrità territoriale. Non esiteremo a schiacciare qualsiasi complotto per l'indipendenza di Taiwan. Qualsiasi forza straniera che tenterà d’intromettersi dovrà scontrarsi con una grande muraglia d’acciaio».
Il Giappone alza la voce
Sul punto la questione diventa ancor più delicata. Perché l’avvertimento cinese va a colpire direttamente le diplomazie di Usa e Giappone. Con gli Stati Uniti che, pur non riconoscendo formalmente Taiwan come Stato e mantenendo negli anni un ruolo ambiguo, hanno appena mosso nuovi passi formali per riallacciare rapporti commerciali con i rappresentanti di Taipei, naturalmente da sfruttare in funzione anti-cinese (obiettivo numero uno della politica estera impostata dalla presidenza Biden). In una nota il Dipartimento di Stato americano (che ai taiwanesi garantisce forniture di armi) ha risposto alle dichiarazioni del presidente cinese, ribadendo il sostegno degli Stati Uniti a una “risoluzione pacifica” della questione dello Stretto di Formosa: «Esortiamo Pechino a cessare la sua pressione militare, diplomatica ed economica contro Taiwan e a impegnarsi invece in un dialogo significativo». Mentre il Giappone ha improvvisamente smarrito il suo abituale autocontrollo, probabilmente temendo che un atto di forza cinese nei confronti di Taiwan possa essere soltanto il preludio al tentativo di riconquista “muscolare” delle isole Senkaku (minuscoli atolli disabitati nel Mar Cinese Orientale, controllati dai giapponesi e ricchi di giacimenti di gas e petrolio: qui c’è la storia del contenzioso con la Cina che ne rivendica il dominio). Un timore talmente marcato da spingere il vicepremier giapponese Taro Aso a una dichiarazione netta e inusuale, rilasciata all’agenzia di stampa Kiodo: «Se la Cina dovesse invadere Taiwan il Giappone si schiererebbe a fianco degli Stati Uniti per difendere l’isola», ha dichiarato. Per poi aggiungere: «Qualora si verificasse un grave problema a Taiwan, non sarebbe eccessivo dire che si potrebbe trasformare in una situazione di pericolo per la stessa sopravvivenza del Giappone». Dichiarazione che ha provocato qualche imbarazzo a Tokyo e che non è piaciuta affatto a Pechino. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha sostenuto che le osservazioni di Aso «hanno danneggiato il fondamento politico delle relazioni tra Cina e Giappone», ripetendo poi la solita minaccia dettata dal presidente Xi Jinping: «Nessuno dovrebbe sottovalutare la ferma determinazione e la formidabile capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale».
Un rischio incalcolabile
Insomma, parole pesanti. E toni che non consentono di escludere l’eventualità di un conflitto dalle conseguenze incalcolabili. Ma perché la Cina dovrebbe rischiare una guerra mondiale per conquistare l’isola di Taiwan? Il governo nazionalista dell’RCO, per quanto una spina nel fianco di Pechino, non è al momento una minaccia, né da un punto di vista militare né economico (i rapporti di scambio tra Cina e Taiwan sono assai floridi), anche se il maggior asset di Taipei, l’industria dei microchip (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. fornisce semiconduttori ai più grandi colossi del pianeta, da Apple a Google) fa gola a molti. Quindi più per motivi ideologici, più per la rincorsa ostinata alla narrazione dell’unica “grande Cina” che per un concreto tornaconto da incassare. Anche se il controllo di Taiwan potrebbe essere fondamentale come strategia marittima, per mantenere un accesso al Mar del Giappone, e quindi all’Oceano Pacifico settentrionale. E ora tutti a chiedersi: sarà un bluff o Xi Jinping fa sul serio? E in questa seconda ipotesi, chi reagirà e come? Intanto la rivista cinese Naval and Merchant Ships ha pubblicato un articolo nel quale si dà conto di un piano dettagliato per un attacco a sorpresa, in tre fasi, contro “la provincia rinnegata” di Taiwan, da “restituire al controllo della Repubblica Popolare Cinese”, se necessario con l’uso della forza. Lo “schema”, attribuito al People’s Liberation Army (PLA), le forze armate di Pechino, stabilirebbe in una prima fase l’impiego di missili balistici a corto raggio (lo stretto di Formosa è largo 180 chilometri) con l’obiettivo di distruggere i radar di primo allarme, le basi antiaeree, gli aeroporti e i centri di comando dell’esercito di Taiwan. Il secondo step vedrebbe l’impiego di missili da crociera mirati verso basi militari, depositi di munizioni, infrastrutture, centri di comunicazione e nodi stradali di particolare importanza. La terza fase prevedrebbe lo sbarco sull’isola delle truppe cinesi, e la conquista dei centri nevralgici. Nell’articolo non si fa alcun riferimento a eventuali interventi stranieri a difesa di Taiwan.
Un bluff? Una provocazione? Lo scenario è minaccioso, non c’è dubbio, anche se restano ancora parole, ipotesi. Che legittimano la domanda successiva: come reagirebbero gli Stati Uniti se la Cina invadesse l’isola? Davvero sarebbero pronti a imbarcarsi per una missione militare così complessa e pericolosa? Va detto che l’ipotesi dell’invasione cinese non è nuova. E probabilmente l’uscita pubblica del presidente cinese proprio questo si propone: testare il grado di reazione internazionale. Capire chi reagisce e come. Ed è per questo che i toni si alzano, come in una simulazione di quel che potrebbe accadere. Kurt Campbell, coordinatore per gli affari indo-pacifici del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, si è subito esposto senza mezzi termini: «Qualsiasi tentativo della Cina di spostarsi su Taiwan avrebbe effetti catastrofici». L’operazione militare, peraltro, non sarebbe semplice da gestire per Pechino. Prima attraversare i 180 km di mare che separano la terraferma dall’isola, esposti a bombardamenti aerei e navali; poi vincere la resistenza locale al netto di una conformazione geografica della costa assai aspra, con poche spiagge, con il rischio di improvvise mareggiate. «Sarebbe più difficile dello sbarco in Normandia», hanno concluso diversi analisti. Qualcuno sostiene che il momento sarebbe tatticamente perfetto per un attacco cinese, con la pandemia a distrarre le opinioni pubbliche e i governi, con un rischio oggettivo di conflitto mondiale (il prezzo da pagare sarebbe incalcolabile) che realmente non gioverebbe a nessuno, (sempre ammesso che tutti ricorrano alla ragione in momenti simili). Ma, di contro, c’è chi sostiene che in questo modo la Cina si isolerebbe ulteriormente, stretta com’è già oggi dalle alleanze delle “forze democratiche” (Usa, Onu, Ue, Quad, Asean) rimarcate da Joe Biden. La conquista militare di Taiwan potrebbe trasformarsi così in un boomerang per Pechino, e ampliare (anche commercialmente) il solco che già la divide, anche ideologicamente, dal resto del mondo. Converrebbe alla Cina esasperare gli animi al punto da mettere a rischio il futuro delle sue innumerevoli “vie della Seta”?
La strategia Usa: bloccare l’espansione cinese
Bisogna anche dire che agli Stati Uniti non interessa poi molto il futuro di Taiwan in quanto Stato (ma sarebbero prontissimi a offrire asilo politico a migliaia di ingegneri e programmatori per ricostruire negli States le aziende specializzate in microchip: mossa che garantirebbe una straordinaria supremazia nel settore). Mentre è prioritario contenere la politica di espansione della Cina nelle isole del Pacifico, che garantirebbe a Xi un predominio assai pericoloso nell’area. Quindi l’obiettivo della Casa Bianca sarà ostacolare qualsiasi mossa che possa preludere all’espansione del dominio cinese. Ma la partita è a tre: perché Taiwan, che fa parte della “prima catena di isole” (quindi la prima, in teoria, a poter essere attaccata), potrebbe addirittura sfruttare a proprio vantaggio questa escalation di tensione per rinsaldare la sua posizione a livello diplomatico, e ottenere quel riconoscimento internazionale, proprio in quanto rappresentante delle “forze democratiche”, che finora è mancato.
Taiwan, 23 milioni di abitanti che da oltre settant’anni sono abituati a vivere sotto la minaccia cinese (qui la storia del suo passato coloniale, della guerra civile cinese e della fuga a Taipei, nel 1949, delle truppe di Chiang Kai-shek, respinte dall’esercito comunista di Mao Zedong) è una delle economie più floride al mondo: nel 2020, in piena pandemia, il PIL di Taiwan è aumentato del 3,11%, a fronte di una media globale che ha segnato un meno 4,5%, con un tasso di crescita perfino superiore a quello cinese. Il 44% delle sue esportazioni è diretto proprio in Cina (in aumento del 12% rispetto al 2019) con una punta nel settore dei semiconduttori (dovuta all’impennata delle richieste a livello mondiale di prodotti elettronici, a causa della proliferazione in ogni angolo del pianeta dello smart working e della didattica a distanza): e la Cina, da sola, non riesce a produrne più del 20%. Taiwan e la Cina, da un punto di vista industriale e commerciale, hanno perciò bisogno l’una dell’altra. Pechino in passato aveva proposto l’attuazione della formula già usata a Hong Kong “un paese, due sistemi”, in base alla quale Taiwan avrebbe ottenuto un'autonomia significativa se avesse accettato la riunificazione cinese. Offerta più volte respinta da tutti i partiti politici taiwanesi. Lo scorso anno la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, leader del Partito Democratico Progressista, aveva dichiarato: «Non possiamo accettare di entrare a far parte della Cina con la sua offerta di autonomia. Entrambe le parti hanno invece il dovere di trovare un modo per coesistere a lungo termine e prevenire l’intensificarsi dell’antagonismo e delle differenze. Pace, parità, democrazia e dialogo: non accetteremo la formula “un paese, due sistemi” per declassare Taiwan e minare lo status quo nello Stretto». Convinzione oggi ancor più radicata dopo quanto accaduto lo scorso anno proprio a Hong Kong, con la decisione di Pechino di schiacciare con la forza la protesta democratica. Questione di fiducia, ormai definitivamente persa. E pochi giorni fa la stessa presidente, che ama dire le cose con chiarezza, ha ribadito: «Taiwan non dimenticherà mai la repressione cinese di Tiananmen». Come dire: non ci convincerete mai. Solo un’azione di forza potrebbe riunificare le due Cine. Ma il prezzo da pagare sarebbe comunque smisurato.




