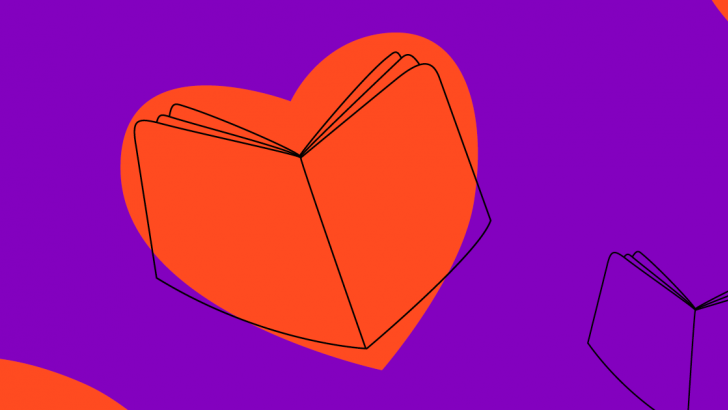In tempi di coronavirus tutto s’intreccia e si sovrappone, le tesi del virologo contro quelle di un altro virologo, le tesi verificabili della medicina e della scienza e quelle complottiste, ritornano paura e superstizione: vecchie teorie miasmatiche risorgono, qualcuno riprende mano l’Apocalisse e ci richiama alla penitenza e alla conversione (è sufficiente visitare i profili FB di cattolici integralisti). La moltiplicazione dei punti di vista è incontrollata, nessuno rinuncia dal dire la sua, neanche un filosofo oracolare come Giorgio Agamben che scrive un articolo superfluo (Il manifesto del 26 febbraio) in cui, applicando categorie come quella schmittiana di ‘stato di eccezione’, si scambiano prudentissime misure di profilassi e di tentativo di limitare la diffusione del virus come “gravi limitazioni della libertà”. I modelli matematici e statistici ci rassicurano sul fatto che la mortalità è molto bassa e che ne ammazza più un’influenza stagionale, ma evidentemente non basta a renderci razionali e prudenti senza perdere il controllo di noi stessi. Gesti quotidiani come pulire una superficie o lavarsi le mani diventano rituali salvifici.
Al di là della scienza e delle rassicurazioni quello che spaventa non è l’ignoto come poteva capitare nei secoli passati, sebbene si tratti di una minaccia virale non ancora completamente conosciuta per cui non c’è ancora un vaccino; quello che ci turba è l’ampiezza e l’ovvietà dei vettori della malattia: stringere mani, giocare a carte in un bar, tenersi ai corrimano di bus e metropolitane, il passaggio della cartamoneta, lo starnutire di chi ci sta accanto. Circostanze come queste che stiamo vivendo in Italia rappresentano un laboratorio sociale in cui si possono osservare le reazioni degli umani e dell’opinione pubblica, il grado di lucidità dei nostri politici e quello dell’organizzazione delle strutture sanitarie e si può subito notare come la potenza di una passione come la paura, per usare un linguaggio spinoziano, prevale sulla ragione e ci spinge all’assalto dei centri commerciali e a fare scorte di pasta, tonno e amuchina.
La letteratura ancora una volta ci permette di comprendere psicologie e reazioni di massa e i nomi evocati, a ogni epidemia vera o presunta, sono Manzoni, Tucidide, Boccaccio, Defoe, qualcuno aggiunge La peste di Albert Camus o The scarlet plague (1912), il romanzo di Jack London ambientato nel 2013 in cui si racconta di una malattia chiamata ‘peste scarlatta’ che elimina quasi del tutto il genere umano. I più colti potranno spingersi anche alla spaventosa ceroplastica di Gaetano Giulio Zumbo, scultore barocco che rappresentava nel Seicento corpi disfatti dalla peste con realismo impressionante. Nelle pagine degli autori prima elencati si racconta di autentiche e devastanti epidemie che non hanno confronto con il coronavirus che, nonostante la sua bassissima mortalità e drammaticità, non va sottovalutato. Forse non ha del tutto torto Alex Broadbent, autore di una Philosophy of epidemiology (uscita nel 2013 per Palgrave Macmillan), a lamentare l’assenza di nozioni di epidemiologia come momento di formazione della coscienza civica.
Sempre su epidemie veramente apocalittiche si potrebbero rileggere le pagine di un capolavoro del Novecento come Massa e potere di Elias Canetti uscito in Germania nel 1960 e tradotto in italiano nel 1981 da Furio Jesi per Rizzoli. In Massa e potere Canetti, premio Nobel per la letteratura nel 1981, indagava da antropologo contemporaneo il nesso che univa il potere, la paura e la morte attraverso l’esperienza assolutamente moderna della massa. Canetti legava il senso originario del potere pre-politico alla sopravvivenza e cerca di descrivere una scena originaria e fondativa: è vero ogni uomo ha paura della morte ed è altrettanto vero che questa è sempre sperimentata negli altri. In chi resta vivo di fronte alla morte altrui si celebra, visibilmente o occultamente, anche un sentimento di potenza, si pensi a quell’autorevolezza esistenziale che il morente Ivan Il’ič, il protagonista dell’immenso racconto di Tolstoj , riconosce e odia nei viventi che lo circondano, tranne quella del buon servo Gerasim: “La salute, il vigore, la prestanza vitale di tutti altri offendeva Ivan Il’ič; solo la forza e la prestanza di Gerasim non lo amareggiava, e anzi gli dava quiete”. Canetti ritiene, forse con un eccesso di generalizzazione, che la massa, cioè una somma di comportamenti comuni all’origine di ogni civiltà, si generi e si concretizzi dall’orrore del contatto reciproco con l’altro e dalla paura dell’ignoto e della morte, più esattamente nelle masse il singolo esorcizza i propri limiti individuali e “può essere redento dal timore d’essere toccato […] dal momento in cui ci si abbandona alla massa, non si teme d’esserne toccati. Nel caso migliore, si è tutti uguali […] chiunque ci venga addosso è uguale a noi. Lo sentiamo come ci sentiamo noi stessi”.
Nell’epidemia, nelle vere epidemie, nonostante l’aggressione della malattia si rimane ancora massa ma come identità di un funesto destino collettivo il cui referente visibile è il mucchio dei cadaveri; diversamente da un terremoto istantaneo e di breve durata, nell’epidemia si ha un effetto cumulativo: “Dapprima solo pochi ne sono colpiti, poi i casi si moltiplicano; dappertutto si vedono dei morti, ed ecco che i morti sono più numerosi dei vivi. Alla fine, il risultato di un’epidemia può essere pari a quello di un terremoto; ma, nell’epidemia gli uomini sono testimoni del massiccio progresso della morte che ha luogo sotto i loro occhi”. Con l’epidemia però la totalità della massa implode e diventa precaria perchè vi si ritrova quel timore del contatto dalla cui liberazione si era generata. In questo caso i vincoli associativi si spezzano e la massa,come per esempio l’insieme dei cittadini che frequentano luoghi comuni, si disgrega e riappaiono comportamenti primari come l’isolamento individuale: “Il miglior modo di difendersi consite nel non avvicinare alcuno: chiunque potrebbe portare con sé il contagio. Alcuni fuggono dalla città e si disperdono nei loro possedimenti. Altri si chiudono in casa e non lasciano entrare nessuno. Ciascuno schiva gli altri. Tenere gli altri a distanza è l’ultima speranza. La prospettiva di vivere, la vita stessa, si esprimono per così dire nella distanza dagli ammalati”.
Le pagine dedicate all’epidemia sono inserite nel capitolo VI di Massa e potere dal titolo Il sopravvissuto. Nella sopravvivenza di fronte all’infuriare del morbo si nasconde un piacere assoluto, il sopravvissuto, infatti, è il favorito dal destino, ha una sensazione di invulnerabilità come piacere originario, biologico si direbbe, un piacere del sopravvivere che rimane nascosto e che difficilmente si ammetterebbe, nemmeno a se stessi: “Nell’ambito di tale condanna generale, in cui chi viene colpito dalla malattia è perduto, accade il massimo dei prodigi: ci sono poche, contate persone che guariscono dalla peste. Si può immaginare come esse si sentano in mezzo agli altri. Esse sopravivvono e si sentono invulnerabili”.
Anche Renzo Tramaglino, il più inerme degli eroi della nostra letteratura è, ne I promessi sposi, uno di quelli che hanno conquistato l’invulnerabilità e che i virologi di oggi avrebbero chiamato Recovered, il contagiato guarito e non più infetto: “I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente una classe privilegiata. Una gran parte dell’altra gente languiva o moriva; e quelli ch’erano stati fin allora illesi dal morbo, ne vivevano in continuo timore[…], quegli altri all’opposto, sicuri a un di presso del fatto loro (giacchè aver due volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro) giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti; come i cavalieri d’un’epoca del medio evo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare”.