Covid può aiutarci a ripensare la città: non perdiamo l’occasione
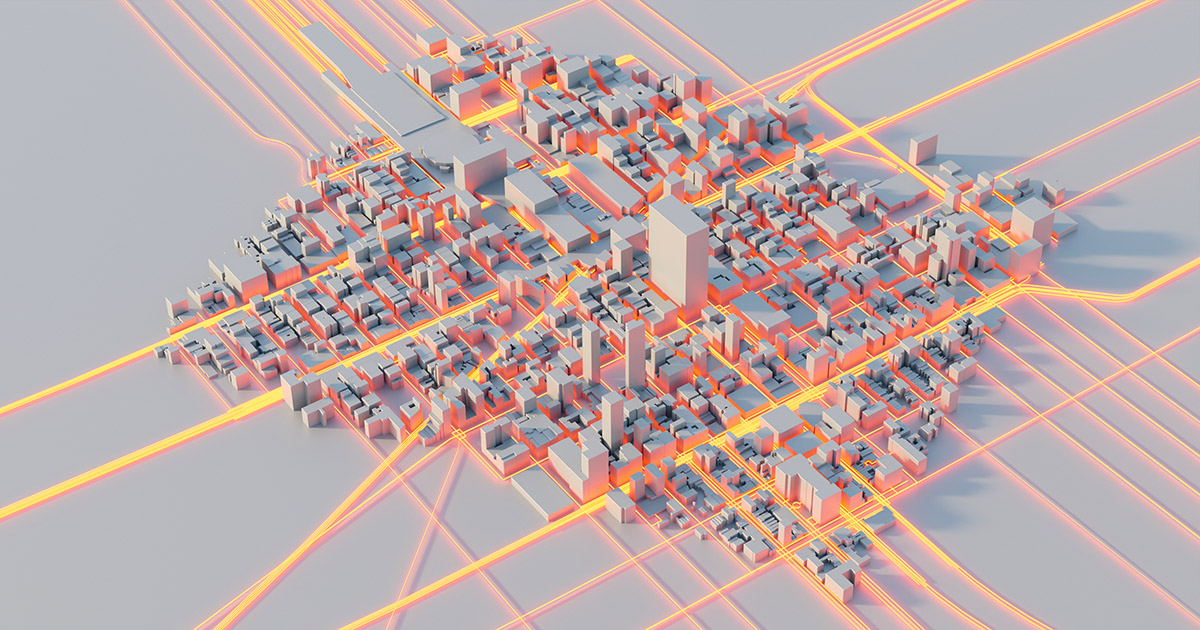
Non sono né architetto né urbanista, sebbene sappia parecchie cose delle due materie perché nella mia adolescenza queste professioni avevano conquistato piena egemonia culturale sulla sinistra della nostra generazione. Forse era perché le città erano state distrutte dalla guerra, e però a pochissimi veniva in mente di fare il medico per via dei tanti morti che lo stesso evento aveva provocato: più che agli umani si pensava alle città, perché in qualche modo erano un modello di società ravvicinato. E questo è quello che allora ci interessava in primo luogo.
Ci piacevano molto anche la filosofia e la storia, ovviamente, visto che stavamo cercando di capire il mondo nuovissimo che si era affacciato all’orizzonte e di raccapezzarsi fra un passato oscuro e un futuro anche più ingarbugliato. Ma comunque erano soprattutto l’architettura e l’urbanistica che ci intrigavano, non in quanto possibili professioni, ma come qualcosa che somigliava a ciò di cui eravamo affamati: la politica. E fare case e immaginare città era una grande operazione pratica e collettiva, cioè politica.
Insomma, non lo so spiegare, so solo che i concorsi per i primi progetti di edilizia popolare li seguivamo con reale passione anche noi che quegli studi non li avevano seguiti perché reinventarsi il modo di abitare era, appunto, parte della passione che ci aveva travolti: cambiare il modo di vivere dell’umanità.
L’ho capito meglio un po’ di anni fa quando Francesco Indovina, al termine della sua lunga docenza veneziana, fu chiamato a insegnare nella nuova facoltà di Alghero; e siccome chi voleva iscriversi doveva superare un test chiese a me e ad altri personaggi simili di tenere ciascuno una lezione per preparare i candidati e far loro capire di che si trattava. «Devi spiegargli cosa è la politica – mi disse – perché senza questa non si può fare l’architetto».
Vi ho raccontato tutto questo per giustificare la mia presenza in questo dibattito cui non ho titoli accademici per partecipare, solo un grande interesse da quando avevo 17 anni ed era pressappoco il 1946.
Covid-19, questo virus maledetto, all’inizio mi è capitato talvolta di definirlo “compagno” per le non irrilevanti positive reazioni che ha suscitato, e fra queste innanzitutto la scoperta di non poter sopravvivere senza gli altri, e dunque dell’insensatezza della convinzione ormai dominante dell’«io me la cavo da solo», prodotto da un virus altrettanto orrendo: quello dell’individualismo.
In questa discussione voglio dunque portare qualche considerazione sulla mia esperienza politica post Covid, direttamente legata all’abitare, che è funzione eminentemente sociale.
Purtroppo l’attenzione che il virus ha suscitato si è subito spostata sulla malattia e pochissimo sulle cause che l’hanno prodotta. Insomma: sul come se ne esce, niente o quasi sul come ci si è entrati. Solo il Papa, da tempo il più lucido dei nostri uomini politici, ha detto in due parole di che si trattava: «in una Terra malata non possono esserci umani sani».
Vorrei che si ripartisse proprio da qui, dal come si può cercare di far guarire la Terra, e non solo dal come ci si accomoda nella sua malattia.
E fra i tantissimi aspetti della questione, il come abitiamo ha un grande spazio di cui tuttavia ci si occupa ben poco: le nostre città consumano quasi tutta l’energia e producono una quantità di veleni, mentre potrebbero non solo ridurne il consumo, ma concorrere a produrre cose necessarie ma non inquinanti. Purtroppo, invece, un tema così importante come quello delle comunità energetiche – per esempio – è nella pratica quasi ignorato. E con questo la necessità non solo di installare ovunque possibile pannelli solari, ma di riaggiustare i fabbricati (il “cappotto”, gli infissi, ecc.). Quanto ai rifiuti, anziché alla loro riduzione ci si sta paradossalmente concentrando sulla loro produzione, puntando al loro riciclaggio, così aiutando a dimenticare che la stessa produzione di rifiuti tossici, anche se poi riciclati, è gravemente dannosa. E così nulla si fa per cambiare la loro canalizzazione, con l’inserimento di depuratori adatti (i quali o non ci sono affatto o sono vecchissimi e inservibili). Non solo: i rifiuti organici hanno origine nella terra e a questa andrebbero restituiti perché ne ha bisogno; invece la restituzione è oggi pari al 2%. Sembra un dettaglio, ma non lo è, perché evoca uno dei grandi problemi che si devono affrontare: cambiare l’orrendo rapporto che ha finito per instaurarsi fra città e campagna, e cioè riportare nella quotidianità della nostra vita l’agricoltura e gli animali non umani che la abitano. Che non è solo questione di ripopolare le zone rurali, ma di far capire ai cittadini che gli umani sono solo lo 0,6% delle specie viventi, una bazzecola, e non possono continuare ad ignorare i tanti coabitanti della Terra che concorrono a renderla quella che è. Quando giro le periferie dove vivono bambini che non vanno in villeggiatura mi rendo conto che molti, ora che neppure i nonni vivono più in campagna, non hanno mai visto una gallina viva e forse pensano che il latte lo fa il frigorifero e non le mucche. Vado perciò proponendo manifestazioni con corteo di animali, l’ho detto persino parlando a Roma nella consueta manifestazione ANPI del 25 aprile. Perché ogni stagione ha le sue sfide, e salvare la Terra passa anche per una rinnovata attenzione alla natura. Per questo penso che non si possa parlare di abitare senza porsi come obiettivo quello di riportare la natura fra le nostre case. Non solo come fa – e comunque ne sono contenta – Stefano Boeri con le sue piante, ma proprio come attività agricola.
Ho accennato solo a qualche problema, per denunciare che di quel po’ di risorse che nel PNRR è destinato alla rigenerazione urbana, così come del previsto contributo del 110%, si stanno per ora occupando soltanto alcune grandi ditte associate a qualche altrettanto grande banca per indurre a usare tali risorse allo scopo di inutilmente abbellire gli appartamenti dei più abbienti.
Usare queste risorse in modo appropriato aiuterebbe non solo ad affrontare correttamente i più urgenti problemi energetici, ma anche ad avviare quella riflessione più generale sul nostro modo di abitare che va cambiato comunque, visto che così tanto sono cambiati negli ultimi cento anni i soggetti che abitano. Pensate alle donne, tuttalpiù associate per secoli quasi solo alle cucine, da cui invece in tantissime sono uscite per andare a lavorare fuori casa, arrabattandosi con le difficoltà di non sapere come affidare il lavoro di cura a vecchi, malati e bambini, da sempre a loro imputato. La prima cosa che si dovrebbe fare, visto che le donne vengono indicate come categoria principale destinata a godere di misure positive, sarebbe quella di ascoltarle e con loro ridisegnare complessi edilizi e quartiere, nel quale, per renderlo vivibile e non fonte di ulteriore spreco di energia, non basta moltiplicare gli autobus o sostituire i motori a gas con quelli elettrici delle auto, ma dotando ogni zona del necessario: presidi sanitari, uffici amministrativi, shopping, librerie, cinema, teatri…, sicché ognuno di questi posti possa esser raggiunto in non più di 15 minuti a piedi. “La città di 15 minuti” è già progetto in corso di attuazione varato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo; in Italia nessuno ne parla.
Eppure, ridare autonomia funzionale ai quartieri, e dotare ognuno di essi di un proprio piccolo centro, potrebbe essere il modo di cominciare a eliminare l’orribile suddivisione delle nostre città in quartieri dormitorio e quartieri del divertimento e/o degli uffici. Per ricostruire le città medioevali, dove ciascuna zona aveva un centro e una propria autonomia: necessarie per i servizi così come per le relazioni sociali.
In realtà ridare importanza al territorio, al quartiere, è questione essenziale, premessa per ridar forza alla nostra appassita democrazia. Per – come sottolineano Bertuglia, Greco e Vaio – porre l’accento sulle disfunzionalità rispetto a una civile convivenza. Se qualcosa di buono è avvenuto a Roma in questi ultimi anni, nel disastro non attribuibile solo alla gestione Raggi, è proprio l’esperienza di mini-municipi, in molti dei quali, e soprattutto per iniziativa e buona volontà dei mini sindaci e di un gruppetto di loro collaboratori, è tornata a crescere un po’ di vita comune, di confronto collettivo, di iniziativa autonoma. Una nuova attenzione al territorio è cresciuta anche nei sindacati: il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha cominciato a parlare di “sindacato di strada” come necessaria componente da affiancare al sindacato di categoria, visto che il lavoro è sempre più frantumato e dunque disperso proprio sul territorio assai più che aggregato nella fabbrica. Il sindacato degli edili e quello dei pensionati, gli uni perché i quartieri li fanno, gli altri perché sono quelli che più ci vivono, hanno dato vita a un’associazione che si propone proprio la loro rigenerazione. Ed interessante è anche che, mentre continua a languire l’interesse per i partiti, un ritorno di attività politica da parte dei più giovani, i millennials, c’è proprio sui territori della periferia di Roma: gruppi organizzati o meno, molti cresciuti nell’attività solidale del lockdown (“Nonna Roma”, per esempio). Con la task force “natura e lavoro” che da circa un anno abbiamo costituito con una decina di amici, scienziati e professionisti assai qualificati (teniamo una rubrica sul Manifesto on line, intitolata “Attenti ai dinosauri”) stiamo lavorando nei quartieri – non un movimento né un’associazione, solo un piccolo strumento per contribuire a fornire competenze al sindacato e a questi gruppi di giovani sì da dare un carattere vertenziale e non solo dimostrativo alle richieste –, mettendo in relazione soggetti diversi e non abituati a lavorare assieme come invece sarebbe necessario. Abbiamo promosso qualche incontro fra gruppi di femministe e sindacato edili per discutere assieme come ripensare all’abitare e come, in concreto, attivare la richiesta dei contributi previsti. Per aiutare a qualificare la domanda, e cioè per indirizzarla alla richiesta di comunità energetiche e di creazione di spazi collettivi nei complessi edilizi, per socializzare il lavoro di cura, così come per spingere le scuole a diventare centri di attività culturale rivolti a tutto il quartiere, non solo agli studenti.
È solo un pezzetto di lavoro che dovrebbe allargarsi e mettere in relazione architetti, sindacati, giovani. E Lega delle cooperative, giacché se si vuole davvero prendere sul serio l’economia circolare è necessario creare piccole ditte artigianali in grado di riparare, manutenere, fabbricare pezzi di ricambio e aggiustare gli immobili. Non sarà l’Impregilo a farlo, è ovvio. Ma per superare l’attuale modello economico (che è poi nientemeno che il capitalismo!), che, come giustamente ci ricorda Berdini, è l’obiettivo e insieme la premessa del nostro fare, occorre attivare nuove forze, nuovi soggetti, in grado di affrontare la complessità. È quanto suggerisce Marianella Sclavi, anche se penso che più che di “facilitatori” abbiamo bisogno di dar vita a nuove e stabili forme di democrazia organizzata che includano momenti di democrazia diretta. Di più: come indicava Gramsci in alcuni suoi scritti che mi sembrano attualissimi, c’è bisogno di forme di autogestione di pezzi della società, sottraendoli all’esclusiva competenza e potere della burocrazia statale, casematte per un lungo processo di trasformazione del modo di produrre, consumare e dunque vivere, quale ci viene imposta dalle dimensioni drammatiche e assolutamente sottostimate delle minacce ecologiche.
È difficile, perché non si tratta solo di avviare un confronto di opinioni e di saperi, come scrive Marianella Sclavi (ma penso siamo in realtà d’accordo). Si tratta di scontro fra interessi diversi e vincerlo è meno facile.








