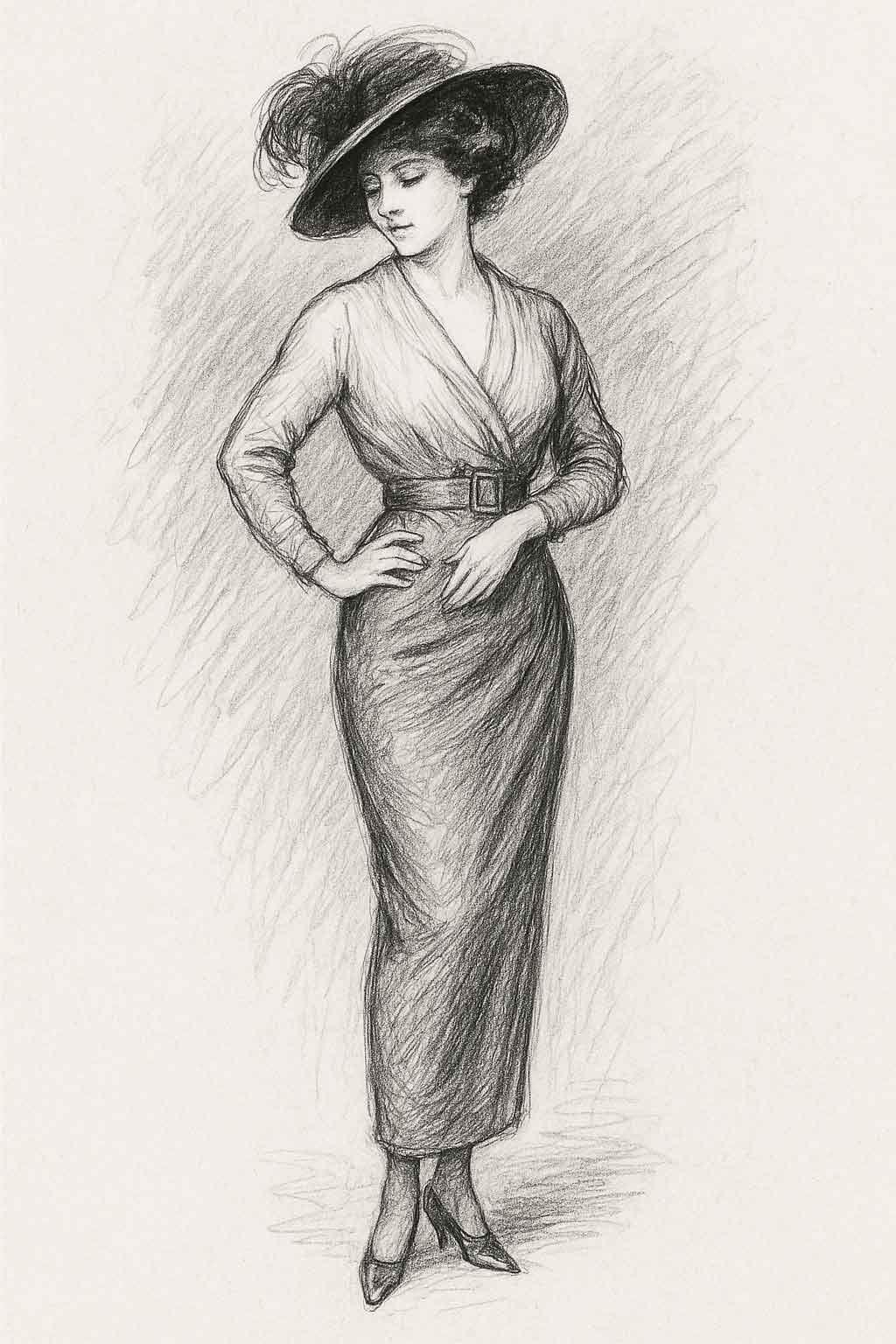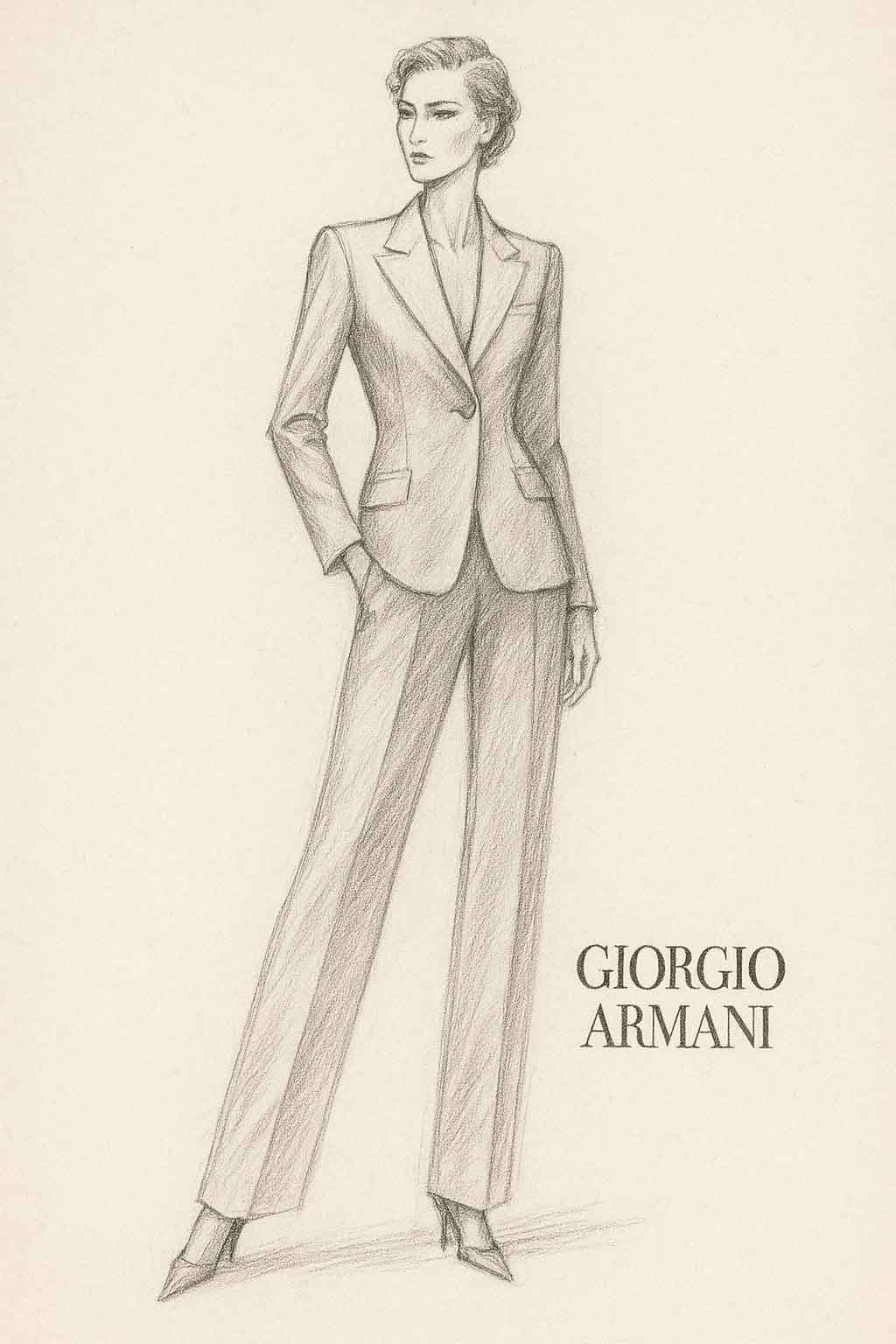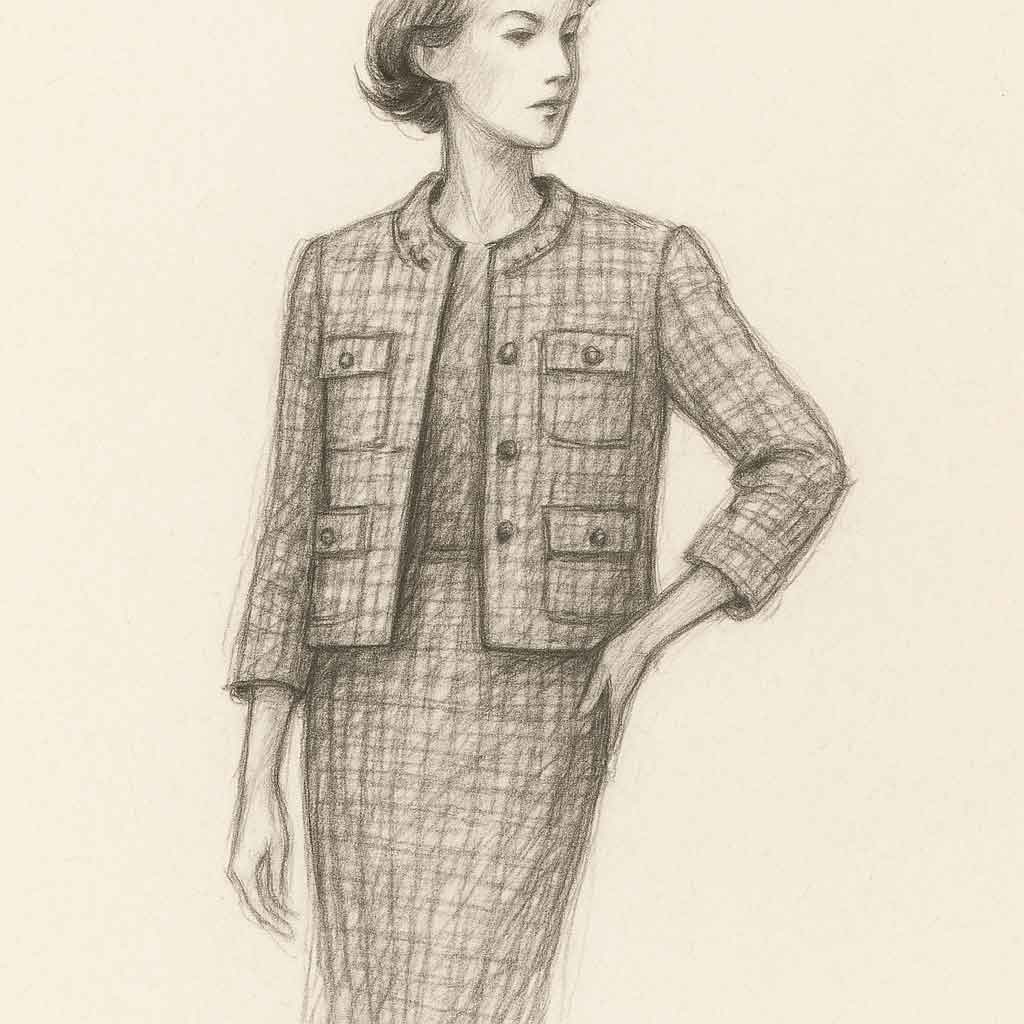La liberazione dal corsetto: storia sociale di un abbraccio forzato

Ricordate tutti il film colossal Via col vento, vero? Forse le scene più d’impatto sono quelle dell’incendio di Atlanta, o quando Rossella O’Hara, sfinita, stringe in mano una zolla di terra di Tara, la sua proprietà, e giura a se stessa che non patirà mai più la fame o quando, alla fine, lasciata da Rhett Butler, pronuncia la fatidica frase: “Ci penserò domani. Domani è un altro giorno”.
Eppure c'è una scena apparentemente molto marginale e non pregna di storia, né di sentimenti turbolenti, che invece è significativa. Siamo all’inizio, quando la guerra di secessione è alle porte ma ancora tutti conducono una vita normale e le sorelle O’ Hara si preparano per andare alla festa di fidanzamento di Ashley e Melania alla tenuta “Dodici querce”. Rossella si sta facendo stringere a fatica il corsetto dalla domestica, tenendosi a una colonna del letto a baldacchino, e quando arriva la colazione la rimanda indietro, ma la domestica la ammonisce: “Una vera dama in pubblico deve mangiare come un uccellino. Non sta bene che ti rimpinzi come un tacchino”. Prima di uscire Rossella si lamenta ancora: “Lo hai stretto così tanto che mi verrà il singhiozzo”.
Et voilà. L’equazione è porta sul piatto d’argento: (nell’Ottocento) una donna deve portare il corsetto, strettissimo possibilmente, e non deve mangiare in pubblico, nemmeno quando va a una festa. Costrizione, disciplina, immagine.
Le origini
Quando lo indossa Rossella O’ Hara, nel 1861, il corsetto è però sulla piazza incredibilmente da diversi secoli: secondo alcuni storici già da millenni, avendo come antenato un indumento rituale rappresentato nella famosa statuina della Dea Serpente di Cnosso, di epoca minoica, datata 1600 a.C. circa. La figura è avvolta in un bustino aderente, che lascia il seno scoperto e stringe la vita piegando il corpo femminile alla famosa forma a clessidra, che quindi è un ideale estetico antichissimo, non il frutto dei desiderata di Richard Williams e Robert Zemeckis quando nel 1988 inventavano il personaggio di Jessica Rabbit (peraltro ispirato, per le sue curve esagerate, nientemeno che a Marilyn Monroe).

La statuina minoica della Dea Serpente è la prima testimonianza di uso del corsetto (1600 a.C. circa) - immagine realizzata con ChaGPT
… fino al Novecento
E se nella civiltà minoica veniva però indossato solo in particolari cerimonie religiose, nel Rinascimento inizia a imporsi come elemento del vestiario quotidiano. Si chiamava “corpetto steccato” perché la sua forma era garantita da rinforzi costituiti da stecche di osso di balena o addirittura di legno o ferro, ma la finitura era in velluto, broccato o altri tessuti nobili nel caso di donne dell’alta società, mentre a mano a mano che si scendeva di classe il corpetto si ammorbidiva fino a stringere il corpo femminile solo attraverso lacci o cinghie che garantivano comunque un minimo di sostegno.
La leggenda vuole che a imporre l’uso del corsetto sia stata nientemeno che Caterina De Medici, diventata regina di Francia nel 1547, perché non voleva che ci fossero “donne con la vita larga”: la moda del “vitino di vespa” alla Jessica Rabbit ha origini molto antiche.
Ma c’è dell’altro. Il bustino in quell’epoca ha una funzione moralizzatrice: imponeva postura, contenimento, modestia. Il corpo addomesticato è il corpo di una donna perbene. Ed è al contempo un simbolo di disciplina, di riconoscimento di classe e di genere, dal momento che viene indossato dalle donne nobili e non certo dagli uomini o dalle contadine, il cui lavoro verrebbe impedito da un indumento così rigido. Al contempo a corte le bambine venivano abituate al suo utilizzo fin da quando avevano sette-otto anni.
Il corsetto non voleva in nessun modo accentuare la femminilità del corpo delle donne, anzi. Si pensi che fa parte dell’abbigliamento caratteristico della “Vergine regina”, cioè di Elisabetta I, e infatti i suoi corpetti appiattiscono il seno e contribuiscono a dare una “postura regale”.
Nel Settecento e nell’Ottocento i corpetti troppo stretti (che portavano il girovita alla misura ideale di 40 cm, e si consideri che le misure perfette nel secondo Novecento erano considerate quelle di Sophia Loren o di Cindy Crawford: 90-60-90, cioè 20 cm in più) provocavano frequenti svenimenti e alcune sale da ballo avevano delle stanze laterali arredate appositamente con dei divanetti proprio per dare sollievo alle donne “in apnea”.

Elisabetta I indossava rigidi corsetti che appiattivano il seno il seno e costringevano a una postura "regale" - immagine realizzata con Chat GPT
La rivoluzione: la liberazione
Fu Coco (Gabrielle) Chanel a liberare le donne dal giogo, all’inizio del Novecento. In realtà, a ben guardare, prima di lei già il couturier parigino Paul Poiret nel 1908 aveva rivoluzionato la moda femminile disegnando una silhouette che aboliva il corsetto e l’aveva chiamata “La Vague”, l’onda, perché gli abiti si posavano sul corpo delle modelle come un’onda del mare; ispirato dal coreografo Djagilev aveva anche messo a punto dei pantaloni in stile orientale e al contempo, però, una gonna molto stretta a livello dei polpacci, la “jupe entravée”, che obbligava le donne che la indossavano a fare passi piccolissimi.
In Chanel invece c’era l’intento vero e proprio, consapevole, di liberare la donna dalle sue schiavitù, a partire dall’abbigliamento. Secondo lei “tutta l’articolazione del corpo è nella schiena; tutti i gesti partono dalla schiena” quindi le sue clienti dovevano poter indossare abiti che le lasciassero libere di muoversi: di giocare a golf, di salire e scendere dai mezzi, di piegarsi e di lavorare. Siamo nel primo dopoguerra e Coco Chanel veste le flappers, quelle donne degli anni Venti che sfidano le convenzioni e lavorano, fumano, bevono, portano i capelli corti e cercano di vivere la propria vita traendone piacere (in anni recenti anche Miuccia Prada nell'ideare il vestiario "ugly chic" guarderà proprio a loro).
Al contempo la stilista fa suo il motto razionalista di architetti come Le Corbusier e van der Rohe, less is more, e si inventa il fatidico abitino nero morbido: la “petite robe noir”. Il corsetto è completamente dimenticato… fino a quando non fa la sua comparsa sulla scena Christian Dior nel 1947 che, con la sua prima collezione, presentata il 12 febbraio di quell’anno, lascia senza parole pubblico e stampa. Il suo stile viene definito dalla caporedattrice della rivista di moda “Harper’s Bazaar”, Carmel Snow, “New Look”, appellativo che gli rimarrà addosso per sempre. Si tratta di un vero e proprio ritorno alle forme dell’anteguerra, come a voler dimenticare l’orrore e le privazioni, che ridisegna l’iconografia femminile. Le donne sono di nuovo principesse dalla vitina di vespa, con addosso abiti aderenti sul busto, scollati, dalle gonne ampie che si producono con uso di parecchia, troppa, stoffa. Il “New Look” tira fuori dal cassetto il corsetto assegnandogli il suo ruolo originario: mettere in evidenza il girovita, e stavolta anche il seno. Un capo che le donne iniziano a indossare quando è in voga il “New Look” è la guepière, letteralmente “donna vespa”, che è un ibrido tra un corsetto e un reggicalze e viene messo sotto agli abiti a clessidra proprio per accentuare le forme femminili come da indicazioni dello stilista.
Coco Chanel, che nel frattempo si era ritirata a vita privata, decide che non può restare a guardare mentre qualcosa di così retrogrado va compiendosi. Come osa, Monsieur Dior, ingabbiare nuovamente le donne?
Così, dopo 15 anni di silenzio, la sera del 5 febbraio del 1954 al primo piano del civico 31 di Rue Cambon le sue modelle sfilano di nuovo: disinvolte, con la mano in tasca, esattamente come fanno gli uomini, senza accompagnamento musicale. Massima semplicità. In America la sfilata viene accolta con giubilo. È quella notte che nasce il tailleur di Chanel, espressione di una donna elegante ed emancipata che tutti abbiamo in mente non fosse solo perché è proprio un tailleur di Chanel, in bouclé rosa, quello che indossa Jaqueline Kennedy il fatidico venerdì 22 novembre 1963 a Dallas quando il marito viene colpito a morte e il suo sangue schizza anche sull’abito della moglie, che però non vorrà cambiarsi per tutto il giorno. La first lady comprava abiti della maison Chanel già dal 1955. Il modello classico del tailleur Chanel era in tweed: giacca senza pince, dalla linea dritta e comoda, i polsini strutturati, i bottoni gioiello con la doppia C di Chanel o la testa di leone (il segno zodiacale della stilista) e – soprattutto – le tasche, non perché ci si potesse tenere dentro qualcosa, ma perché le donne potessero infilarci le mani, con un gesto di disinvoltura. Quattro sulla giacca, ma anche la gonna le aveva.
Chanel non era l’unica sul palcoscenico della moda degli anni Cinquanta a essere all’avanguardia nel vestire le donne, però.
Pur partito da posizioni vicine alla linea storicista in voga in quel momento, il basco Cristóbal Balenciaga che dominava la scena già ben prima di Dior (pare che un tassista abbia detto alla scrittrice Nancy Mitford che usciva, appunto, dalla maison Dior: “Finalmente abbiamo un couturier che può competere con Monsieur Balenciaga!”, alludendo proprio a Dior) aveva messo il comfort delle sue clienti al centro delle sue produzioni: tacchi bassi, capelli raccolti, linee funzionali erano i suoi must. La sfilata del 1951 aveva svelato a pubblico e stampa il tailleur semi aderente: adeso al corpo sul davanti ma staccato sulla schiena. Ovazione di cinque minuti e la solita Carmel Snow di “Harper’s Bazaar” chiosava: “Ancora una volta è avvenuto il miracolo. Forse questa silhouette rivoluzionerà la moda”.
Lo stesso anno Balenciaga lancia un nuovo concetto di tailleur amatissimo dalle donne perché nasconde i punti critici: si tratta di una blusa da marinaio su un abito lungo e stretto; nel 1955 è la volta della tunica, perché l’eleganza, per il couturier, doveva prescindere dalle forme; nel 1956 l’abito a sacco sfida completamente i codici estetici: non segna il punto vita e ha linee dritte che nascondono le curve. Si tratta di un modello tutt’altro che di semplice fattura, che esalta l’arte del taglio e minimizza le cuciture.
È una rivoluzione del canone estetico, fortemente meditata, esattamente come per Chanel. Ma non finisce qui: nel 1958 Balenciaga propone l’abito baby-doll, dal drappeggio estremamente fluido, che si sostiene esclusivamente sulle spalle. Eppure, nonostante lo stilista sia un sostenitore, con i suoi modelli, dell’emancipazione femminista, quando la minigonna di Mary Quant inizia a spopolare in Inghilterra, si rifiuta di accorciare le gonne, anzi le allunga. Serena Sinclair commenta sul “Daily Telegraph”: “Qualsiasi abito di Balenciaga sembrerebbe più giovane di dieci anni se avesse dieci centimetri di meno”.
Un grandissimo ammiratore di Balenciaga era invece il giovanissimo Yves Saint Laurent, che – ironia della sorte – alla morte prematura di Dior nell’ottobre del 1957, dopo averlo affiancato dal 1955, viene chiamato a succedergli.
Il desiderio del giovane Yves è quello di affrancarsi dal maestro e, negli anni, le collezioni prendono via via le distanze dal “New Look”, pur avendo ideato abiti aderenti celeberrimi come quello indossato nella fotografia “Dovima con gli elefanti” di Richard Avedon. La collezione Trapèze per Dior, una delle prime, è una rivoluzione: gli abiti fluttuano intorno al corpo senza aderire, esattamente come quelli del suo stilista di riferimento, Balenciaga.
Nel 1961 Yves Saint Laurent lascia la maison Dior per aprire la propria: di tutti gli ottanta dipendenti nella nuova casa di moda, la metà vengono da Dior. Lì Saint Laurent prosegue l’emancipazione del corpo femminile: cappotti pratici “da marinaio”, prestiti dal guardaroba maschile, fino alla rivoluzione dei pantaloni: vuole dare alle donne la stessa libertà di movimento di cui godevano gli uomini. Nel 1966 è la volta del tailleur pantalone, addirittura nella forma dello smoking femminile. (Quindici anni anni dopo il power suit con cui Giorgio Armani vestirà le donne in carriera, dalle fogge diversificate a seconda delle esigenze, non solo farà la sua fortuna, ma segnerà un'ulteriore tappa in questa direzione).
Quando nel 1968, stavolta definitivamente, Coco Chanel si ritira dalla moda, nomina Yves Saint Laurent suo successore ideale “perché un giorno qualcuno dovrà portare avanti la mia eredità”.
È fatta, verrebbe di affermare. Ma un altro dei direttori creativi della maison Dior, John Galliano, nel 1977 riporta in passerella il New Look reinterpretandolo con tagli sbiechi (che rendono la stoffa elastica e fluida) abbinati all’uso del corsetto molto strutturato, ispirato ai bustini vittoriani e agli abiti rinascimentali.
Un nuovo significato
E poi, siccome il destino è beffardo, così come Saint Laurent succede proprio a Dior, maestro del corsetto, va detto che Yves Saint Laurent, amante delle forme morbide, è stato nientemeno che l’idolo del giovane Jean Paul Gaultier che negli anni Settanta lavora per Pierre Cardin (che ha contribuito a diffondere il prêt-à-porter nei grandi magazzini e sdoganato l’utilizzo delle “taglie”) ma guarda al lavoro di Yves: “I suoi abiti, a volte dall’aspetto rétro, rivelavano un rigore quasi puritano, smentito però dalle camicette trasparenti e da uno stile femminile-maschile mai visto prima. Adoravo quei contrasti”.
Ed è proprio nella direzione di cercare una nuova femminilità che tenga insieme l’idea di mostrare e nascondere allo stesso tempo, cara a Saint Laurent, che Gaultier porta alla ribalta, di nuovo, il corsetto, come capo di lingerie vero e proprio. In un decennio, gli anni Ottanta, in cui mostrare la biancheria intima è ancora peccato mortale, lo stilista amplia gli scolli, mostra le sottovesti, i reggiseni, persino il bordo degli slip dai pantaloni.
Leggenda vuole che un pomeriggio a casa della nonna Marie lo stilista, da bambino, abbia visto per la prima volta la biancheria femminile e se ne sia innamorato, ma che il ricordo gli sia sovvenuto solo quando, nei primi anni Ottanta, vide ballare nel club Le Palace Fredo, la sua modella di prova, con addosso un bustier, e di nuovo poi a Broadway le danzatrici in bustino del musical Nine.
Stavolta però il corsetto non significa costrizione, ma anzi liberazione. Chi non ha in mente Madonna con il corpetto con le coppe a cono – una rosa e una dorata – disegnato proprio da Jean Paul Gaultier e indossato per il suo tour Blonde Ambition del 1990? Madonna è l'emblema della trasgressione, dello scandalo, della sessualità libera. E Madonna indossa gli abiti (anche) di Gaultier, a partire dal 1985, quando, con un suo tubino bianco comprato da lei stessa in negozio, si presenta alla prima a New York di Cercasi Susan disperatamente di cui è protagonista.
“Ho realizzato le prima coppe a cono con la carta di giornale per il mio orsetto Nana” racconta Jean Paul, ricordando ancora i pomeriggi a casa della nonna.
Sembra impossibile invece è accaduto proprio così. Lo scandalo di Gaultier di tornare al corsetto fornisce alle donne l’alibi ideale: indossando l’indumento che le ha ingabbiate per eccellenza possono invece rivendicare la loro femminilità e la loro sessualità.
Gaultier non è il solo. Negli stessi anni si muove in quella direzione Vivienne Westwood. Il suo è un capo postmoderno che mescola moda vittoriana, storia dell’arte (spesso è realizzato con stampe tratte da dipinti antichi) e cultura punk e rappresenta la fusione tra oppressione e liberazione. Un po’ come il personaggio di Carrie Bradshaw della celebre serie della HBO Sex and the city, una giornalista single molto emancipata che tiene una rubrica intitolata “Il sesso e la città” ma che è alla costante ricerca, insieme alle sue tre amiche, dell’amore romantico. E che spesso veste Vivienne Westwood.


Celine Dion, Miley Cyrus, Amanda Seyfried in corsetto Armani mptvimages.com/contrasto
E allora oggi?
Proprio di recente ha fatto scalpore la scelta di Marco Mengoni, il cantante lanciato da Sanremo, di salire sul palco del suo tour indossando… un corsetto. Anzi sfoggiandone una serie (di Nick Cerioni per Etro). E alle contestazioni ha risposto mentre cantava il brano Voglio: “La vita è una sola e non so se ce n’è un’altra, quindi se non sono me stesso adesso non lo potrò essere mai più”.
Il corsetto, oggi, è diventato (anche) simbolo di libertà.

Jean Paul Gaultier reintroduce il corsetto e gli dà un significato di emancipazione, libertà, autodeterminazione femminile - immagine realizzata con ChatGPT