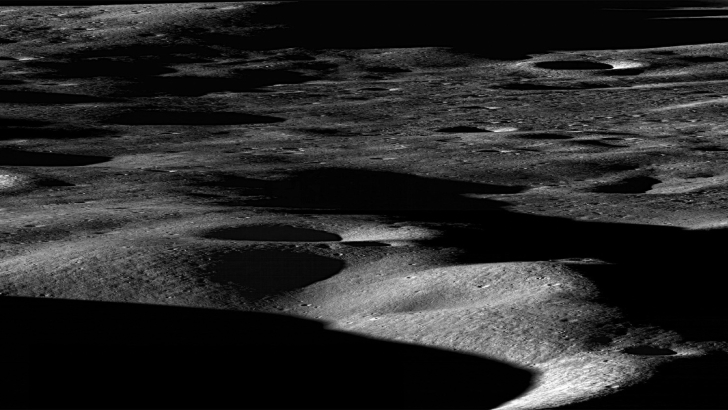Dallo spazio alla difesa: l’ESA cambia paradigma

La sede dell'European Space Agency a Parigi. Foto: ESA
L’Europa scopre la resilienza dallo spazio: l’ESA verso il suo primo programma ibrido civile-sicurezza. Quando nel 1975 nacque l’Agenzia spaziale europea, i fondatori avevano un obiettivo ambizioso: dimostrare che la cooperazione scientifica poteva unire un continente appena uscito dalle divisioni della Guerra fredda. L’ESA nacque come strumento di conoscenza e progresso, non di potere. “Lo spazio per fini pacifici”, recitava il principio che ne definiva l’identità, segnando una linea netta rispetto agli usi militari che caratterizzavano le due superpotenze.
Oggi, quasi cinquant’anni dopo, quello stesso principio viene ridefinito alla luce di un mondo più instabile. Guerre ibride, crisi energetiche, attacchi informatici e disastri climatici hanno trasformato lo spazio in un’estensione delle infrastrutture terrestri, e quindi in un nuovo campo di vulnerabilità.
È in questo contesto che l’ESA si prepara a una svolta storica: la nascita del programma European Resilience from Space (ERS), il primo progetto dell’Agenzia concepito per rafforzare la resilienza e la sicurezza europea, pur restando formalmente civile. Un passaggio che ridefinisce il ruolo stesso dell’Europa nello spazio e, in parte, la sua idea di sovranità.
Un nuovo capitolo per l’Agenzia civile d’Europa
Nel giugno 2025 il Consiglio dell’ESA ha approvato una enabling resolution che autorizza la proposta di portare l’ERS all’esame del Consiglio ministeriale di Brema, previsto a fine novembre.
La risoluzione segna un punto di svolta istituzionale: per la prima volta, un’agenzia nata per scopi scientifici assume la responsabilità di costruire capacità spaziali con una valenza diretta per la sicurezza.
Il progetto è stato presentato pubblicamente durante l’evento “Space for European Resilience – Rising to the Collective Challenge”, tenutosi a Bruxelles nell’ottobre 2025 sotto la presidenza danese del Consiglio UE. Lì, i rappresentanti dell’ESA, di ESPI e della Commissione europea hanno descritto l’ERS come un sistema integrato di sistemi, pensato per fornire servizi rapidi e sicuri durante crisi ambientali, disastri naturali o minacce ibride.
L’iniziativa, ancora in fase di definizione tecnica, nasce dunque come risposta a un’esigenza politica: dotare l’Europa di strumenti di sorveglianza e comunicazione autonomi, affidabili e soprattutto non dipendenti da infrastrutture extraeuropee.
Osservare, comunicare, reagire
L’obiettivo dell’ERS è costruire una rete di satelliti e servizi in grado di osservare, trasmettere e rispondere con rapidità alle emergenze.
Il programma punta a unificare ciò che oggi è disperso: le costellazioni per l’osservazione della Terra, i sistemi di navigazione e le reti di telecomunicazione. Insieme, queste componenti formano un’infrastruttura europea capace di fornire informazioni aggiornate quasi in tempo reale, garantendo comunicazioni sicure anche in condizioni critiche.
In pratica, significa poter monitorare da satellite un incendio o un’inondazione, localizzare con precisione le aree colpite, coordinare i soccorsi e assicurare la trasmissione dei dati alle autorità anche in caso di interruzioni terrestri.
L’obiettivo finale è una resilienza operativa: usare lo spazio non solo per osservare, ma per proteggere — rendendo, nelle intenzioni, l’Europa più pronta a reagire a crisi naturali, tecnologiche o geopolitiche.
L’anello mancante dell’architettura europea
L’iniziativa nasce anche come tassello abilitante del futuro Earth Observation Governmental Service (EOGS) dell’Unione Europea, che fornirà servizi di osservazione governativi “sovrani” per Stati membri e istituzioni.
Finora, i servizi satellitari europei erano frammentati tra Copernicus (per l’ambiente e il clima), Galileo (per la navigazione) e i programmi nazionali di sicurezza, spesso non interoperabili. L’ERS si propone di colmare quel vuoto intermedio, fornendo una base tecnica comune per le esigenze civili e governative.
Ma la portata politica è ancora più ampia. L’EOGS, al quale l’ERS fungerà da fondamento operativo, rappresenta un passo verso una governance integrata tra ESA e Unione Europea, in cui competenze e ruoli si avvicinano senza sovrapporsi. Da un lato l’ESA, con la sua esperienza tecnica e la capacità industriale maturata in decenni di missioni; dall’altro la Commissione, che definisce le priorità strategiche e politiche dei programmi europei.
Questa cooperazione, non sempre lineare in passato, sta diventando uno dei pilastri della sovranità tecnologica europea: un’alleanza in cui il sapere scientifico si intreccia con la necessità di proteggere infrastrutture, reti e dati. In un momento in cui la frammentazione istituzionale è uno dei limiti più evidenti dell’Europa spaziale, l’ERS appare come un tentativo concreto di costruire una catena di responsabilità comune, dalla progettazione alla risposta operativa.
Secondo l’ESA, le prime capacità potrebbero essere pronte dal 2028, con un investimento iniziale stimato intorno a un miliardo di euro, da finanziare su base opzionale dai Paesi aderenti. Le modalità di sottoscrizione saranno definite proprio al Ministeriale di Brema, che dovrà anche stabilire le regole di cooperazione con Bruxelles e con gli Stati membri.

Una riproduzione di un satellite ESA in orbita terrestre. Foto: ESA/Denmann production
Un contesto geopolitico in rapido mutamento
L’ERS non nasce in un vuoto politico, ma segue l’andamento che si può riscontrare in molti altri Paesi. Negli ultimi anni, la competizione orbitale si è trasformata in un terreno di confronto strategico tra potenze. Gli Stati Uniti investono oltre 40 miliardi di dollari l’anno soltanto nei programmi di difesa spaziale, gestiti attraverso una catena di comando unificata che fa capo alla U.S. Space Force e allo Space Command.
La Cina, grazie all’integrazione tra le sue agenzie civili e militari, ha costruito una rete di osservazione e allerta precoce che combina il sistema di navigazione Beidou, la stazione spaziale Tiangong e una costellazione di satelliti per il controllo e la sorveglianza.
L’Europa, invece, muove risorse inferiori: sommando i programmi nazionali e quelli comunitari, si arriva a qualchedecina di miliardi di euro distribuiti su più anni. Le capacità restano tuttavia frammentate tra ESA, Commissione europea e ministeri della difesa dei singoli Stati.
L’assenza di un comando unitario e di una struttura comune per la gestione e l’acquisto dei sistemi spaziali ha finora limitato la capacità europea di proiettarsi nello spazio come attore strategico. Eppure, la crescente interdipendenza tra sicurezza, tecnologia e autonomia industriale rende inevitabile una riflessione politica di lungo periodo.
L’ERS nasce anche come risposta a questa consapevolezza: che senza un sistema orbitale autonomo e resiliente, l’Europa resta dipendente da infrastrutture e dati forniti da altri.
Dal “Golden Dome” americano allo “Space Shield” europeo
Il dibattito sull’autonomia strategica ha portato, negli ultimi anni, alla definizione di una roadmap europea per la difesa spaziale. Documenti della Commissione e del Servizio europeo per l’azione esterna delineano un percorso verso uno European Space Shield, un sistema di difesa orbitale e di allerta precoce ispirato – in parte – al Golden Dome proposto dall’amministrazione statunitense.
L’ERS, pur restando sotto l’ombrello civile dell’ESA, si inserisce di fatto in questa traiettoria: un’infrastruttura capace di monitorare, prevenire e reagire. È il primo passo verso una resilienza orbitale europea che non implica militarizzazione, ma riconosce che la sicurezza – oggi – passa anche dall’orbita terrestre bassa.
In questo senso, il programma rappresenta un terreno di convergenza tra le due anime dell’Europa spaziale: quella scientifica e cooperativa, radicata nella tradizione dell’ESA, e quella strategica e tecnologica, promossa dalle istituzioni comunitarie.
L’effetto domino sull’industria spaziale
Il programma arriva in un momento di profondo riassetto industriale. Nel 2025, le divisioni spaziali di Leonardo, Thales e Airbus hanno annunciato un processo di fusione delle loro attività nel settore dei satelliti e dei servizi orbitali, con l’obiettivo di creare un campione europeo in grado di competere con colossi come SpaceX, Lockheed Martin e Boeing.
Leggi anche: Europa, la sfida per tornare protagonista nello spazio
Questa concentrazione riflette un cambio di paradigma: la necessità di integrare ricerca, industria e difesa in un ecosistema più coeso. L’ERS, con la sua architettura multiservizio, potrebbe diventare il primo grande banco di prova per verificare la capacità dell’industria europea di rispondere in modo unitario a una domanda strategica comune.
Anche il ruolo dell’Italia è centrale: membro fondatore dell’ESA, sede del centro ESRIN di Frascati (dedicato proprio all’osservazione della Terra) e paese con forti competenze industriali in ambito satellitare, dai sistemi di comunicazione militare SICRAL alle missioni dual-use per la Protezione Civile.
Per Roma, l’ERS rappresenta anche una conferma di priorità: l’idea che lo spazio sia ormai parte integrante della sicurezza nazionale e continentale.
Leggi anche: La corsa ai satelliti: l'Italia punta all'indipendenza nelle telecomunicazioni
L’ESA tra neutralità e sovranità
C’è però un nodo politico e identitario. L’ESA è nata come agenzia civile, pacifica e scientifica, con una governance intergovernativa distinta da quella dell’UE. L’ERS, pur non trasformandone la natura, apre un dibattito sul suo futuro ruolo: può un’agenzia nata per l’esplorazione diventare anche un attore di sicurezza?
Secondo Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, la risposta è sì, a condizione di mantenere la trasparenza e la cooperazione internazionale come principi cardine. “Resilience from Space non significa militarizzazione, ma rafforzamento della capacità europea di reagire e proteggere i propri cittadini”, ha dichiarato in una recente intervista.
In altre parole, si tratta di una nuova declinazione della neutralità europea, in cui la protezione dei cittadini diventa parte integrante della missione scientifica.
L’ERS, dunque, rappresenta un compromesso politico e simbolico: garantire sovranità e sicurezza senza rinunciare ai valori cooperativi che hanno guidato l’Europa nello spazio finora.
Verso un nuovo equilibrio orbitale
Se approvato al Ministeriale di Brema, l’ERS potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione per la politica spaziale europea. Una stagione in cui lo spazio non è più solo laboratorio scientifico, ma infrastruttura vitale per la sicurezza, la sostenibilità e la coesione del continente.
In un’epoca di crisi interconnesse – dalla guerra in Ucraina ai blackout digitali, dalle alluvioni record alla competizione industriale con Stati Uniti e Cina – la resilienza non è più un concetto astratto. È una capacità da costruire, mantenere e difendere.
L’ESA, con il suo primo programma ibrido, prova a farlo dal cielo: osservando, connettendo e proteggendo un’Europa che ha finalmente deciso di guardare allo spazio non solo come laboratorio scientifico, ma come strumento della propria autonomia e della propria sicurezza collettiva.