Voci e volti della crisi climatica: il racconto del documentario “Il prezzo che paghiamo”
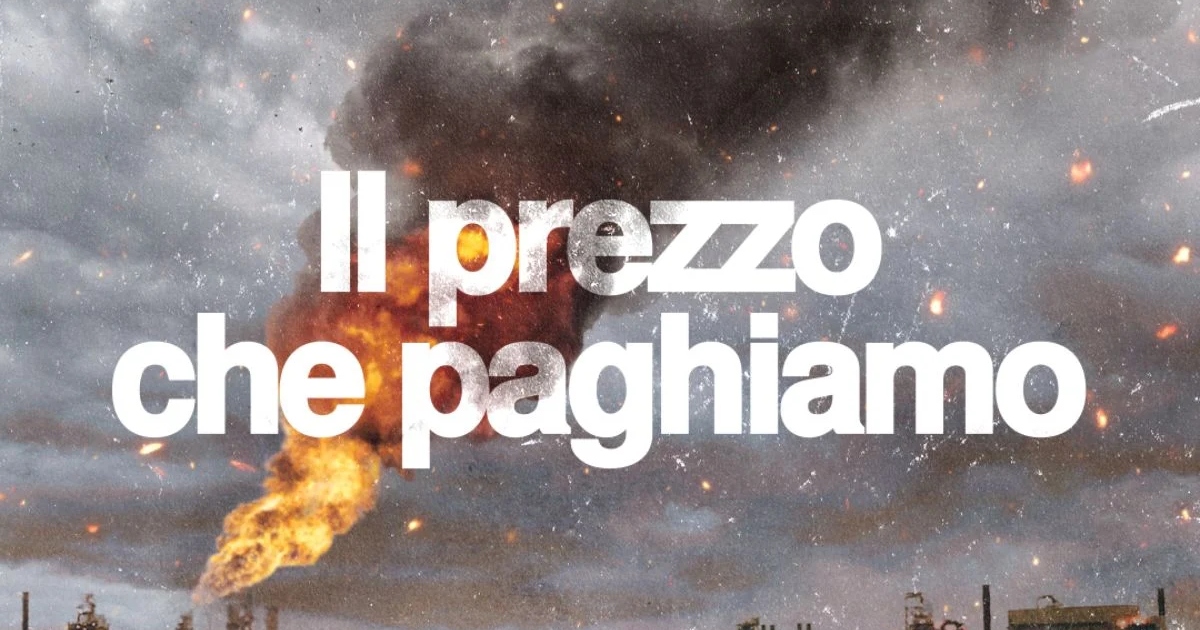
“Dal 2004 al 2024 il cambiamento climatico ha contribuito ad aggravare i dieci eventi metereologici più mortali, causando oltre 570.000 vittime a livello globale”. Inizia così il documentario Il prezzo che paghiamo, scritto e diretto da Sara Manisera. Una frase che non lascia dubbi.
C’è Maria Gordini, agricoltrice dell’Emilia-Romagna, che ha perso la casa e l’azienda durante le alluvioni del 2023 e 2024. Ci sono Camilla Nigro, Isabella Abate e Giorgio Santoriello, che in Basilicata convivono con le conseguenze delle attività estrattive di ENI, Shell e TotalEnergies, in un territorio che ospita il più grande giacimento petrolifero su terra d’Europa occidentale. Ne Il prezzo che paghiamo ci sono storie di persone comuni i cui destini sono inevitabilmente condizionati dalla crisi climatica e dall'industria fossile.
Il racconto delle vicende personali di Maria, Camilla, Isabella e Giorgio, alternato alle testimonianze e alle analisi di ricercatori, giornalisti e attivisti, mette in luce le connessioni tra l'estrazione del petrolio e le devastanti ricadute sociali, ambientali ed economiche, dalla contaminazione delle terre e delle acque, fino alle alluvioni e ai fenomeni climatici estremi. Un viaggio che invita a chiedersi: Chi paga davvero il prezzo della crisi climatica?
Il prezzo che paghiamo però non è solo un titolo, ma una domanda che accompagna lo spettatore lungo tutto il percorso narrativo. Chi sostiene davvero il peso della crisi climatica? Non le grandi compagnie fossili, raramente nominate nei media italiani, ma persone come Maria, Camilla, Isabella e Giorgio, le cui vite quotidiane portano il segno delle scelte industriali e politiche di decenni. Abbiamo intervistato Sara Manisera che ci ha raccontato com’è nato il progetto che ha coinvolto tre realtà diverse ma complementari: Greenpeace, ReCommon e FADA Collective.
Come nasce l’idea de Il prezzo che paghiamo?
Il prezzo che paghiamo nasce dall’esigenza di raccontare alle persone le cause e le conseguenze della crisi climatica. In Italia, purtroppo, nei media manca ancora uno spazio adeguato per parlare della crisi climatica e delle sue origini. L’obiettivo era proprio quello di provare a “unire i puntini”: si parla spesso di fenomeni atmosferici estremi — alluvioni, ondate di calore, grandinate — ma raramente li si mette in relazione con le cause di origine antropica, cioè con l’aumento delle emissioni di CO₂ legate all’uso dei combustibili fossili. Sentivo quindi l’urgenza, come giornalista che da anni si occupa di ambiente, crisi climatica e degli impatti dell’industria estrattiva (soprattutto oil & gas a livello internazionale), di raccontare questa connessione.
In questo senso, la collaborazione con Greenpeace e ReCommon è stata una sorta di convergenza naturale: anche loro avevano l’esigenza di dare voce a queste storie. Così abbiamo unito le forze per provare a colmare questo vuoto e raccontare non solo gli effetti, ma anche le cause profonde della crisi climatica.
Qual è l’importanza di unire associazioni come greenpeace e realtà come recommon?
L’importanza di unire realtà come Greenpeace e ReCommon, con la produzione esecutiva curata da noi di FADA, sta proprio nella possibilità di convergere nei messaggi, nelle visioni e negli sguardi. Non aveva senso procedere separati creando tre prodotti diversi: per questo, a mio avviso, è stato significativo che le due associazioni abbiano deciso di unirsi e di affidare a chi fa questo di mestiere — cioè la sottoscritta insieme al mio collettivo — la parte registica, autoriale, di scrittura, ripresa e produzione.
Spesso, infatti, i linguaggi usati da ReCommon e Greenpeace funzionano bene all’interno delle loro “bolle” di riferimento, ma l’obiettivo qui era diverso: ampliare il pubblico e utilizzare un linguaggio nuovo, a metà strada tra il reportage e la divulgazione.
Tu parti sempre dalle storie, perché secondo è importante proprio partire dalle storie per poi cercare di raccontare un fenomeno più complesso e globale?
L’obiettivo è stato quello di partire dalle storie umane, perché sono proprio le storie personali che trasformano un fenomeno grande e lontano in qualcosa di vicino e comprensibile. Durante tutta la produzione abbiamo insistito molto sull’inserire voci e testimonianze il più possibile autentiche, umane, quotidiane.
Penso, ad esempio, alla signora Maria, un’agricoltrice dell’Emilia-Romagna: potrebbe essere la mamma o la nonna di ciascuno di noi, e racconta con semplicità come ha perso tutto.
Scopri la nostra serie sulla crisi climatica: Il clima che vogliamo
Abbiamo bisogno di empatia, di commuovere e di rendere le storie vicine. Altrimenti il rischio è che, parlando di fenomeni complessi, le persone finiscano per allontanarsene. Il nostro obiettivo, invece, era suscitare empatia nel pubblico, nei cittadini e nelle cittadine che possono ritrovarsi nella situazione di Maria, immedesimandosi.
Naturalmente abbiamo lasciato spazio anche alla parte scientifica, alle fonti, agli articoli e agli archivi — che abbiamo utilizzato ampiamente, compresi quelli universitari. Ma era fondamentale, prima di tutto, emozionare. Ecco, sì: emozionare.









