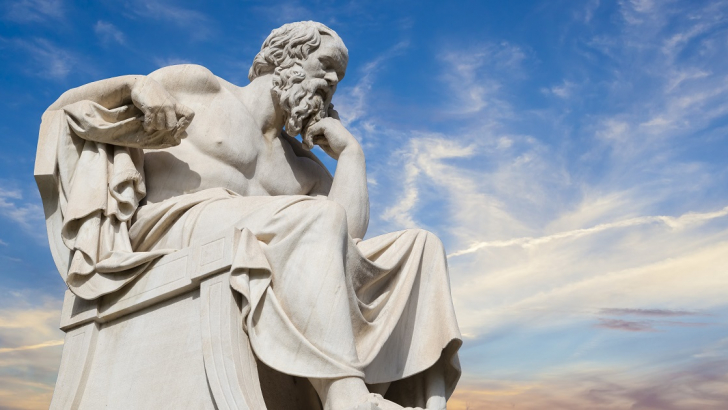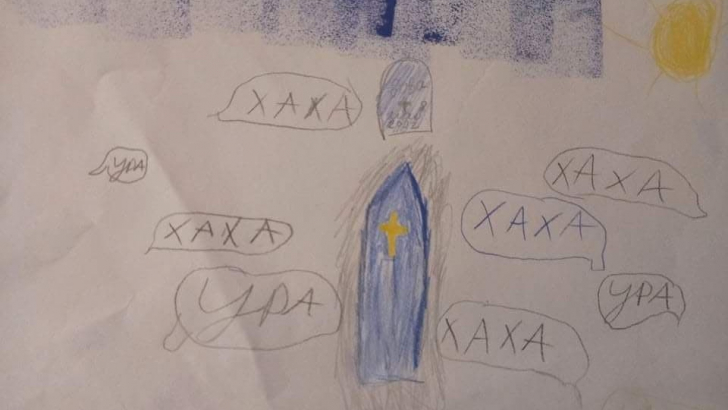La morte rimossa: perché dobbiamo tornare a parlarne

Per secoli l’inizio di novembre è stato un momento comune di riflessione e di memoria. Il giorno di Ognissanti e la commemorazione dei defunti scandivano il rapporto tra vivi e morti: si andava al cimitero a trovarli, portando con sé l’idea che la vicinanza non finisse con la vita biologica. Un tempo che negli ultimi anni si sta dissolvendo sotto i nostri occhi, sostituito da zucche, travestimenti e risate, utili più ad esorcizzare che a rielaborare. “L’ironia è il nostro modo di rispondere all’angoscia, perché siamo immersi in un estremo vuoto di senso– conferma Ines Testoni –. Sappiamo che la morte c’è, ma non abbiamo più un linguaggio credibile per affrontarla”.
Docente di Psicologia sociale e di Psicologia delle relazioni di fine vita all’Università di Padova, Ines Testoni dirige il master in Death Studies & The End of Life. Da anni studia come le società costruiscono – o rimuovono – l’idea di morte. Tra le sue pubblicazioni figurano, entrambi editi dal Saggiatore, Il grande libro della morte. Miti e riti dalla preistoria ai cyborg (2021) e il recentissimo Essere eterni. Manifesto contro la morte (2025), che invita a un radicale ripensamento della finitezza.
La rimozione moderna della morte
La trasformazione culturale che ha portato la morte a diventare un tabù ha radici profonde: “Con la rivoluzione scientifica e l’Illuminismo abbiamo iniziato a mettere in discussione non solo le superstizioni ma anche le certezze religiose, comprese quelle riguardanti l’aldilà, che oggi on appaiono più credibili per il senso comune – continua la studiosa –. Da lì ha preso avvio un processo irreversibile: se Dio muore, come scrive Nietzsche, allora non c’è più un discorso di salvezza che possa consolarci dalla finitezza”. Con un paradosso: da una parte siamo riusciti a liberarci dalle paure irrazionali del passato, dall’altra “non siamo più felici dei nostri antenati, o dei santi che si autoflagellavano per penitenza, perché almeno loro avevano davanti una prospettiva di salvezza. Oggi pensiamo che dopo la morte ci sia il nulla: una contraddizione che genera un’angoscia spesso paralizzante”.
“ Quanto più si entra nel merito della morte come problema filosofico e spirituale, tanto più diminuisce l’angoscia
Il rapporto con il corpo mostra questa lacerazione in modo brutale. Da un lato la medicina ci spinge verso la massimizzazione della vita biologica, talvolta fino all’accanimento terapeutico; dall’altro siamo diventati incapaci di accompagnare personalmente e spiritualmente ammalati, anziani e chiunque soffra una perdita. La morte oggi è ovunque: nelle notizie e nelle immagini delle guerre, nella pandemia che ha scosso il mondo. Eppure – dice Testoni – preferiamo non affrontarla: “La pandemia da Covid-19 ha traumatizzato profondamente la nostra umanità ma non è stata elaborata, e forse non è un caso che subito dopo siano esplosi nuovi conflitti. Il mancato confronto con la morte è disastroso: sia a livello individuale che collettivo”.
Un’impreparazione che esplode soprattutto nei momenti di crisi: “Quando ci troviamo davvero davanti al limite spesso reagiamo in modo disfunzionale: rabbia, violenza, richieste impossibili di soluzioni immediate. È ciò che vediamo ogni giorno in ospedali e luoghi di cura, con medici e infermieri aggrediti perché non possono garantire ciò che promette la nostra cultura, ovvero un benessere senza fine”.
Una nuova cultura della morte sta già nascendo
“Senza un’elaborazione culturale della morte diventiamo tutti più fragili, manipolabili e spaventati”, continua Testoni. Anche perché, nonostante tutti i tentativi di rimozione, la morte continua a essere ben presente – anche se in forma sublimata – sia nel subconscio individuale che nell’immaginario collettivo. A sorpresa, però, oggi ci si mette il digitale a riaprire varchi di consapevolezza: “La virtualità sta ridisegnando il modo di vivere la presenza e l’assenza. Sul web nascono gruppi di auto-aiuto che offrono spazi di elaborazione che la società non sa più dare: nascono così dal basso nuovi rituali e narrazioni, forme di vicinanza nella perdita diverse rispetto al passato”.
In parallelo anche le cure palliative e l’attenzione verso il fine-vita stanno assumono un ruolo sempre più centrale: “Il master in Death Studies ha formato in vent’anni centinaia di professionisti, contribuendo a un cambiamento concreto nella mentalità di chi gestisce ogni giorno sofferenza e perdita. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova cultura della morte e del morire: non dobbiamo temerla ma partecipare attivamente alla sua costruzione”.
“ Sul web nascono gruppi di auto-aiuto che offrono spazi di elaborazione che la società non sa più dare
Da questo punto di vista il lavoro educativo – insiste Testoni – è decisivo: “Non è vero che sulla morte non c’è nulla da sapere. Bisogna semplicemente mettere a disposizione tutta la ricchezza con cui l’umanità l’ha pensata: filosofia, arte, religioni, psicologia”. La formazione non è dunque un lusso per specialisti: “Quanto più si entra nel merito della morte come problema filosofico e spirituale, tanto più diminuisce l’angoscia”. Serve però competenza per evitare derive manipolative, giacché la paura della morte può essere più pericolosa della morte stessa.
Ripensare la finitezza
Proprio da questa esigenza di restituire alla morte una dimensione di pensiero e di senso nasce Essere eterni, l’ultimo libro di Testoni: non un manifesto contro la morte come evento biologico, “ma contro l’idea sbagliata che questa significhi annientamento”, chiarisce Testoni seguendo il pensiero di Emanuele Severino, per il quale – riprendendo la lezione di Parmenide e di Heidegger – credere che qualcosa possa diventare “niente” sarebbe una follia logica tipica dell’Occidente. Per spiegarsi la studiosa ricorre a una nota metafora: “Quando il sole tramonta, nessuno dice che è stato annientato: sappiamo che sta brillando altrove. Così è per noi: nascere e morire non sono sinonimi di apparire e scomparire”.
La risposta non sta né nella rimozione né nell’ossessione del morire – un continuo e limitante memento mori – ma in una consapevolezza pacificata non solo del limite, ma anche delle infinite potenzialità del vivere. Tutto ciò che esiste – afferma la docente – non può diventare altro da sé cadendo nel nulla: “Siamo già eterni, il problema è trovare un linguaggio per riconoscerlo”. Una visione che non vuole essere evasione spiritualistica né fragile consolazione: “Se siamo eterni, allora siamo inevitabilmente in relazione con tutti i momenti che abbiamo vissuto e con quelli vissuti da tutti gli altri. La spiritualità non è nient’altro che la nostra capacità di intuire questa verità profonda”. Il messaggio è un invito alla fiducia. “È importante non cedere al nichilismo – conclude Ines Testoni –. Se siamo destinati a essere in qualche modo eterni, allora ogni forma di esistenza merita rispetto, cura, attenzione”. Riscrivere il nostro rapporto con la morte non significa negarla: vuol solo dire imparare di nuovo a vivere.