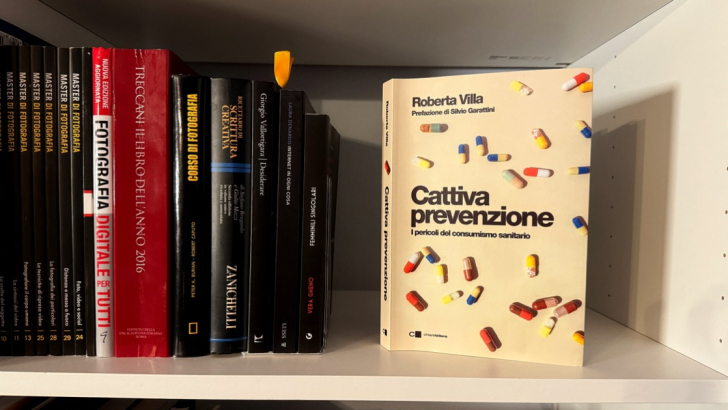Non un'unica via: il futuro è una questione collettiva. Intervista a Giulio Boccaletti

“Bisogna avere rispetto della complessità delle società umane”. Potrebbe essere una frase scritta da chi si occupa di antropologia o di scienze politiche. Invece esce dalla bocca di Giulio Boccaletti, fisico e attualmente direttore scientifico della Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), il centro di ricerca internazionale con sede in Italia che si occupa di studiare le interazioni tra clima e società. La pronuncia mentre lo intervistiamo a proposito del suo ultimo libro, appena uscito per Mondadori e intitolato Il futuro della natura.
Il libro si muove su tre piani intrecciati tra di loro. Il primo, il meno interessante, ma necessario per chi affrontasse la lettura a digiuno di informazioni sui cambiamenti del clima che stiamo vivendo, racconta le basi, anzi i “fondamenti”, come li indica Boccaletti, della scienza del clima. Non è una sezione che bombarda con informazioni tecniche (ce ne sono) e ansiogene. Serve per mostrare chiaramente che l’umanità è al punto in cui lo scenario di contenimento delle temperature medie entro 1,5 o anche 2 °C rispetto all’epoca preindustriale semplicemente non è più realistico.
Tolte di mezzo le incomprensioni, Boccaletti può quindi dedicarsi effettivamente a raccontare quali sono i possibili scenari futuri. Ma, attenzione, non sono quelli tecnici e scientifici che si trovano, per esempio, nei rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite. La questione è piuttosto decidere cosa vogliamo fare. Alla visione di come dobbiamo pensare oggi agli ecosistemi e alle infrastrutture ambientali è dedicata la seconda parte, mentre al terza, e ultima, si interroga e propone alcune idee su come sia possibile mantenere il buono della modernità, ma immaginando le conseguenze per il futuro e provando a gestire gli effetti che quest’immaginazione può avere sulle generazioni future.

È in queste due parti che Boccaletti si distacca dallo scienziato medio che parla pubblicamente di crisi climatica, perché non chiede alla società di rivolgersi alla scienza per farsi dire come deve gestire e pensare il futuro. “La scienza è fondamentale”, ci dice, “perché ci fornisce i dati, i fatti e può illuminarci su questo o quell’aspetto delle scelte che possiamo prendere”. Ma non è suo compito indicare la via, quella è una questione “politica”, non nel senso partitico del termine, ma di partecipazione alle decisioni comuni che tutta la cittadinanza è chiamata a fare. A partire, ovviamente, dalla istituzioni.
Deviazione storica necessaria
Per capire come Boccaletti sia arrivato alla proposta esposta nel libro, serve fare un detour nel passato. Gli esempi storici abbondano tra le sue pagine, perché servono a indicare qualcosa che è sotto i nostri occhi, ma che “come società abbiamo dimenticato”. Boccaletti si riferisce alla trasformazione del territorio che è avvenuta nel Novecento, la più evidente delle conseguenze enormi della modernità di cui scrive. “All’inizio del XX secolo, l’Italia era un paese povero, abitato da una maggioranza schiacciante di analfabeti”, spiega. In pochi decenni, è diventata una delle potenze economiche mondiali, ha sviluppato una società avanzata e moderna. E gran parte di questi risultati sono il risultato del fatto che “abbiamo infrastrutturato” il paesaggio: centrali idroelettriche per la produzione di energia, bonifiche delle aree paludose e umide, come per esempio nella Pianura Padana dove Boccaletti è nato e cresciuto.
Tutta questa trasformazione, però, tendiamo a darla per scontata, e spesso l’abbiamo resa invisibile. E abbiamo finora pensato di gestire queste infrastrutture come entità a sé, separate almeno in parte dal contesto sistemico in cui sono inserite. Ecco un esempio. Oggi Rimini è una delle capitali del turismo estivo italiano, capace di ospitare ogni anno qualche milione di turisti. Ma la città sorge in una zona scarsamente irrorata dall’acqua dolce. Per sopperire a questa mancanza, mezzo secolo fa si è costruita sull’Appennino romagnolo la diga di Ridracoli che, in un certo senso, è parte del sistema-Rimini. E per tenerla efficiente, abbiamo capito nel tempo, che serve gestire la foresta che la circonda, perché detriti, ramaglie e terriccio che finiscono nel lago artificiale finiscono per riempirlo, a discapito della capacità di immagazzinare la preziosa acqua dolce.
Quello di Rimini e Ridracoli è solo uno degli esempi che Boccaletti fa, e che servono a mostrare come da sempre il “paesaggio si sia co-evoluto assieme a noi”. Non c’è una natura separata dalla società, come vorrebbe una lettura romantica dell’ambiente, ma c’è un insieme di sistemi complessi, determinati da processi altrettanto complicati, che - e questo è un punto fondamentale nella storia raccontata da Boccaletti - “possono essere gestiti”. Chiude, così la porta, a quelle visioni ambientaliste che definisce “manichee” che invitano a un ritorno alla natura, “semplicemente perché quella natura non esiste più”, soprattutto se guardiamo all’Italia e agli altri paesi industrializzati: è solo una piccola percentuale del territorio nazionale che è davvero selvaggio, mai intaccato dall’attività umana.
Quale futuro
Mettendo insieme quest’analisi con le conoscenze scientifiche, potremmo riassumere il Boccaletti-pensiero scrivendo che il futuro in cui le cose rimarranno come prima, cioè come nel Novecento che ha basato le proprie economie sui combustibili fossili, non è realistico. Ma - buona notizia - abbiamo le possibilità di governare processi complessi che possono farci sperare in un futuro non apocalittico. La scienza può darci la ricetta migliore? “Non esiste: qualsiasi cosa decidiamo di fare oggi avrà conseguenze sul futuro”, spiega Boccaletti. “Non esiste cioè una scelta più giusta rispetto alle altre, ma esistono delle possibili traiettorie che possiamo decidere insieme”, consapevoli delle conseguenze e del loro costo.
Questo è il nocciolo politico del libro del direttore scientifico del CMCC. Che ci ricorda come queste questioni non riguardino il governo e lo Stato, ma tutti i cittadini e tutte le cittadine. Non solo perché le conseguenze delle scelte saranno necessariamente collettive. E non solo perché è giusto assumerci le nostre responsabilità. Ma è proprio l’ordinamento costituzionale a chiedercelo. L’Articolo 3 della Costituzione, quello che sancisce l’uguaglianza delle persone di fronte alla legge, nella seconda parte, dice che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. E qui, ci sottolinea Boccaletti, non si parla “dello Stato o del Governo, ma della Repubblica, cioè tutti noi”.