“Cattiva prevenzione” di Roberta Villa: il lato oscuro di esami e check-up
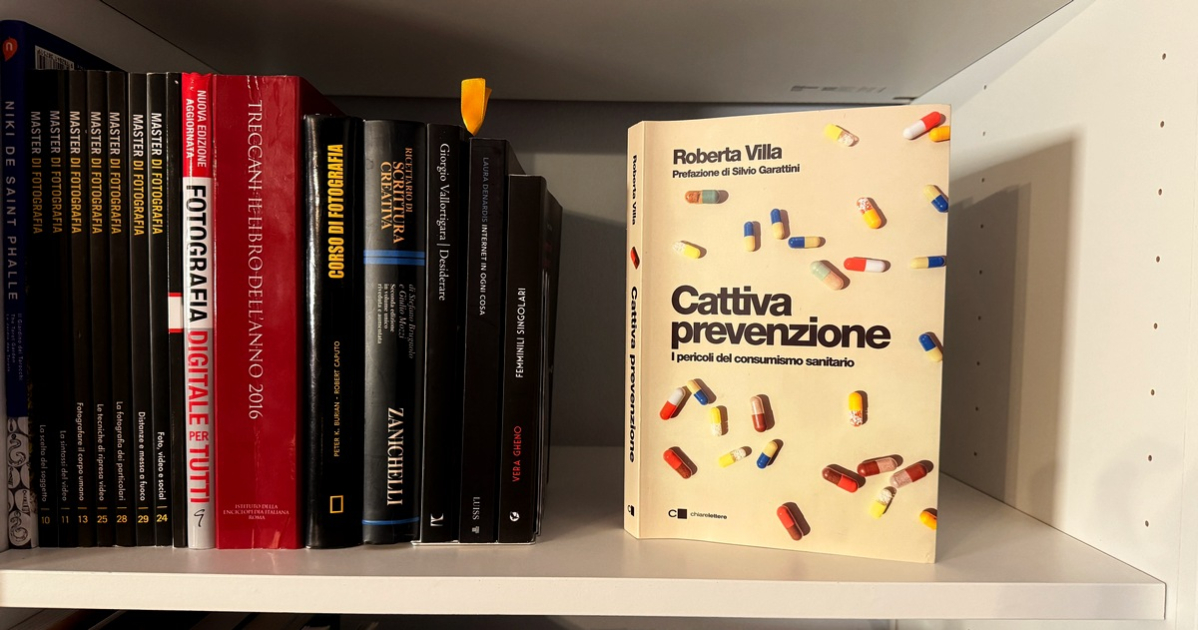
Prevenire è meglio che curare, diceva la saggezza popolare. E fino a qui si può anche essere d’accordo, però bisognerebbe capire meglio cosa si intende con “prevenire”.
Più problemi sorgono quando la frase, magari pronunciata da un medico è “meglio un esame in più che uno in meno”: potrebbe sembrare logico e intuitivo, eppure ci sono dei casi in cui non è vero, ed è dimostrato scientificamente.
Chi volesse sfatare i falsi miti sulla prevenzione, da oggi, 28 ottobre, ha uno strumento in più, perché è uscito il libro Cattiva prevenzione – i pericoli del consumismo sanitario di Roberta Villa, medica e divulgatrice, per Chiarelettere.
Villa, che già in passato con il suo Controglossario di medicina aveva dimostrato il suo interesse per il significato delle parole, inserisce in apertura la definizione di prevenzione dell’Enciclopedia Treccani: “In campo medico, il tentativo di evitare la comparsa di una malattia, o di una sua specifica manifestazione o di un suo aggravamento o recidiva fino a un possibile evento fatale, nonché il complesso delle procedure messe in atto per raggiungere questo scopo”. Eppure siamo distanti da farci un’idea di cosa significhi in pratica. Per questo si procede a una distinzione ulteriore, quella di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
L’obiettivo della prevenzione primaria è impedire che una malattia si presenti: vaccinazioni, campagne per smettere di fumare, promozione dell’attività fisica e altre iniziative di questo tipo: si lavora a monte, sulla riduzione dei fattori di rischio.
Per la prevenzione secondaria, si parte dall’idea che ci sia una malattia silente. L’obiettivo è scovarla sul nascere, in una fase precoce in cui i sintomi non si vedono ancora e gli interventi funzionano meglio.
Gli strumenti sono, a seconda dell’età, screening oncologici, controlli della pressione, controlli del colesterolo e altri esami di vario tipo. Nel caso della prevenzione terziaria, la malattia c’è già, ma si possono limitare i danni evitando complicanze e peggioramenti (un esempio sono i controlli per le persone con diabete, che è un fattore di rischio per i problemi cardiovascolari).
Se funziona non succede niente
Il “difetto” della prevenzione è che quando funziona non possiamo vederlo: se arrivi a 90 anni senza gravi problemi di salute è perché hai sempre avuto un’alimentazione sana, non hai fumato e bevuto alcol e facevi sport o per puro caso? Qui si gioca sulle probabilità, ma la prevenzione primaria è facile da sottovalutare, a differenza di quella secondaria, i cui effetti potrebbero essere sovrastimati.
“ Prevenire significa affrontare un costo certo (in termini di economici, di tempo o di volontà) in cambio di un beneficio che invece non sarà sempre dimostrato Roberta Villa
A volte la medicina basata sull’evidenza è controintuitiva, e per il singolo è normale che sia così: se a una persona durante un controllo fatto in assenza di sintomi viene trovato e poi asportato un tumore, quella persona sarà contenta, e magari penserà che la prevenzione le ha salvato la vita. Fatti come questo contribuiscono a spiegare il gradimento di tutti quei post dei vip che, dopo aver scoperto di avere una malattia, invitano i loro follower a fare prevenzione, cioè a farsi dei controlli. Eppure la scienza (nelle note del libro sono citati tutti gli studi presi in considerazione) suggerisce che no, quasi mai questo tipo di prevenzione salva la vita: probabilmente il tumore sarebbe stato scoperto, e curato, all’esordio dei sintomi, e il risultato sarebbe stato lo stesso. Oppure, come può capitare nel caso di alcuni tumori alla prostata o al seno, non si sarebbe mai manifestato.
Cosa significa davvero “salvare una vita”?
A volte un esame viene prescritto anche se le azioni successive non cambierebbero a seconda del responso, e questa è pessima prevenzione. Se per esempio il sospetto è quello di un cancro alla prostata in un paziente 90enne, è lecito fargli fare degli accertamenti, per poi magari dovergli prescrivere delle terapie che potrebbero favorire la sua morte molto prima del tumore? E chi ha risposto di sì, manterrebbe la sua opinione sapendo che dalle autopsie disposte per altre cause emerge che più del 50% degli ultranovantenni testati viveva serenamente con un tumore alla prostata che non aveva mai dato problemi?
E sì, qualcuno potrebbe in effetti salvarsi per un controllo in più, ma quante persone dobbiamo testare per salvarne una? E quale impatto hanno tutti gli altri test inutili sul sistema sanitario (anche chi sceglie il privato impegna macchine e personale che non potranno fare esami più utili ad altri), sulle finanze, pubbliche o del singolo, e sull’ambiente (l’ambito medico è uno dei pochi in cui si continua a usare ampiamente la plastica perché non ci sono alternative praticabili, per esempio)? Bisognerebbe preoccuparsi di più anche degli effetti sulla psiche di quella persona che fa quel controllo di troppo e che, se è sfortunata, viene scagliata in un girone infernale di altre visite, prescritte o per eccessivo scrupolo o per condizioni per cui all’esordio è indicata solo una vigile attesa che, lo dice la parola stessa, ti fa stare sul chi vive facendoti sentire malato, quando magari non lo sei ancora: prendere i sani e spostarli nella categoria dei malati è uno degli effetti meno considerati della cattiva prevenzione ma, alla luce di tutto questo, siamo ancora sicuri che “è meglio un esame in più che uno in meno”?
Il ruolo del marketing
Ma perché si fanno tutti questi esami inutili? I motivi sono molti, e vengono tutti lucidemente analalizzati nel libro.
Uno però dovrebbe farci riflettere più degli altri: la medicina sta sempre più diventando un business, con tanto di obiettivi e budget da rispettare nelle strutture private. Se centrare gli obiettivi di budget diventa prioritario, bisogna individuare delle micro-azioni che portino a centrarli, come si fa per ogni strategia aziendale, e una di queste potrebbe essere aumentare il numero dei clienti. Per farlo, quasi tutte le altre aziende hanno un’arma nel loro arsenale: la pubblicità. Lo sa bene chi si è fatto sanzionare per aver detto chiaramente: “La cellulite è una malattia”. Non è vero, non lo è, ma pensare che lo sia ti motiva a “curarti” comprando quel prodotto, perché se non lo fai sei un po’ irresponsabile. Se come azienda ti sanzionano, cambi pubblicità, ma intanto sei così in attivo che quella sanzione non impedisce ai vertici aziendali di dormire la notte. Nel caso di medicine non da banco, invece, o nel caso degli esami, l’arma della pubblicità non c’è: la legge italiana impedisce di farla. Ma ostacoli così trascurabili non hanno mai fermato i geni del marketing, che hanno bypassato il problema facendo la pubblicità alla malattia.
Roberta Villa presenterà il suo nuovo libro al Cicap fest 2025: scopri tutto il programma
Apparentemente, infatti, non c’è nulla di male nel sensibilizzare le persone e nel far conoscere loro la sintomatologia o le modalità di contagio di qualcosa che magari non sanno di avere. Nessuno potrebbe prendersela con la giornata mondiale contro l’AIDS, che tra i vari obiettivi ha quello di aumentare il numero di persone che diventano consapevoli di aver avuto comportamenti a rischio e si vanno a fare il test hiv.
Ma se la campagna di sensibilizzazione riguarda un problema come la stitichezza (qualcuno per caso non si accorge di essere stitico?) il discorso cambia, soprattutto se poco dopo esce provvidenzialmente un nuovo farmaco per combattere i problemi legati alla stipsi cronica.
I test genetici: utili o solo di moda?
Nel grande contenitore della “prevenzione”, oggi finiscono anche i test genetici predittivi, che promettono di dirci in anticipo quali malattie potremmo sviluppare in futuro. Sulla carta suona promettente, nella realtà, però, la genetica lavora su probabilità e non su certezze. Salvo rari casi (come quello che ha portato alla mastectomia bilaterale Angelina Jolie), sapere di avere un gene che aumenta il rischio non cambia né la diagnosi né le cure, ma in compenso questi test svuotano il portafoglio e alimentano l’ansia, perché ti sembra di avere una spada di Damocle che incombe sulla testa quando in realtà non è nemmeno sicuro che ti ammalerai: fuori dagli scenari ad alto rischio, la medicina predittiva rischia di diventare una fabbrica di ansia, perché si può uscire da un laboratorio con una lista di decine di condizioni potenzialmente in agguato e senza un medico che aiuti a interpretare quelle percentuali.
E questo solo quando si parla di malattie, ma ci sono anche dei test per anticipare la malattia ben oltre ogni necessità, come il test genetico per l’intolleranza al lattosio. L’esame può rivelare una predisposizione che in molti casi rimarrà silente per anni, forse per tutta la vita. Nel frattempo, però, chi riceve un risultato positivo rischia di modificare la propria dieta senza alcun motivo, scegliendo prodotti senza lattosio molto più costosi e alimentando un mercato redditizio che gioca sulla paura del futuro.
“ A che serve, per esempio, sapere di avere una predisposizione genetica a sviluppare intolleranza al lattosio? Finché lo digerisci, bene; quando basterà un cappuccino a farti correre in bagno smetterai di bere latte e assumere latticini Roberta Villa
Cattiva prevenzione: il caso del PSA
Quelli citati sono solo alcuni esempi di come stiamo ipermedicalizzando condizioni comuni, e di come la deriva che sta prendendo la prevenzione stia ignorando principi fondamentali come il rapporto costi/benefici di un test o di un intervento.
Anche solo un esame del sangue può essere controproducente, come dimostra il caso degli esami per dosare il PSA, una proteina prodotta dalla prostata che, a livelli alti, potrebbe indicare la presenza di un tumore. Peccato che i dati ci dicono che tre uomini su quattro con PSA alto non hanno il tumore, mentre uno su sette con PSA normale ce l’ha comunque.
Un risultato sospetto può portare a una lunga catena di indagini: risonanze magnetiche, ecografie, biopsie, fino a interventi chirurgici che possono causare incontinenza e impotenza, per un tumore che, ricordiamolo, può anche restare silente tutta la vita.
Gli studi hanno dimostrato che per evitare un singolo decesso bisogna invitare allo screening oltre 1.400 uomini, ma soprattutto trattarne inutilmente 50: uno screening di questo tipo può essere una priorità di un sistema sanitario che fatica a curare anche chi è effettivamente malato?
Poche semplici regole e meno controllo
Ma allora cosa dobbiamo fare per fare buona prevenzione? In realtà le indicazioni non sono molte, ma in pochi le rispettiamo tutte: curare la dieta, limitando il consumo di carne, soprattutto quella rossa, e inserendo molta frutta e verdura, smettere di fumare e possibilmente anche di bere, fare almeno due ore e mezza di attività aerobica ogni settimana, dormire abbastanza e farsi quei tre screening, forniti gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, che hanno scientificamente dimostrato di individuare malattie che possiamo curare meglio agendo prima: quello per il tumore al collo dell’utero, quello per il tumore al seno (su cui c’è ancora un certo dibattito per modalità e fasce d’età) e quello per il tumore al colon-retto.
Per il resto, in assenza di sintomi o condizioni di rischio, è meglio stare lontano da esami, test genetici alla moda e altri screening dalla dubbia efficacia. Non si può comprare la vita eterna, e nemmeno la salute a suon di test: se nella definizione di salute includiamo anche quella mentale, probabilmente staremo meglio accettando che a volte l’esito di una malattia è aleatorio, e che non possiamo avere il controllo di tutto.









