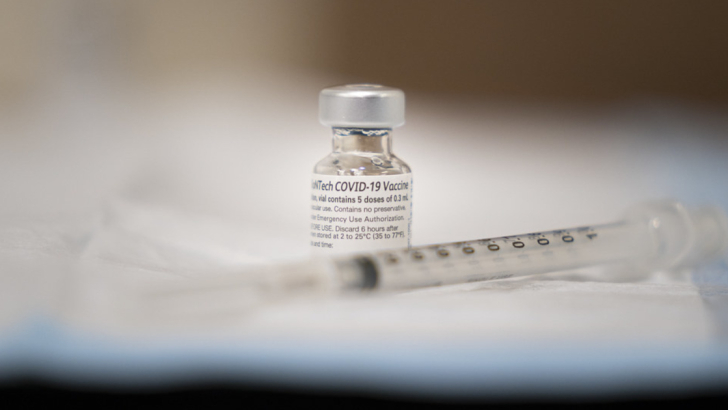In Salute. Il nuovo Piano di azione nazionale per la salute mentale

One health, inclusione, continuità delle cure, approccio multidimensionale e multidisciplinare: sono questi alcuni dei concetti chiave al centro del Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030, pubblicato dal Ministero della salute a luglio 2025.
Il documento - che, come vedremo più avanti, ha ricevuto anche alcune critiche - è stato redatto da un tavolo tecnico composto da esperti e rappresentanti del settore. Mette in luce le principali aree di intervento per la tutela del diritto alla salute mentale di cittadine e cittadini, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione italiana – il quale considera la salute non solo come come diritto fondamentale dell’individuo, ma anche un interesse della collettività – e della definizione dell’OMS, secondo la quale “non c’è salute senza salute mentale”.
Per questo il PANSM richiama esplicitamente il paradigma del One health, secondo il quale salute fisica, mentale e ambientale sono strettamente interconnesse, e propone l’adozione di un sistema definito bio-psico-sociale, definito come “una strategia di approccio alla persona sulla base di una concezione multidimensionale della salute” che non si basa solo sugli aspetti prettamente clinici, ma tiene conto anche di variabili ambientali, contesti sociali, vicissitudini personali. Viene per questo rimarcata più volte l’importanza di adottare piani di cura individualizzati e interventi integrati.
Come rimarcato nel Piano di azione nazionale, il benessere psicologico può essere compromesso da una molteplicità di fattori: discriminazioni, instabilità economica e abitativa, difficoltà relazionali, condizioni ambientali e climatiche. A questi si aggiungono i profondi cambiamenti sociali, tecnologici e culturali degli ultimi anni, che hanno reso più evidente la centralità della salute mentale. Vengono segnalate, inoltre, la crescente diffusione di sostanze psicoattive, l’uso eccessivo del web e dei social media e l’aumento significativo di ansia e depressione (soprattutto tra i giovani e gli anziani) legato alla pandemia.
In questo contesto, il PANSM si propone di essere uno “strumento strategico e operativo” per garantire una tutela uniforme del diritto alla salute mentale su tutto il territorio nazionale, lungo l’intero arco della vita. Viene sottolineata inoltre l’importanza di una rete di servizi integrata e sinergica, fondata su multidisciplinarità, accessibilità, personalizzazione degli interventi e coordinamento tra strutture sanitarie, servizi sociali, scuole, luoghi di lavoro e comunità che comprenda anche il contrasto allo stigma, il rispetto della dignità della persona, l’inclusione e l’adesione alle evidenze scientifiche.
Il documento evidenzia, in particolare, sei aree di intervento: promozione, prevenzione e cura, infanzia e adolescenza, giustizia, gestione del rischio, integrazione sociale, ricerca e formazione.
Promozione, prevenzione e cura
Tra i molti temi affrontati nel primo, denso capitolo del documento, spiccano i riferimenti agli psicologi di primo livello – figure professionali formate in modo analogo ai medici di medicina generale, da integrare nei dipartimenti di salute mentale territoriali con lo scopo di gestire forme di disagio lieve o moderato – e alla telemedicina, considerata una risorsa strategica per migliorare l’accessibilità dei servizi, sulla base di esempi già consolidati in altri paesi europei e americani. Ci si propone, in particolare, di potenziare strumenti come la telepsichiatria, la televisita e il teleconsulto, da erogare non in sostituzione dell’assistenza in presenza, ma come supporto integrativo.
Più approfonditamente sono affrontati i temi dei disturbi mentali correlati all’uso di sostanze e alle diverse forme di dipendenza e della salute mentale perinatale.
Si segnala, in particolare, che in un anno (dal 2023 al 2024) i giovani tra i 15 e 19 anni che fanno uso di sostanze psicoattive sono aumentati, in particolare tra la popolazione studentesca. Colpisce che nell’ultimo anno i SerD (i Servizi per le Dipendenze patologiche) abbiano assistito 132.000 pazienti, e che gli accessi in Pronto Soccorso correlati all’uso di droghe siano stati 8.596 (con un aumento del 5% rispetto al 2022), il 12% dei quali ha necessitato di un ricovero. Questi numeri in crescita sono preoccupanti perché, come precisa il PANSM, la dipendenza da sostanze psicoattive riduce l’aspettativa di vita e rischia di compromettere lo sviluppo del sistema nervoso centrale nelle persone d’età inferiore ai 25 anni.
Per quanto riguarda invece la salute mentale perinatale, il documento segnala un aumento dei casi di depressione sia durante la gravidanza che nel post-partum. Nel 2022, i disturbi mentali perinatali interessavano il 15-20% delle donne in gravidanza e il 16-18% di quelle nel periodo post-partum, con percentuali più alte nei paesi a basso e medio reddito. In Italia, la quota di donne con sintomi riconducibili alla depressione post-partum è salita dall’11% del 2019 al 25% nel 2022, anche a causa della pandemia.
Per prevenire complicazioni gravi per la salute delle donne e dei nascituri, si sottolinea l’importanza di intervenire precocemente attraverso screening periodici da effettuare fin dal primo trimestre, percorsi terapeutici mirati e uniformi e una rete integrata di servizi madre-bambino. Il piano prevede, infatti, di migliorare il coordinamento tra consultori, reparti ospedalieri e specialisti in psicologia, ostetricia e neuropsichiatria infantile, con l’obiettivo di offrire supporto multidisciplinare e accessibile ai futuri genitori lungo tutto il percorso nascita.
Leggi anche: In Salute. Disuguaglianze sanitarie: gli interventi proposti dall’Oms
Infanzia e adolescenza, giustizia
Il PANSM definisce il periodo di passaggio dall’infanzia e dall’adolescenza all’età adulta come “una fase del ciclo della vita particolarmente complessa”, in cui l’eventuale comparsa di patologie psichiatriche, neurologiche o neuropsicologiche, se non trattate tempestivamente, può avere impatti negativi duraturi anche in l’età adulta.
Per garantire un’assistenza di qualità a bambini, bambine e adolescenti che hanno bisogno di cure psichiatriche o psicologiche, viene posta l’attenzione su due aspetti fondamentali: da una parte, la necessità di considerare la complessità dei già citati fattori bio-psico-sociali che possono impattare sul benessere psicologico del singolo paziente, offrendo quindi percorsi personalizzati e multidisciplinari; dall’altra, la continuità delle cure, che va garantita strutturando piani terapeutici ad hoc che accompagnino i pazienti nel delicato passaggio alla maggiore età.
L’attenzione alla salute mentale delle persone più giovani è centrale anche nel capitolo del PANSM dedicato alla giustizia e all’ambito forense. Il documento insiste sull’importanza della continuità assistenziale dei minori che hanno commesso reati, ai quali ci si propone di garantire supporto sia durante che dopo l’esecuzione della misura penale, distinguendo i casi in cui è necessario un trattamento sanitario vero e proprio da quelli in cui si richiede un percorso socio-educativo.
Il documento sottolinea anche l’importanza delle attività dei presidi sanitari penitenziari e delle sezioni psichiatriche all’interno delle carceri. Si stima, infatti, che tra il 10 e il 15% delle persone detenute abbiano un disturbo mentale, ma le articolazioni per la salute mentale presenti in questi luoghi dispongono di risorse sufficienti ad assistere solo lo 0,5% circa della popolazione detenuta; si ritiene quindi necessario un investimento che permetta di raggiungere almeno il 10%.
Ci si propone, inoltre, di migliorare le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ovvero le strutture sanitarie dedicate all’accoglienza di persone con problemi di salute mentale che hanno commesso reati, facendo sì che operino in base a protocolli ben definiti e con la partecipazione di esperti in ambito forense.

Rischio clinico e integrazione sociosanitaria
Tra le varie misure presenti nel Piano d’azione nazionale per il miglioramento del rischio clinico troviamo la “stesura di indicatori specifici di riferimento a livello regionale sulla base dell’analisi degli incident reporting verificatesi e della letteratura internazionale attuale”, oltre alla formazione del personale – per migliorare la capacità di riconoscere eventi d’allarme o casi avversi – e alla definizione di protocolli condivisi.
Per quanto riguarda invece la sicurezza sul luogo di lavoro degli operatori sanitari, il documento definisce i diversi ruoli riconosciuti alle diverse figure (nello specifico, il personale sanitario, le forze dell’ordine e le guardie giurate) deputate alla gestione dei pazienti con problemi di aggressività e alla prevenzione di eventi critici.
Nel capitolo dedicato all’integrazione sociale viene evidenziato il legame tra diritto alla salute mentale e inclusione. Se da una parte si evidenzia che la partecipazione sociale, l’empowement personale e l’accesso al mercato del lavoro costituiscono requisiti fondamentali per garantire la piena realizzazione dell’individuo, dall’altra si segnalano alcuni dei principali ostacoli che possono impedire l’inclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale. Tra questi troviamo, innanzitutto, le difficoltà abitative – che minacciano l’autostima e l’autodeterminazione – che ci si propone di risolvere aiutando chi ne abbia necessità a trovare la soluzione più adatta in base alle esigenze specifiche. Viene promossa anche la progettazione di percorsi di inclusione lavorativa per persone con disturbi mentali, supportandole quindi nella costruzione di una vita sociale e di relazione che “restituisce identità, autostima e dignità, oltre che mezzo reddituale ed economico per poter soddisfare in modo autonomo i bisogni della vita”.
Viene menzionata, inoltre, l’importanza di una comunicazione anti-stigma, volta cioè al contrasto degli stereotipi negativi e delle credenze infondate sulle persone con problemi di salute mentale, le quali vengono ancora troppo spesso etichettate come improduttive, incompetenti, imprevedibili o pericolose. Tali pregiudizi, ricorda il PANSM, non solo aumentano l’isolamento di queste persone, ma minano ulteriormente il loro benessere.
Ricerca e formazione
Nell’ultima parte del documento viene evidenziato il ruolo fondamentale delle università e degli enti scientifici, ai quali viene richiesto di rafforzare la collaborazione con le realtà cliniche per condurre, in primo luogo, ricerche sperimentali su fenomeni ancora poco noti, riguardanti, ad esempio, le caratteristiche di alcune dipendenze comportamentali o da sostanze d’abuso e l’impatto delle nuove tecnologie sulla salute mentale. Si specifica, inoltre, che tali indagini vadano svolte garantendo la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni raccolte; viene anche considerato fondamentale fare tesoro dei dati qualitativi e quantitativi raccolti attraverso la ricerca per la definizione di culture, politiche e normative evidence-based (ossia aderenti all’evidenze scientifiche).
Gli istituti di istruzione e ricerca vengono inoltre ritenuti fondamentali per la formazione non solo degli studenti e delle studentesse iscritti a percorsi di laurea legati alla salute, ma anche di chi opera in settori non strettamente sanitari, ma coinvolti nei servizi, nelle reti o nelle équipe di assistenza a persone con disagio mentale. In linea con la visione di una rete di intervento personalizzata e multidisciplinare promossa dal PANSM, viene considerato essenziale che tutte le figure attive nei percorsi di supporto siano adeguatamente preparate sulle diverse manifestazioni del disagio psichico, sulla gestione del rischio e delle emergenze, nonché sui quadri normativi di riferimento.
Leggi anche: La salute mentale all'università
Limiti e criticità
Va infine segnalato che il nuovo Piano d’azione nazionale per la salute mentale è stato oggetto di diverse critiche da parte di importanti realtà del settore, come il Consiglio nazionale degli psicologi (CNOP), oltre che da esperti ed esperte alla guida di associazioni e servizi dedicati alla salute mentale.
Tra i principali limiti evidenziati troviamo, innanzitutto, un’attenzione insufficiente al problema dello stigma, che sarebbe stato trattato in modo generico e affrettato, senza la pianificazione di strategie operative concrete basate sui dati scientifici. La mancanza di concretezza viene lamentata anche riguardo ad altri temi affrontati nel documento, considerato una mera sintesi di dati già raccolti e non il risultato di una reale consultazione con i diversi attori coinvolti. Non è stata inoltre apprezzata l’enfasi sui disturbi psichiatrici gravi presente nel PANSM, che tralascerebbe invece altre problematiche inerenti il benessere psicologico, legate allo stile di vita, alla salute fisica o al disagio sociale.
In conclusione, nonostante la volontà espressa nel documento di adottare un approccio più olistico e multidimensionale alla promozione della salute mentale, il nuovo Piano d’azione nazionale rischia, secondo queste critiche, di restare un elenco di buone intenzioni. Spetterà quindi alle istituzioni il compito di rendere operativi i principi delineati, in modo tale da strutturare un sistema accessibile, equo e in grado di rispondere alle necessità specifiche di chi vi si rivolge.