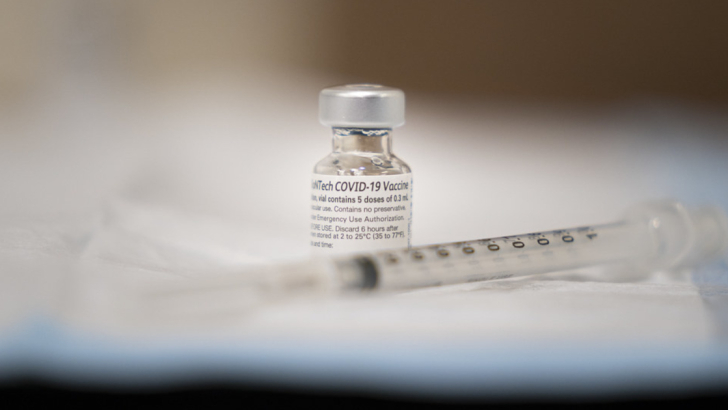In Salute. Case e ospedali di comunità, per un nuovo modello di assistenza territoriale

Nei giorni scorsi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato delle Linee di indirizzo che definiscono l’impegno dei medici di medicina generale all’interno delle case di comunità, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022.
Ma cosa sono le case di comunità? Potrebbe chiedersi chi non è del settore, magari proprio un paziente. E quali servizi vengono erogati al loro interno? Domande lecite, se si considera soprattutto che tali strutture sono state formalizzate solo pochi anni fa nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – pur avendo un loro antecedente nelle case della salute –, e che non sono ancora a regime sul territorio nazionale. Anzi, a dicembre 2024 solo il 15% circa delle (almeno) 1.038 strutture programmate ha attivato tutti i servizi previsti e poco più del 4% disponeva di personale medico e infermieristico.
Come sappiamo, il Pnrr è stato concepito per rilanciare l’economia dell’Italia e nel contempo promuovere la salute, la sostenibilità, la ricerca, l’inclusione, l’innovazione digitale, attraverso la pianificazione di una serie di investimenti e riforme che il nostro Paese dovrà realizzare entro il 2026. Originariamente suddiviso in sei missioni – ognuna delle quali comprende diverse componenti –, nel corso degli anni il programma ha subito modifiche tra cui, per esempio, l’aggiunta di una settima missione relativa al REPowerEU (il piano dell'UE per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e accelerare la transizione verde).
La missione 6, nello specifico, è interamente dedicata alla salute e propone un nuovo modello di organizzazione sanitaria territoriale, che garantisca servizi di prossimità facilmente accessibili. Di seguito cercheremo di offrire un quadro generale delle azioni proposte, con tutti i limiti che la sintesi di un tema tanto ampio necessariamente porta con sé.
Per una riforma dell’assistenza sanitaria territoriale
Vediamo innanzitutto cosa prevede il Pnrr in tema di salute. La missione 6 si articola in due componenti: “M6C1–Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” e “M6C2–Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.
La prima linea di intervento mira a introdurre un modello organizzativo che offra servizi più vicini alle persone, allo scopo di ridurre la pressione sugli ospedali. Attenzione particolare viene posta anche alla prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico in linea con il principio One Health.
I fondi messi a disposizione hanno lo scopo dunque di rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio attraverso la creazione di case di comunità. In secondo luogo devono essere utilizzati per aumentare le prestazioni in assistenza domiciliare, utilizzando anche strumenti come la telemedicina, con l’obiettivo di prendere in carico entro la metà del 2026 almeno il 10% delle persone con più di 65 anni, con una o più patologie croniche o non autosufficienti. Tale investimento comprende la realizzazione di centrali operative territoriali, con funzioni di coordinamento. I finanziamenti, infine, servono a potenziare l’assistenza sanitaria intermedia attraverso l’istituzione di ospedali di comunità, cioè strutture sanitarie che prevedono ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari di media/bassa intensità clinica.
La seconda linea di intervento prevista dalla missione 6 del Pnrr – sulla quale ci soffermiamo solo brevemente per completezza – si sviluppa invece su due fronti: da un lato l’aggiornamento tecnologico e digitale del sistema sanitario, dall’altro il potenziamento della formazione, della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico.
Più nello specifico, le misure e gli investimenti previsti intendono rafforzare l’infrastruttura tecnologica e digitale ospedaliera, attraverso l’acquisto di nuove apparecchiature sanitarie, la digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione di I e II livello, la dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, l’ammodernamento dei pronto soccorso e l’incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari secondari.
I fondi previsti dal Piano sono destinati poi a rendere più sicuri gli edifici ospedalieri, adeguandoli alle norme attuali per le costruzioni in zone soggette a rischio sismico; a completare e diffondere il fascicolo sanitario elettronico, e a erogare e monitorare i livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso sistemi informativi più efficaci.
Risorse sono destinate infine alla valorizzazione e al potenziamento della ricerca biomedica nel Sistema sanitario nazionale, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese, e al rafforzamento delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario attraverso la formazione del personale.
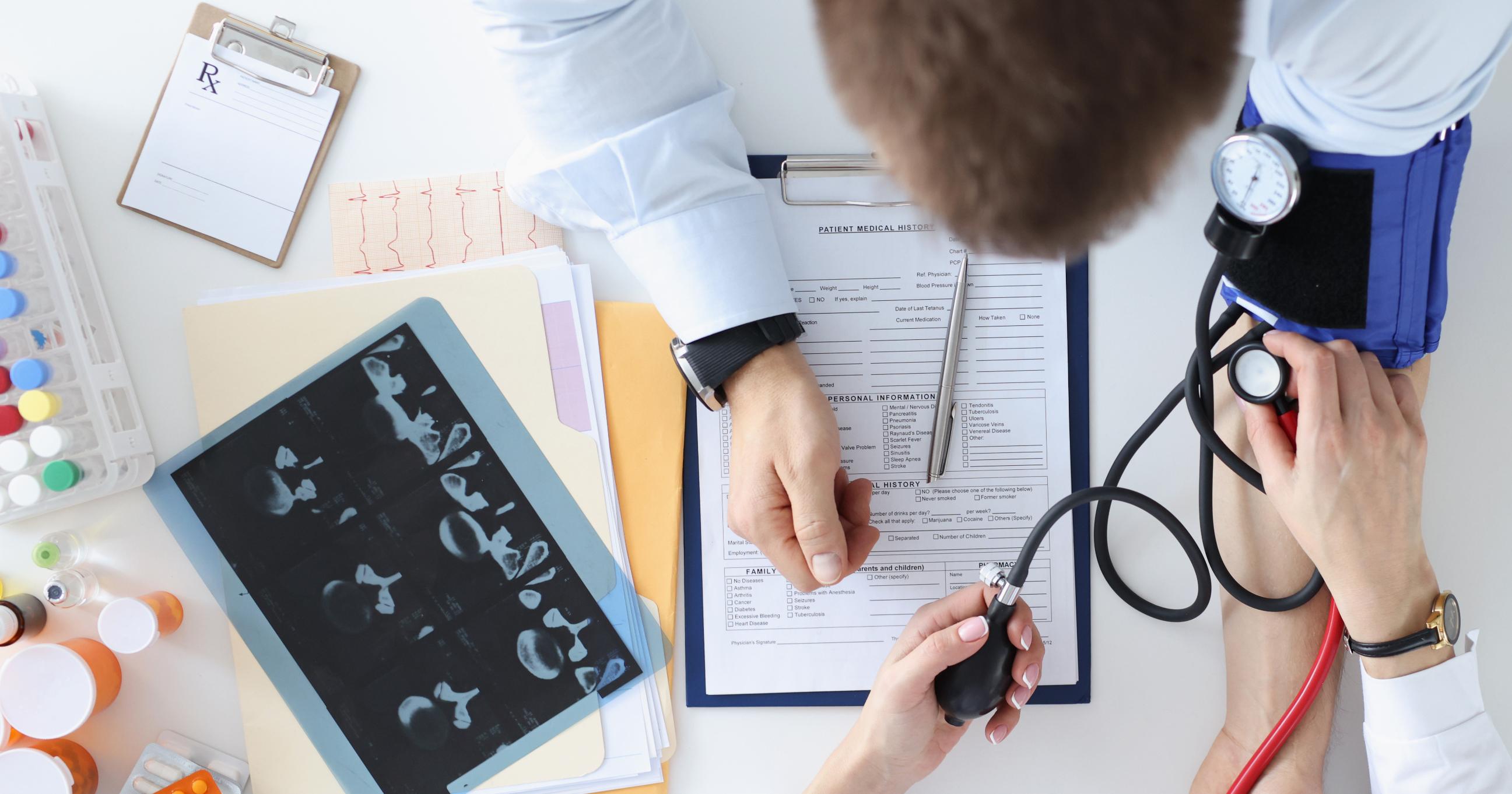
Medicina di popolazione e sanità d’iniziativa
La riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, così come delineata dal Pnrr, è regolamentata dal decreto ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022 che ridefinisce le funzioni del distretto (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale). “Il Servizio Sanitario Nazionale – si legge nel documento – si basa su tre principi fondamentali: universalità, uguaglianza ed equità. Il perseguimento di questi principi richiede un rafforzamento della sua capacità di operare come un sistema vicino alla comunità, progettato per le persone e con le persone”.
Il nuovo regolamento definisce in principio alcuni elementi cardine che costituiscono un cambio di paradigma nella presa in carico delle persone da parte del SSN. Per essere realmente efficaci i servizi sanitari devono saper tutelare, innanzitutto, la salute dell’intera comunità e non solo di chi richiede direttamente una prestazione. In questo caso si parla di medicina di popolazione, che ha lo scopo di mantenere cittadini e cittadine in buona salute, intervenendo sia sul piano della prevenzione che della cura e con particolare attenzione a chi soffre di patologie croniche, oggi in aumento.
Diventa fondamentale pertanto conoscere il profilo epidemiologico della popolazione, implementando sistemi di misurazione e stratificazione della popolazione sulla base del rischio. Il decreto del 2022 in particolare stratifica i bisogni di salute della popolazione in sei livelli, per ciascuno dei quali distingue la condizione clinica, i bisogni assistenziali e le azioni necessarie.
Ciò consente di programmare e differenziare gli opportuni interventi, individuando le priorità, secondo un modello assistenziale orientato alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Si parla, a tal proposito, di sanità di iniziativa che agisce prima che si manifestino i sintomi di una malattia o che una condizione già esistente peggiori. A differenza dell'approccio tradizionale (sanità di attesa), non attende cioè che il paziente si rivolga ai servizi sanitari, ma si attiva in modo proattivo. Questo metodo è efficace soprattutto nella gestione delle patologie croniche; prevede l’individuazione delle persone a rischio di malattia, l'educazione a corretti stili di vita, la presa in carico negli stadi iniziali delle patologie, la programmazione di medio-lungo periodo delle attività di assistenza, il coinvolgimento delle figure interessate nel processo di assistenza come i familiari o i caregiver. In tale contesto, il progetto di salute (come definito dal D.M. n. 77) è lo strumento di programmazione, gestione e verifica della presa in carico della persona nell’ambito dei servizi sanitari territoriali.
Le case di comunità, nodo centrale della riforma territoriale
Nodo centrale della riforma sono le case della comunità, evoluzione delle precedenti case della salute. Sono definite dalla normativa come “luoghi fisici e di facile individuazione” ai quali i cittadini possono accedere per i bisogni di assistenza sanitaria, e possono essere di due tipi: hub, una ogni 40.000-50.000 abitanti, di dimensioni più grandi e con un’offerta più ampia di servizi; e spoke, più piccole e diffuse capillarmente sul territorio. Le prime devono garantire presenza medica e infermieristica 24 ore al giorno, sette giorni su sette; le seconde invece 12 ore al giorno, sei giorni su sette. Le case di comunità hub, in particolare, costituiscono il riferimento naturale dell’attuale unità complessa delle cure primarie (Uccp) e delle aggregazioni funzionali territoriali (Aft) dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Per la realizzazione delle case della comunità hub, nel 2024 l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha pubblicato delle specifiche linee di indirizzo.
Vediamo dunque quali sono le principali caratteristiche delle nuove strutture. Sia nelle case di comunità hub che in quelle spoke, è obbligatoria l’erogazione di alcuni servizi fondamentali. Le cure primarie, innanzitutto, sono garantite da équipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e comunità e così via. È previsto poi un punto unico di accesso, che costituisce il luogo in cui il cittadino trova accoglienza e supporto amministrativo-organizzativo. Dovranno essere garantiti inoltre assistenza domiciliare, prestazioni infermieristiche e visite specialistiche ambulatoriali per le patologie più comuni, in particolare nei settori della cardiologia, pneumologia, neurologia, diabetologia, oncologia, geriatria e medicina interna. Sono contemplati, infine, un sistema di prenotazione integrato con il CUP aziendale, il collegamento con i servizi sociali e il coinvolgimento attivo della comunità all’interno dei processi di promozione della salute, prevenzione e cura.
Da casa della salute a casa della comunità: l'esempio di Portomaggiore e Ostellato in Emilia Romagna
Nelle case di comunità hub è obbligatoria anche la presenza di un punto prelievi, servizi di continuità assistenziale e servizi diagnostici di base per il monitoraggio della cronicità, dunque la possibilità di eseguire ecografie, elettrocardiogrammi, retinografie, spirometrie.
Sono invece raccomandati, sia nelle strutture hub che spoke, i servizi relativi alla salute mentale, alle dipendenze patologiche, alla neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, nonché alla medicina dello sport. Facoltative infine le attività di consultorio e quelle rivolte ai minori, i programmi di screening e gli interventi di salute pubblica come le vaccinazioni per la fascia 0-18.
Se questo è quanto previsto dal decreto ministeriale del 2022, la realizzazione delle case di comunità sta procedendo molto a rilento. Come si è detto, entro il 30 giugno 2026 dovrebbero essere operative in Italia almeno 1.038 case della comunità, dotate di servizi e personale sanitario. Tuttavia a dicembre 2024, stando a quanto riferisce Gimbe in un comunicato stampa del 29 luglio 2025, solo 164 strutture (15,8%) avevano attivato tutti i servizi previsti e, tra queste, appena 46 (4,4% del totale) disponevano di personale medico e infermieristico. In 485 strutture (46,7%) risultava attivo un solo servizio, mentre le rimanenti 389 case di comunità (37,5%) non risultavano aver attivato alcun servizio.
Fare rete: la centrale operativa territoriale
Proprio per il loro ruolo centrale sul territorio, le case di comunità hub dovranno adottare meccanismi di coordinamento su quattro fronti: innanzitutto tra i vari professionisti della salute che prestano servizio in queste strutture; dovranno poi lavorare in sinergia con le case di comunità spoke, per rispondere alle esigenze di capillarità e prossimità dei servizi. Dovranno collaborare con gli altri settori dell’assistenza sanitaria territoriale, che comprendono per esempio l’assistenza domiciliare, gli ospedali di comunità, hospice e rete delle cure palliative, consultori familiari e attività rivolte ai minori, residenze sanitarie assistenziali, servizi per la salute mentale, dipendenze e disabilità, servizi sociali e altre forme di strutture intermedie e servizi. Ogni casa di comunità hub, infine, dovrà essere in rete con l’attività ospedaliera.
Per coordinare tutte queste attività, si prevede l’istituzione di una centrale operativa territoriale ogni 100.000 abitanti, con personale infermieristico e di supporto, che dovrà essere operativa sette giorni su sette e dotata di infrastrutture tecnologiche ed informatiche, tra cui software con accesso al fascicolo sanitario elettronico e ai principali database aziendali.
Ospedali di comunità
Con una funzione intermedia tra assistenza domiciliare e ricovero, l’ospedale di comunità è un altro dei servizi previsti dalla riforma. È una struttura sanitaria territoriale pensata per pazienti che, dopo un disturbo improvviso e di lieve entità o una riacutizzazione di patologie croniche, hanno bisogno di cure a bassa intensità clinica. Si tratta di interventi che potrebbero essere erogati anche a casa, ma che richiedono un’assistenza infermieristica continua, anche durante la notte, non sempre possibile a casa o in assenza di un ambiente domestico adatto. Le cure e gli eventuali ricoveri sono rivolti dunque principalmente a persone fragili, con patologie croniche, o affette da multimorbidità, a pazienti che sono stati dimessi da un ospedale per acuti ma necessitano ancora di assistenza infermieristica o medica, o che a casa hanno avuto un peggioramento della loro condizione clinica tale però da non richiedere un ricovero ospedaliero nelle strutture per acuti.
La riforma prevede un ospedale di comunità dotato di 20 posti letto ogni 100.000 abitanti e il ricovero non potrà superare i 30 giorni. Può avere una sede propria o essere collocato in una casa della comunità, ma anche in strutture sanitarie polifunzionali, in strutture residenziali sociosanitarie o ancora essere dislocato in una struttura ospedaliera, ma deve essere chiaramente riconducibile ai servizi compresi nell'assistenza territoriale distrettuale.
Anche in questo caso la realizzazione di ospedali di comunità risulta in ritardo rispetto ai target previsti. Entro giugno 2026 dovrebbero essere funzionanti almeno 307 ospedali di comunità, ma al 20 dicembre 2024, solo 124 strutture (40,4%) dichiaravano almeno un servizio attivo e non è riportata alcuna informazione sul personale sanitario.