Parco Gran Paradiso: tra origini e prospettive future

Il Parco Gran Paradiso, che si estende tra il Piemonte e la Valle d’Aosta con una superficie di circa settantamila ettari, è l’area protetta più antica d’Italia: con i suoi 103 anni di attività, svolge una funzione essenziale di protezione e salvaguardia di molteplici specie animali e vegetali.
Abbiamo raggiunto Sonia Calderola, direttrice facente funzioni dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, e a Il Bo Live ha parlato delle caratteristiche del Parco, della sua storia e della sua identità, e ha raccontato il lavoro e l’impegno per rendere l’area protetta uno dei parchi più importanti e all’avanguardia.
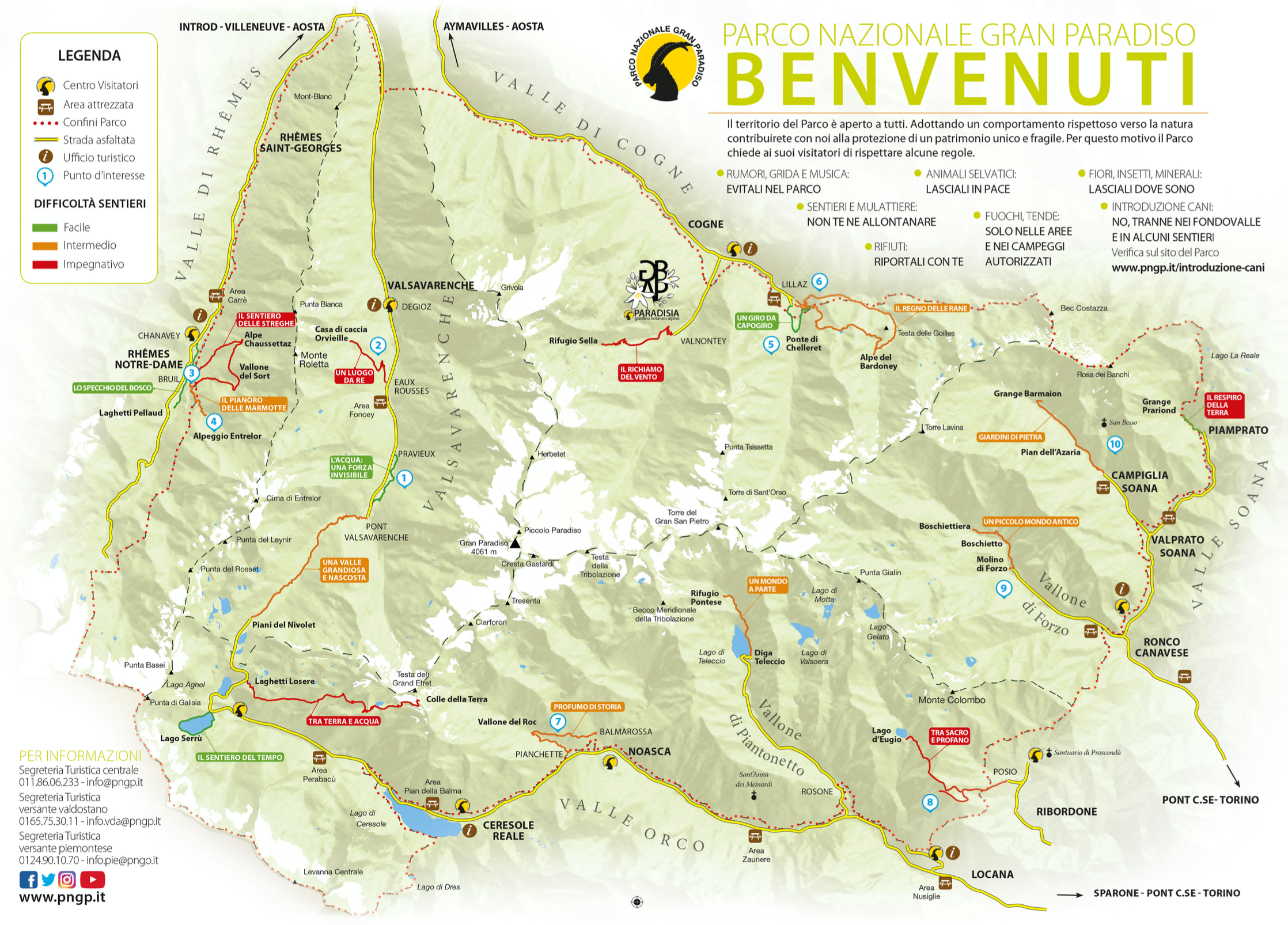
La sua storia – come afferma Calderola – inizia a metà dell’Ottocento: all’epoca il re Vittorio Emanuele II, appassionato di fauna, istituì la riserva di caccia proprio là dove oggi si trova il cuore del Gran Paradiso. L’obiettivo era quello di salvare dall’estinzione lo stambecco, dunque il re adottò un atteggiamento illuminato e innovativo per quei tempi.
"Il legame tra il Parco e lo stambecco è una relazione a doppio senso – dichiara la direttrice –. Questo perché l’esistenza dell’uno dipende dall’altro e viceversa. Si può dire che quest’ultimo rappresenti la specie simbolo dell’area".
A donare la riserva allo Stato italiano fu Vittorio Emanuele III che, all’inizio del Novecento, prese la decisione di creare qui la prima area protetta, sempre con l’intento di salvaguardare lo stambecco.
"Le vicende del Parco – continua Calderola – furono poi travagliate e altalenanti. Quello fascista, per esempio, fu un periodo buio e poco proficuo, perché le guardie reali di caccia furono sostituite con le milizie forestali nazionali, meno esperte del territorio e dunque meno capaci di tutelarlo."
Nel secondo dopoguerra, infine, nacque il Parco come ente, la cui missione era quella di riportare lo stambecco a numeri tranquillizzanti non solo all’interno dell’area, ma in tutto il territorio delle Alpi.
"Oggi – afferma Calderola – i risultati sono assolutamente soddisfacenti: lo stambecco è tornato a popolare l’intero arco alpino con numeri altamente significativi. Tuttavia, adesso stiamo vivendo un’altra fase della storia del Parco, con nuove minacce e sfide particolarmente difficili da affrontare."
Se, infatti, un tempo il problema più impellente era quello del bracconaggio, ora gli ostacoli sono più complessi da fronteggiare: il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, come sottolinea la direttrice, sono sfide che, pur volendo, il Parco non può vincere isolatamente.
"Queste minacce – dichiara Calderola – hanno un carattere globale: non basta l’azione di un singolo ente, e neppure quella di un solo Stato. Tutto ciò che si può fare nell’area è raccogliere dati, fare studi e portare avanti ricerche che possano consentire di sviluppare strategie di resilienza per fronteggiare e rallentare questi fenomeni che ci coinvolgono tutti."
Il Parco Gran Paradiso, infatti, collabora con diversi enti di ricerca scientifica, come altre aree protette, varie università e il CNR. La direttrice afferma che studi e ricerche sono un vero e proprio fiore all’occhiello dell’area: conservando molteplici specie da lungo tempo, è possibile raccogliere una grande quantità di dati sui loro mutamenti nel lungo periodo.
"Lo stambecco, per esempio – dichiara Calderola – viene censito nella stessa zona e con la medesima metodologia dagli anni Cinquanta. Ciò è molto importante, perché questi dati consentono di comprendere come le diverse specie reagiscono al velocissimo processo del cambiamento climatico."
Nuovi orizzonti di ricerca, inoltre, si stanno aprendo grazie all’intelligenza artificiale, che consente di effettuare il riconoscimento individuale degli animali senza dover ricorrere al marcaggio, che consiste nell’applicare particolari segni artificiali su alcuni membri della specie che si vuole studiare per monitorarne crescita e sviluppo.
Un altro ambito di studio che impegna il Parco riguarda i ghiacciai: più che di uno studio, in realtà, si tratta di un’attività di monitoraggio, che mira a controllare la rapida evoluzione del loro scioglimento, data anche la loro importanza e il loro legame con l’ambiente del Parco.
Al di là della ricerca, come detto, conservare e proteggere specie a rischio resta un obiettivo principale dell’area. Ovviamente, pur essendone il simbolo, lo stambecco non è l’unica specie che il Parco custodisce.
"Lo stambecco – afferma Calderola – è una delle categorie di animali che più interessa il grande pubblico, assieme, ad esempio, all’ermellino o al camoscio. Tuttavia, esistono tantissime altre specie – come quelle di chirotteri – meno conosciute, ma che al contempo hanno un’enorme importanza dal punto di vista ecologico, e sono minacciate dal cambiamento climatico, da diversi fattori di disturbo antropico e dalla perdita di habitat."
La direttrice racconta, infine, i progetti futuri che si mira a portare avanti all’interno dell’area: in primis, si cercherà di consolidare la partnership con i due parchi confinanti, quello della Vanoise, in Francia, e quello di Mont Avic, in Valle d’Aosta; le tre aree costituiscono insieme una delle più ampie d’Europa, da conservare e tutelare nella loro interezza.
Per Calderola è altrettanto importante riuscire a gestire l’afflusso di turisti: "Il turismo – afferma – è una risorsa di sostentamento importante, ma va adeguatamente indirizzato. Sempre più persone si concentrano in luoghi simbolo del Parco, lasciandone altri – che hanno da offrire altrettante bellezze – poco affollati e quasi vuoti."
È fondamentale, secondo la direttrice, tenere la barra dritta sulla conservazione e la protezione, cercando di evitare tutte le fonti di pericolo e disturbo per la fauna.
"Occorre – conclude – che le persone vengano educate al rispetto e alla conoscenza del territorio, così che possano apprezzare le bellezze che l’area offre senza mettere a rischio le specie che conserva e protegge."

















