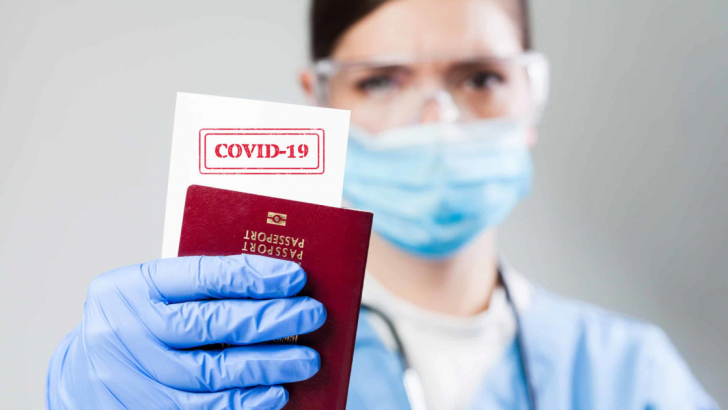Confini invisibili: storia, diritto e politica degli spazi aerei

Due Typhoon della Royal Air Force (RAF) del 1° Squadrone (caccia) intercettano un aereo russo Tu-214. I Typhoon sono schierati in Estonia nell'ambito della missione NATO di polizia aerea del Baltico 4 luglio 2023 Reuters
Gli spazi aerei non hanno confini fisici, eppure sono tra le frontiere più rigide e sensibili del mondo moderno. Definiscono la sovranità di uno Stato, regolano i flussi del traffico civile e, al tempo stesso, rappresentano un terreno strategico in cui si intrecciano sicurezza, politica e diritto internazionale. Dallo sviluppo dell’aviazione civile all’era degli intercettori supersonici, fino agli attuali scenari geopolitici in Europa, lo spazio aereo è divenuto un bene comune e conteso, invisibile ma cruciale.
Le origini giuridiche: la Convenzione di Chicago
Il concetto moderno di spazio aereo nasce formalmente con la Convenzione di Chicago del 1944, trattato fondativo dell’ICAO (International Civil Aviation Organization). L’articolo 1 recita così: “Ogni Stato ha completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sopra il proprio territorio”. Il territorio, precisa l’articolo 2, comprende le aree di terraferma e le acque territoriali.
Questa impostazione chiude il dibattito che aveva animato i giuristi tra Ottocento e Novecento: alcuni sostenevano che il cielo dovesse essere libero come l’alto mare, altri che spettasse al dominio statale. Prevaleva la seconda visione: la sovranità aerea era funzionale alla sicurezza e al controllo delle nuove tecnologie di volo. Da allora, ogni Stato definisce e amministra il proprio spazio aereo nazionale. Sorvolarlo senza autorizzazione significa violare la sovranità, con conseguenze che possono andare dalle sanzioni amministrative all’intercettazione militare.
La definizione tecnica: uno spazio “a tre dimensioni”
A livello operativo, l’ICAO e gli enti nazionali definiscono lo spazio aereo come “un volume di dimensioni definite, nel quale si applicano regole e servizi specifici”. La classificazione internazionale distingue sette classi (da A a G), che regolano chi può volare in VFR o IFR (rispettivamente il cosiddetto “volo a vista” e quello “strumentale”), se è richiesta autorizzazione, quali servizi di separazione forniscono i controllori del traffico aereo.
Accanto alla distinzione orizzontale (CTR, TMA, FIR), vi è quella verticale: in Europa e in Italia lo spazio aereo è diviso convenzionalmente in Lower Airspace (da terra fino al livello di volo 195, pari a 19.500 piedi, circa 5.900 metri) e Upper Airspace (sopra il livello di volo 195). Questa soglia, scelta da Eurocontrol (l’ente che per l’Europa si occupa della sicurezza dei voli civili) per uniformare la gestione continentale, consente di distinguere i voli a corto raggio, tipici del traffico regionale o dell’aviazione generale, da quelli di lungo raggio che operano nelle quote più alte, dove valgono regole più stringenti e si applicano i concetti di Free Route Airspace.
Leggi anche: Gli occhi del cielo: come si controlla il traffico aereo in Italia
Il problema del limite superiore: dove finisce lo spazio aereo
Un nodo irrisolto riguarda la parte più alta del cielo: fino a che quota uno Stato esercita la propria sovranità? La Convenzione di Chicago non lo stabilisce. Alcuni giuristi indicano i 100 chilometri della linea di Kármán, considerata convenzionalmente l’inizio dello spazio extra-atmosferico. Ma non esiste accordo vincolante.
Oltre una certa quota, infatti, entrano in gioco i trattati spaziali delle Nazioni Unite, primo fra tutti l’Outer Space Treaty del 1967, che dichiara lo spazio cosmico res communis omnium, patrimonio comune non soggetto ad appropriazione nazionale. La mancanza di una delimitazione chiara crea un “grigio giuridico” che, con lo sviluppo dei voli suborbitali e commerciali, diventa sempre più attuale. Per quanto riguarda gli aeroplani convenzionali esiste, d’altra parte, un limite prettamente pratico e fisico: al di sopra di una certa altitudine, i velivoli dotati di ala non possono semplicemente più volare per la perdita di portanza dovuta all’estrema rarefazione dell’aria.
Dallo sviluppo civile alla gestione integrata europea
Dopo la Seconda guerra mondiale, il traffico aereo civile è esploso, e con esso l’esigenza di regolare i cieli. Sono nati i centri di controllo d’area, le rotte aeree, i servizi di assistenza al volo. Negli anni Novanta, con l’integrazione europea, si è affermata la visione del Single European Sky, progetto che mira a superare la frammentazione nazionale per garantire efficienza e sicurezza.
Eurocontrol ha introdotto il concetto di Flexible Use of Airspace, che permette di condividere porzioni di spazio tra usi civili e militari, a seconda delle necessità. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza del traffico civile e al tempo stesso mantenere la prontezza delle forze armate. In pratica, l’UE si è dotata di un insieme di regole condivise, abbattendo, virtualmente, i confini del cielo così come non esistono più le dogane terrestri.

La dimensione militare: sconfinamenti e intercettazioni
Se sul piano civile lo spazio aereo è infrastruttura e servizio, sul piano militare è frontiera di sovranità territoriale. Entrare nello spazio aereo di un altro Stato senza autorizzazione è una violazione che può avere conseguenze immediate. In Italia la difesa aerea è assicurata dall’Aeronautica Militare tramite il sistema di Air Policing: radar, centri di controllo e coppie di caccia in prontezza operativa 24 ore su 24 (la cosiddetta quick reaction alert) sulle basi di Grosseto (Toscana), Gioia del Colle (Puglia), Trapani (Sicilia) e Istrana (Friuli Venezia Giulia).
Quando un velivolo non identificato si avvicina senza un piano di volo (le indicazioni di partenza, destinazione e rotta da seguire che devono essere consegnate agli enti di controllo), con transponder spento (un apparecchio trasmittente che permette ai sistemi di controllo di ottenere informazioni da un aeromobile) o senza contatti radio, il Centro di comando ordina lo scramble: i caccia decollano in pochi minuti, intercettano, identificano, affiancano e istruiscono l’aereo sospetto. Le procedure sono codificate dall’ICAO e standardizzate in tutto il mondo. L’intercettato deve rispondere ai segnali visivi e radio, e in caso di necessità può essere scortato, costretto all’atterraggio o accompagnato all’esterno dei confini dello spazio aereo territoriale che ha violato. Attenzione: possono accadere situazioni di sconfinamento anche all’interno di un dato territorio nazionale. Le mappe che i piloti devono consultare in volo identificano una serie di zone “ristrette” o di porzioni di area che non possono essere sorvolate a determinate quote o in un determinato periodo di tempo (spazi militari, aree protette o banalmente zone in cui si effettuano operazioni speciali come il lancio di paracadutisti). Anche queste violazioni possono comportare azioni di verifica ed eventuali sanzioni amministrative.
Il quadro NATO: la difesa collettiva dei cieli
L’Italia non agisce da sola: fa parte del sistema integrato della NATO, Integrated Air & Missile Defence. I cieli dell’Alleanza atlantica sono sorvegliati 24 ore su 24 da due Combined Air Operations Centres (CAOC): Uedem (Germania) per l’Europa settentrionale, Torrejón (Spagna) per quella meridionale.
L’Air Policing è una missione permanente di pace con il compito di intercettare e dissuadere aeromobili che si avvicinano senza rispettare le regole del volo. Questa cooperazione consente di presentare una difesa unitaria dei cieli NATO: un velivolo sconosciuto che si avvicina alla Polonia, alla Romania o all’Estonia o anche ai confini italiani viene identificato e affiancato secondo procedure comuni, a prescindere dalla bandiera del caccia intercettore che decolla. Nella maggioranza dei casi, l’attivazione delle procedure di verifica rivelano dei problemi di sicurezza minori: negli anni non si contano azioni rivolte a piccoli aerei di aviazione generale che avevano la radio o il transponder spenti e che avevano violato spazi aerei interdetti. Ci sono stati casi più eclatanti, come quello di un volo di linea – nel 2022 - in sorvolo sulla Francia, che non ha risposto per alcuni minuti alle chiamate del centro radar di controllo perché entrambi i piloti si erano addormentati ai comandi.
Scramble e sconfinamenti
Negli ultimi dieci anni, gli scramble hanno oscillato tra le tre e le cinque centinaia l’anno. Dopo il 2014, con l’annessione russa della Crimea, il numero è cresciuto sensibilmente, fino a superare i 400 episodi nel 2020 e nel 2023. Nel 2022, subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la NATO ha dichiarato quasi 570 intercettazioni, il livello più alto del decennio.
Qui è necessaria una distinzione: la maggior parte dei casi riguarda velivoli in volo nello spazio aereo internazionale ma vicini ai confini dell’Alleanza, senza transponder attivi o piani di volo. Le violazioni effettive dello spazio aereo NATO sono rare, ma quando avvengono hanno un impatto politico immediato.
Nel settembre 2025, ad esempio, tre Mig-31 russi hanno sconfinato per 12 minuti nello spazio aereo estone, mentre pochi giorni prima droni radiocomandati erano entrati nello spazio polacco. Episodi che hanno spinto i governi a invocare consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Ancora più di recente, i casi che hanno costretto alla chiusura gli aeroporti principali della Norvegia (nella capitale, Oslo) e della Danimarca (sempre nella capitale, Oslo): dei droni non meglio identificati hanno minacciato la sicurezza aerea dei due scali aeroportuali, avvicinandosi alla no fly zoneche delimita le aree di pertinenza delle piste di decollo e di atterraggio. La conseguenza (oltre a quella politica con una ridda di accuse e smentite per la possibile ma non ancora dimostrata azione russa) è stata la sospensione delle operazioni di volo con la chiusura degli scali e un accumulo di ritardi nei cieli dell’Europa del Nord.
La frontiera invisibile del futuro
Gli spazi aerei restano una frontiera invisibile ma decisiva. Sono luogo di transito per centinaia di migliaia di voli civili ogni anno, ma anche teatro di tensioni geopolitiche che si giocano a pochi metri dalle linee di confine, seppure a migliaia di metri di altezza dalla superficie.
Il futuro pone nuove sfide: i voli suborbitali turistici, i droni a lungo raggio, la militarizzazione dello spazio vicino alla Terra. Tutti fenomeni che ripropongono la domanda: fino a dove si estende la sovranità nazionale e come aggiornare i regolamenti esistenti?
Se il mare ha avuto i suoi trattati e i suoi confini (anche se anche le dispute territoriali marittime sono all'ordine del giorno e creano altrettante tensioni politiche) il cielo rimane un territorio complesso, sospeso tra diritto e tecnologia, tra traffico civile e sicurezza militare. Governarlo significa trovare un equilibrio tra libertà e controllo, tra cooperazione internazionale e difesa degli interessi nazionali.