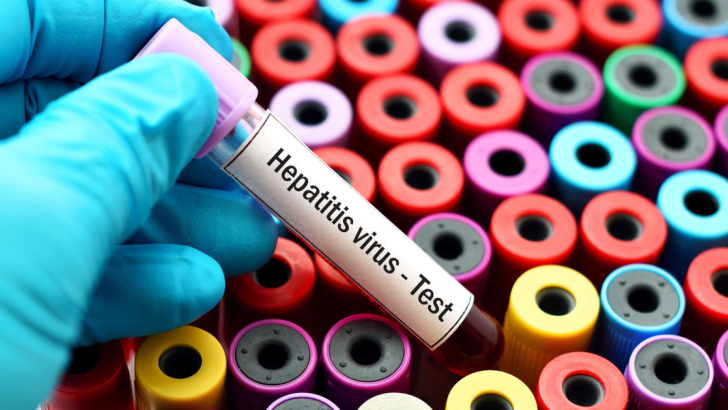La grande diga etiope della discordia diventa realtà

Il suo acronimo è GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam, la “Grande Diga del Rinascimento Etiope”) e non c’è dubbio che la sua costruzione rappresenti una straordinaria opportunità di sviluppo per l’Etiopia e per l’intero bacino del Nilo, da un punto di vista energetico, economico e sociale. Ma c’è anche chi avanza dubbi e perplessità sulla sua gestione, ritenendo che possa diventare una formidabile “arma” nelle mani di una sola nazione, in grado di condizionare gli equilibri geopolitici, già fragili, con le nazioni limitrofe a valle (soprattutto Egitto e Sudan). Si tratta comunque di un’opera monumentale (costata circa 5 miliardi di dollari) sia per dimensioni sia per l’importanza strategica che ricopre: 170 metri di altezza, 1,8 chilometri di lunghezza, un bacino idrico da 74 miliardi di metri cubi in grado di produrre energia elettrica tale da soddisfare non soltanto il fabbisogno di 60 milioni di persone, pari a circa 12 milioni di famiglie, ma di consentire anche l’esportazione, ai paesi limitrofi, dell’elettricità in eccesso.
La diga, che ha una potenza di 5.000 megawatt e con una produzione annua stimata di 15.700 gigawattora (l’equivalente di tre centrali nucleari di medie dimensioni), è stata costruita lungo il Nilo Azzurro, uno dei principali affluenti del corso d’acqua principale, in territorio etiope. Numeri forniti da Webuild, l’azienda italiana, nata dalla fusione tra Salini e Impregilo, che ha materialmente edificato l’opera, in 14 anni. La sua inaugurazione è stata salutata con toni trionfali dal primo ministro etiope Abiy Ahmed: «Questo progetto segna la fine dell’irrilevanza geopolitica dell’Etiopia. Comincia oggi una nuova era di prosperità. È un’opportunità condivisa per l’intera regione». La diga è stata costruita (anche) grazie ai sacrifici collettivi di etiopi di ogni estrazione sociale: agricoltori, commercianti, studenti, funzionari pubblici, istituzioni civiche e religiose, la stessa diaspora, hanno acquistato obbligazioni, in una straordinaria mobilitazione dal basso. Tutti uniti nello sforzo di dare forma a un sogno, che di certo porterà sollievo all’economia etiope, che sta riprendendo slancio dopo essere riuscita a superare un default dichiarato alla fine del 2023.
Le proteste e i timori di Egitto e Sudan
Fin qui tutto rose e fiori. Ma a spezzare il clima festoso è stato l’Egitto, che proprio mentre il governo etiope, attorniato da decine di leader stranieri (il presidente del Kenya, William Ruto, ha svelato trattative in corso per l’acquisto di energia dall’Etiopia), annunciava l’inaugurazione dell’impianto, ha definito l’apertura della diga come «un atto unilaterale illegale, un progetto che viola il diritto internazionale», protestando formalmente con una lettera inviata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. «Dall’avvio unilaterale del progetto della diga etiope e negli ultimi anni, il Cairo ha esercitato la massima moderazione e ha scelto di ricorrere alla diplomazia e alle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite», si legge nella dichiarazione firmata dal ministero degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty. «Al contrario, Addis Abeba ha adottato posizioni intransigenti, cercando di ritardare i negoziati e imporre un fatto compiuto». Preoccupazioni condivise dal Sudan, altra nazione attraversata dal più imponente corso d’acqua africano, il secondo al mondo per lunghezza, superato di appena un centinaio di metri dal Rio delle Amazzoni. Il timore, comprensibile, e condivisa anche dalla Lega Araba, è che una diga presente sull’affluente principale del Nilo possa ridurre la portata d’acqua disponibile e minacciare così la loro sicurezza idrica. Che è di fondamentale importanza per la vita di quelle popolazioni: basti pensare che in Egitto il 90% della popolazione (11 milioni di persone) vive in prossimità delle sponde del Nilo. Fin dall’avvio dei lavori di costruzione della GERD, Egitto e Sudan avevano chiesto all’Etiopia di stilare un accordo per condividere la gestione della diga, e non lasciare alla sola Etiopia la possibilità di “aprire o chiudere” i rubinetti. Ma i negoziati non hanno portato mai alla stesura di un accordo scritto, con l’Etiopia che, almeno finora, si è sempre rifiutata di firmare accordi per la condivisione di quadri tecnici e giuridici. L’enorme serbatoio della diga, progettato per contenere 74 miliardi di metri cubi di acqua, è stato così riempito, per decisione delle autorità etiopi, in cinque fasi successive, a partire dal 2020: fino all’inaugurazione della scorsa settimana. Da qui la protesta di Egitto e Sudan, che all’inizio di settembre avevano già diffuso una dichiarazione comune nella quale si legge: «Quella diga rappresenta una continua minaccia alla stabilità del bacino orientale del Nilo, secondo il diritto internazionale». Rimarcando così i pericoli derivanti dalle mosse unilaterali dell’Etiopia, come rilasci incontrollati di acqua o gestione non mirata alle esigenze delle varie nazioni durante i periodi di siccità.
Abbas Sharaky, docente di geologia e risorse idriche all’Università del Cairo, ritiene che i progressivi riempimenti del bacino idrico della diga hanno già danneggiato la “quota d’acqua” egiziana: «Il danno è già evidente - scrive il geologo -: circa 90 miliardi di metri cubi di acqua sono stati trattenuti in cinque anni, inclusi 60 miliardi di metri cubi immagazzinati nel lago, oltre alla perdita di circa 20-30 miliardi di metri cubi a causa dell'evaporazione e delle infiltrazioni nel terreno». Stando ai dati forniti dal ministero degli Esteri egiziano, il fabbisogno idrico annuale dell’Egitto supera i 90 miliardi di metri cubi, mentre la sua quota attuale si attesta ad appena 55,5 miliardi. L’attuale disponibilità di acqua pro capite è inferiore a 500 metri cubi all’anno, circa la metà della soglia di povertà idrica (1000 metri cubi/anno) indicata delle Nazioni Unite. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha più avvertito più volte negli ultimi anni che la quota annua limitata di acqua del suo paese di 55,5 miliardi di metri cubi dal Nilo è una “linea rossa”: «Non consentiremo a nessuno di prendere una sola goccia d'acqua dall'Egitto».
Le parole non bastano
In realtà, nonostante il fallimento registrato fin qui nei negoziati, ci sarebbe ancora spazio per trovare un accordo legale vincolante che stabilisca le regole per il riempimento e il funzionamento della GERD. Il problema è che l’Etiopia considera la diga come “cosa propria”. Mentre Egitto e Sudan considerano l’acqua del Nilo come “bene comune”. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed oggi usa toni concilianti: «Ai nostri fratelli (sudanesi ed egiziani) dico che l’Etiopia ha costruito la diga per prosperare, per elettrificare l’intera regione, e assolutamente non per nuocere ai suoi fratelli. Vi assicuro che l’Etiopia non vi porterà mai via la vostra giusta parte. Oggi faccio questa promessa davanti al mio popolo. La fame dei nostri fratelli in Egitto, in Sudan o in qualsiasi altro luogo è anche la nostra fame. Dobbiamo condividere e crescere insieme, perché non abbiamo intenzione di fare del male a nessuno». Ma è evidente che le parole non bastano. Com’è chiaro che la disputa sulle acque del Nilo sia intrecciata con dinamiche geopolitiche assai più ampie, sempre sull’orlo di un conflitto armato. Con l’Etiopia, che con i suoi 135 milioni di abitanti è attualmente il paese più popoloso del mondo senza sbocco sul mare, che continua a cercare un accesso diretto al Mar Rosso, soprattutto attraverso il Somaliland (i porti di Assab e Massaua li ha persi nel 1993, quando l’Eritrea diventò indipendente dopo una guerra durata trent’anni). Una tensione, quella con l’Eritrea, che continua ancora oggi per il controllo della regione del Tigray: l’accordo di pace raggiunto nel 2018, che peraltro fruttò al primo ministro etiope il Nobel per la pace, sembra lontanissimo. Mentre un nuovo conflitto, invece, è considerato possibile dagli analisti del Robert Lansing Institute.
Non c’è dubbio che l’inaugurazione della grande diga abbia riacceso l’entusiasmo degli etiopi (il primo ministro l’ha paragonata, per importanza, alla vittoria dell'Etiopia sull’esercito italiano nella battaglia di Adua, nel 1896). L’indipendenza energetica sarà sicuramente un jolly per l’economia locale, che sta attraversando un momento di profonda transizione, con ottime prospettive: si prevede una crescita del Pil dell’8,9% nel biennio 2025-2026, e un’inflazione che dal 30% è scesa a circa il 13%, con la previsione che possa attestarsi al 10%. Un’economia che sta attirando l’attenzione delle grandi potenze, a partire dalla Cina, che ha già contribuito in passato a co-finanziare il progetto della GERD, ma che ha recentemente firmato accordi di investimento con l’Etiopia per 1,7 miliardi di dollari. Mentre Donald Trump ha più volte affermato che anche gli Stati Uniti hanno finanziato la Grand Ethiopian Renaissance Dam, pur criticandone le modalità e di fatto schierandosi dalla parte dell’Egitto: «La massiccia diga costruita dall’Etiopia è stata stupidamente finanziata dagli Stati Uniti d'America e riduce sostanzialmente l’acqua che scorre nel fiume Nilo», aveva recentemente scritto il presidente americano in un post sulla sua piattaforma Truth. Ma sono soltanto le prime schermaglie: la partita diplomatica attorno alla Grande Diga etiope è appena cominciata.