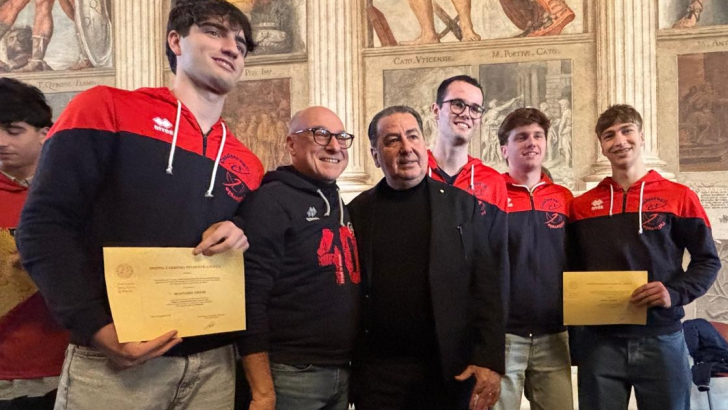Sinner e non solo: perché il tennis ci piace tanto

Jannik Sinner e Ben Shelton REUTERS/Hannah Mckay
Negli ultimi tempi il tennis è tornato a occupare le menti e le pagine di giornali italiani grazie alle gesta di campioni come Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli… Poi c’è lui, Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon: nuovo idolo delle folle e da oltre un anno dominatore del ranking mondiale. Il tennis va però con la sua storia ben oltre le classifiche e le mode passeggere: è un racconto complesso nel quale si intrecciano attraverso i secoli arte, scienza e filosofia.
Impossibile tentare qui un repertorio della presenza nel nostro immaginario di quello che ancora oggi è lo sport individuale per antonomasia. Basti pensare che il tennis esplode come fenomeno nelle corti europee fin dal Medioevo e dal Rinascimento, sotto il nome di pallacorda o jeu de paume, e che è uno dei giochi più ritratti nella storia dell’arte, come ad esempio ha sottolineato il grande Gianni Clerici – memorabili le telecronache assieme a Rino Tommasi – nel libro Il tennis nell’arte (Mondadori 2018). Dai Tiepolo a Chardin, da Goya a Boccioni per arrivare a Carrà, Hopper e Calder, palle e racchette compaiono nei dipinti come elementi familiari e, in qualche modo, necessari. Lo stesso Caravaggio fu un accanito giocatore: una lite sorta durante una partita gli costò la fuga da Roma e, forse, la vita.
Anche la letteratura ha attinto dal tennis come potente metafora. Nell’Enrico V di Shakespeare è proprio l’invio di palle da gioco al giovane monarca inglese da parte del suo rivale, il delfino di Francia, a innescare la spirale di tensione che porterà alla guerra, in un momento catturato magistralmente da Kenneth Branagh nella sua versione cinematografica del 1989. Perfettamente a tono è la risposta di Enrico: “Quando avremo incrociato le nostre racchette con queste palle speriamo, con l’aiuto di Dio, di giocare in Francia un tale set da far ruzzolare la corona del re suo padre in mezzo al campo” (Atto I, scena II).
All’epoca del Bardo il tennis è già uno dei simboli di una società raffinata e in trasformazione, che si apre al piacere codificato e regolato lasciandosi alle spalle le ben più pericolose giostre cavalleresche. I tennisti diventano i nuovi cavalieri: duellanti solitari in un’arena rettangolare animati da grazia, disciplina e resistenza mentale. Così, fin dagli albori del mondo moderno, il gioco non è più solo distrazione e divertimento, ma anche palestra di virtù e codice di comunicazione nella continua competizione per il potere. Il tennis però non è solo metafora, ma anche storia concreta. Si narra che Luigi X di Francia morisse tra gli spasmi, il 5 giugno 1316 a Vincennes, dopo aver trangugiato vino gelato in seguito a un’accesa partita di jeu de paume. E oltre quattro secoli e mezzo più tardi, il 20 giugno 1789 a Versailles, sarà in una sala adibita al medesimo gioco che i rappresentati del Terzo Stato si riuniranno per giurare insieme di dare una costituzione alla Francia, dando ufficialmente inizio alla Révolution.
Non è tutto: il tennis è anche sport profondamente tecnico e scientifico. Già Galileo nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632, lo utilizza – come raccontano il tennista, giornalista e divulgatore Luca Bottazzi e Alessandro Tosi, storico dell’arte dell’università di Pisa – per spiegare il moto dei corpi celesti. Così il genio pisano descrive un colpo “trinciato”, in cui la rotazione impressa alla palla ne cambia traiettoria e rimbalzo, in una sorprendente anticipazione della moderna teoria dello spin: “…i giocatori di palla a corda più esperti ingannano l’avversario col trinciar la palla, cioè rimetterla con la racchetta obliqua, in modo che ella acquisti una vertigine contraria al moto proietto”.
Quando poi, nel 1874, il maggiore britannico Walter Clopton Wingfield codifica le regole del lawn tennis, la storia di questo sport mette l’acceleratore; pochi anni dopo, nel 1877, nasce il torneo di Wimbledon. Il tennis entra nelle Olimpiadi fin dalla prima edizione del 1896, ma è protagonista anche di una delle sue crisi più significative: nel 1928 viene escluso dai Giochi a causa della controversia su dilettantismo e professionismo, evidenziata dal caso che coinvolge di Suzanne Lenglen, imbattibile tennista francese che ha iniziato a ricevere compensi per le sue esibizioni. Un’esclusione che dura fino a Seul 1988, vent’anni dopo l’inizio dell’era Open.
Con l’apertura ai professionisti il gioco si trasforma: sport d’élite e insieme popolare, estetico e competitivo, precursore di un mondo che si sta riscrivendo attraverso la TV, la moda, le sponsorizzazioni. Negli anni Settanta il tennis anticipa tutti gli altri sport, primo a fare dei suoi campioni testimonial di stile a livello mondiale. Intanto anche scienza e tecnologia accelerano: dalle racchette in legno a in alluminio (brevettate da René Lacoste) si passa a quelle in grafite e materiali compositi. Cambiano anche le palline, le superfici, i tessuti tecnici, facendo del tennis laboratorio di biomeccanica, fisica applicata e intelligenza artificiale.
Oggi il tennis permea la vita quotidiana: è presente nello stile, nel linguaggio, nei materiali che utilizziamo e persino nei videogiochi. Pong, il primo videogioco di successo, è un’astrazione del tennis (più precisamente nella variante del tennis tavolo o ping pong) ridotta alla sua essenza: una pallina che rimbalza tra due superfici mobili. I grandi campioni sono icone globali, e opere come l’autobiografia Open, in cui Andre Agassi (con l’aiuto del giornalista J. R. Moehringer) confessa fin dall’inizio di odiare lo sport che lo ha reso famoso, rimangono inquietanti monumenti alla società in cui viviamo e ai suoi valori.
Intanto servizi, passanti e discese a rete rimangono, in un’epoca straordinariamente poco epica, estremamente letterari. Sarà perché, nonostante la spettacolarizzazione e la commercializzazione, resta uno sport unico per la sua dimensione individuale e spirituale, in cui si è soli contro l’avversario, il pubblico e soprattutto sé stessi. “Il vero avversario, la frontiera che include, è il giocatore stesso. C’è sempre solo l’io là fuori, sul campo, da incontrare, combattere, costringere a venire a patti. Il ragazzo dall’altro lato della rete: lui non è il nemico, è più il partner della danza. Lui è il pretesto o l’occasione per incontrare l’io. E tu se la sua occasione”.
A scrivere è la mano di David Foster Wallace in Infinite Jest (Einaudi 2006, p. 99), una delle sue opere più complesse e magmatiche. Lo stesso autore, talentuoso a livello juniores e in seguito vero appassionato, tratta il tennis in una serie di articoli e saggi che, tra le altre cose, centrano grazie al proverbiale acume anche il ruolo del pubblico nel riconoscere, definire e raccontare il genio dei giocatori. Roger Federer as Religious Experience è ad esempio il titolo di un suo scritto pubblicato sempre nel 2006 sul New York Times, in una laica epifania dove il ruolo dell’apostolo ed evangelista non è meno importante di quello dei messia, veri e presunti.
La stessa complessità attraversa Levels of the Game, libro cult di John McPhee che in quasi 150 pagine racconta – punto per punto, colpo su colpo – la semifinale degli US Open 1968 tra Arthur Ashe e Clark Graebner. Un match che grazie all’ampliamento spazio-temporale favorito dal tennis – più bergsoniano che einsteiniano – diventa racconto esistenziale, saggio psicologico e ritratto dell’America tra tensioni razziali, tattiche e strategie. “Nel tennis, i meccanismi motori traducono la storia personale e il carattere in colpi e stili – scrive McPhee –. Un metodico tenderà a giocare in modo metodico, mentre chi ha estro nella vita lo tirerà fuori anche in campo. Una partita lottata, tesa, è prima di ogni altra cosa uno scontro di psicologia”.
Forse è per questo che il tennis, giocato o osservato, è anche una forma di conoscenza. Che lo seguiamo o meno, in fondo ci riguarda e ci guarda tutti. Ci racconta e continuerà a farlo, ogni volta che qualcuno, da solo o in coppia, proverà a restituire una palla all’altro lato della rete.