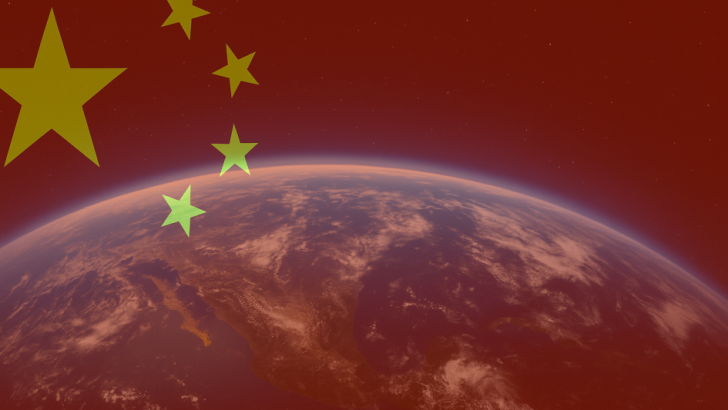Africa, i nuovi interessi del neocolonialismo

Il recente golpe militare in Mali ha riacceso i riflettori internazionali sull’influenza di alcune nazioni nelle complesse dinamiche politiche, economiche, militari e sociali del continente africano, dove l’instabilità resta spesso di casa, come il saccheggio delle risorse, la corruzione, la povertà endemica, nonostante i decenni più recenti di “aiuti” dall’Occidente, dopo secoli di colonialismo. Cambiano i modi, non la sostanza: il neocolonialismo usa non più catene, ma denaro offerto in prestito. E dopo i soldi ci sono le competenze ingegneristiche, gli accordi commerciali e culturali, la fornitura di armi. Sempre garantendo la massima “libertà” alle popolazioni locali. Dal dominio si è passati alla dipendenza. Salvo situazioni limite dove magari, con le dovute cautele, senza troppo apparire, è necessario intervenire.
L’avanzata di Putin
Prendiamo il caso della Russia. Per Putin l’Africa non è la priorità assoluta, ma uno scenario di primo piano che certo non vuol lasciare scoperto, magari sperando di riacquisire il ruolo di primaria influenza che aveva l’Unione Sovietica all’epoca della Guerra Fredda, poi dissolta con la fine dell’URSS. Nell’ottobre 2019 si è svolto a Sochi il primo summit Russia-Africa (il prossimo dovrebbe tenersi nel 2022), alla presenza di 43 capi di stato africani, nel quale sono stati firmati oltre 500 accordi bilaterali, per un valore complessivo che il Cremlino ha stimato in oltre 12 miliardi di dollari. Durante i due giorni di vertice il presidente russo si è smarcato, a parole s’intende, da qualsiasi sospetto di neocolonialismo: «La Russia non ha alcun desiderio di interferire con gli affari interni dei paesi africani», ha dichiarato. Gli obiettivi di Putin sono molteplici: rimarcare il ruolo di grande potenza della Russia, creare alleanze che consentano alla Russia stessa di essere protagonista attiva nelle dinamiche geopolitiche dell’area ed entrare nella spartizione delle risorse naturali e delle materie prime (cobalto, oro, diamanti, coltan). Ma, soprattutto, mantenere e irrobustire la leadership militare nell’area, con la fornitura di armi e di competenze militari. Con una quota di mercato del 37,6%, la Russia è già oggi il primo esportatore di armi in Africa, seguita dagli Stati Uniti con il 16%, la Francia con il 14% e la Cina con il 9%. Il principale destinatario di armi russe in Africa è l’Algeria, seguita da Egitto, Sudan e Angola. Proprio al vertice di Sochi, la Nigeria ha firmato due accordi: uno per l'acquisto di 12 elicotteri militari russi, l’altro per una joint venture tra la Nigerian National Petroleum Corporation e la compagnia petrolifera russa Lukoil.
Come scrive il settimanale The Arab Weekly: «La Russia si sta muovendo per espandere la sua sfera di influenza in Africa attraverso nuove basi militari e un numero crescente di truppe, in una mossa che, dicono gli esperti militari, è volta a costruire una forza militare sotto forma di un AfriCom di tipo russo in grado di competere con il ruolo del comando militare statunitense in Africa (US AfriCom)». In un rapporto segreto del ministero degli Esteri tedesco, reso pubblico pochi giorni fa dal quotidiano Bild, è riportato che la Russia ha ottenuto i permessi per stabilire basi militari in sei paesi africani: Repubblica Centrafricana, Egitto, Eritrea, Madagascar, Mozambico e Sudan. «Queste basi – sottolinea il bimestrale Africarivista - sono l’evoluzione di una strategia che, negli ultimi anni, ha portato Mosca a siglare intese di cooperazione militare con 21 paesi in Africa. Alcune di queste intese prevedono la costruzione di basi militari, tutte l’addestramento (in parte segreto e in parte ufficiale) dei soldati di quei paesi. Secondo il rapporto tedesco, 180 istruttori dell’esercito russo si trovano attualmente nella Repubblica Centrafricana e circa 20 militari maliani vengono addestrati in Russia ogni anno».
La variabile Wagner
A questo si somma l’attività del Gruppo Wagner, l’ormai celebre ma impenetrabile “polizia privata”, costituita in gran parte da ex militari dell’esercito russo: mercenari che dietro compenso (oppure in cambio di risorse minerarie e di concessioni di vario genere) intervengono ovunque alle dirette dipendenze di Mosca (in Libia, ad esempio, ma anche in Siria e in Ucraina), nonostante in Russia sia in vigore una legge che vieta all’esercito di appoggiarsi a squadre di mercenari. E senza che la responsabilità dei loro atti, a volte oltre il limite del lecito, possa essere imputata al Governo centrale. In Africa sarebbero centinaia i mercenari della Wagner in attività, soprattutto in Repubblica Centrafricana, Sudan, Madagascar e Mozambico, impiegati per addestrare milizie locali e per proteggere le miniere di diamanti e di metalli preziosi. «Il Wagner Group – scrive Massimo Alberizzi su Africa ExPress - può essere considerato l’avamposto della politica estera del Cremlino».
Il golpe in Mali e i legami con Mosca
E qui si torna al punto di contatto con la cronaca di questi giorni, con il colpo di Stato in Mali. Un contingente di contractors russi era arrivato a Bamako, capitale del Mali, all’inizio di quest’anno, come peraltro aveva annunciato il ministro della Difesa locale, parlando però di «soldati russi incaricati di gestire la manutenzione di due elicotteri Mi-35 consegnati da Mosca nell’ottobre 2017 e prendere parte all’addestramento dei piloti». Proprio in quei giorni, dicembre 2019, a Bamako si manifestava esponendo gigantografie di Putin.
La situazione nella Repubblica del Mali è poi rapidamente precipitata: all’origine della crisi le elezioni legislative che il presidente Ibrahim Boubacar Keita aveva indetto per il 29 marzo nonostante l’emergenza coronavirus (a oggi in Mali 2600 contagiati con 125 vittime), elezioni segnate dal rapimento alla vigilia delle consultazioni del leader dell’opposizione Soumaila Cissé, ancora oggi in mano a gruppi jihadisti, e dalla sentenza della Corte Costituzionale che dopo la denuncia di brogli e attentati ai seggi ha annullato il voto in una trentina di circoscrizioni, e sono in molti a ritenere che la manovra sia stata realizzata per garantire a Keita una maggioranza parlamentare. Una tensione crescente, con la nascita del Movimento per la disobbedienza civile che ha portato a rivolte e attacchi contro il Parlamento e la televisione nazionale, con una scia di morti e feriti. Fino al colpo di Stato militare del 18 agosto scorso, con l’arresto e le dimissioni («Sono stato sottomesso, non ho altra scelta») del presidente Keita e del primo ministro, Boubou Cissé, da parte di militari maliani. Un golpe realizzato senza sparare un solo colpo. I militari hanno formato un “Comitato Nazionale per la Salvezza del Popolo” e indetto nuove elezioni. Ma la fragilità del paese, ex colonia francese, indipendente dal 1960, resta intatta, tra assolute povertà e rischio d’infiltrazioni di organizzazioni terroristiche, apertamente contrastate dalla comunità internazionale (unanime la condanna del golpe che ha di fatto innescato un isolamento del Mali) e soprattutto dalla Francia, che nell’area ha ancora interessi enormi e che attualmente schiera oltre 5mila soldati nell’operazione Barkhane (ora in bilico) contro i terroristi jihadisti. Il presidente Macron ha chiesto l’immediata scarcerazione del presidente Keita e che «il potere sia restituito ai civili».
Resta una domanda: chi ha interesse a mantenere instabile la situazione politica e la sicurezza in Mali? Il sospetto è che possa esserci una regia occulta. Secondo indiscrezioni non verificabili, due tra i principali leader dei rivoltosi, il colonnello Malick Diaw e il generale Sadio Camara, sarebbero stati recentemente in Russia per una “una sessione di addestramento”. Scrive al riguardo Formiche.net: «La Russia da mesi conduce operazioni di info-war in Mali per screditare la presenza francese, azioni di disturbo non nuove. Inoltre da tempo Mosca ha interesse al Mali, come testimoniato dall’accordo militare di gennaio. Dal 2018 Bamako ha formalmente chiesto aiuto ai russi per combattere le organizzazioni terroristiche». Dunque potrebbe trattarsi, ma è soltanto un’ipotesi, di un tentativo di Mosca di subentrare alla Francia come partner privilegiato.
Colpo di stato in #Mali, arresti arbitrari e uccisioni. L’allarme di #AmnestyInternational. Di @RiccardoNoury @AntonellaNapoli @JLTouadi @alswolf @claudialode https://t.co/Y0n8MizBad
— Focus on Africa (@FocusonafricaIt) August 19, 2020
Non solo Russia: le mire della Cina
Naturalmente non è soltanto la Russia ad avere mire espansionistiche nel continente africano, scenario che sempre più diventa “attrattivo”. Ci sono gli Stati Uniti, l’India, la Turchia, i paesi del Golfo. Dagli Stati Uniti alla Russia, dall’India alla Turchia, dal Giappone ai paesi del Golfo. Ma c’è soprattutto, e sopra a tutti, la Cina, che oggi è la vera forza dominante postcoloniale in Africa: primo fornitore di beni e servizi, primo finanziatore (non direttamente, ma sotto forma di prestiti, e vedremo tra poco perché). Gli investimenti corrono a ritmi impressionanti: dai quasi 8 miliardi di dollari del 2008 si è passati ai 46 miliardi del 2018 (ultimo dato ufficiale disponibile). Il commercio bilaterale Africa-Cina si attesta attorno ai 185 miliardi di dollari (per avere un termine di paragone: quello con la Russia arriva a 20 miliardi di dollari, praticamente un decimo). Il più grande acquirente di prodotti cinesi è il Sud Africa, seguito da Nigeria ed Egitto. Il più grande esportatore è l’Angola. Dunque grandi investimenti nel settore dell’energia, dell’estrazione di materie prime, nell’agricoltura e nel commercio, che portano con sé imponenti costruzioni di strade, ferrovie, porti, aeroporti, centrali elettriche, dighe (come quella, gigantesca, in Etiopia, la Gerd, che tanti problemi diplomatici e commerciali sta creando con Egitto e Sudan).
L’intervento cinese in Africa è pianificato, strategico. Ogni tre anni, dal 2000, organizza il “Forum on China-Africa Cooperation”, nel quale il presidente cinese Xi Jinping, con il suo entourage, stabilisce assieme alle controparti africane, in modo collegiale, l’approfondimento delle relazioni economiche, commerciali e culturali che legano le due aree. Una Cina che di certo ha approfittato del passo indietro di quelle che furono un tempo le Grandi Potenze in quest’area, Francia e Gran Bretagna su tutte, che oramai si limitano (senza coinvolgere l’Unione Europea) a gestire rapporti diretti con le loro ex colonie, rimasti comunque presidi strategici da tutelare e fonti privilegiate di guadagno. Altri paesi europei, come l’Italia, cercano di infilarsi negli spiragli ancora aperti e inserire le proprie imprese nei vari progetti di sviluppo: ma si tratta di iniziative-spot, prive di un piano strategico complessivo. La Cina sceglie l’Africa per aprirsi nuovi mercati, con l’obiettivo di realizzare una parte della Belt and Road Initiative (la “nuova via della Seta”, un poderoso progetto di collegamento tra Estremo Oriente e Europa da un lato e Africa Orientale dall’altro), ma anche per aumentare il suo “peso” politico all’interno delle organizzazioni internazionali (a partire dall’Onu), dove spesso può contare sul voto dei paesi africani. L’Africa sceglie la Cina perché in cambio dei prestiti (che portano infrastrutture indispensabili) Pechino non chiede altro: nessuna intenzione d’interferire con le questioni politiche o sociali o religiose. Non vuole drastiche riforme. Solo affari, senza condizioni. Una forma di “rispetto” per le autonomie locali che è molto apprezzato, soprattutto dai regimi più autoritari. Il che espone Pechino a continue critiche di “pratiche neocoloniali”, attuate peraltro con “la trappola del debito” (il prestito complessivo del governo e delle banche cinesi ai paesi africani tra il 2000 e il 2018 ammonta a oltre 150 miliardi di dollari).
Il Covid e la “trappola del debito”
Ora però l’emergenza coronavirus sta creando non pochi problemi alle economie di questi stati, contraendo gli spazi di manovra, tra necessità delle popolazioni e debiti da pagare. Dalla Cina nessun segnale di allentamento della morsa, anzi. Sostiene Ferruccio Michelin, su Formiche.net: «La Cina non sembra pensare a provvedimenti a sostegno di quei paesi con cui ha legami», come ad esempio la riduzione o la cancellazione del debito reale. «La realtà, secondo diversi analisti, è che Pechino potrebbe offrire invece una rinegoziazione del debito, stringendo così ancora più forte il lucchetto della trappola. Quei paesi infatti risulteranno ancora più indebitati, e perderanno parte della propria sovranità a favore della Cina. Un esempio: il China Merchants Group, di proprietà statale, ha riacquistato metà di un porto nello Sri Lanka nel 2017, dopo che il governo era rimasto indietro nel rimborsare 1,5 miliardi in prestiti da Pechino. Oppure c’è il caso dell’Etiopia, dove l’utility cinese State Grid ha acquistato una quota da 1,8 miliardi nella società elettrica nazionale in cambio della cancellazione di una tranche del debito pubblico aperto con la Cina». Accuse infondate? Una narrazione troppo “occidentale” come sostiene Lee Jones, in un articolo appena pubblicato su The Spectator? «Ci sono certamente buone ragioni per diffidare del regime cinese. Ma c'è anche un chiaro rischio che la crescente sinofobia distorca la realtà del comportamento cinese, che spesso è molto meno strategico di quanto si supponga». Oppure è il caso di osservare entrambi gli aspetti della questione: «Sebbene vi sia la tendenza a dipingere i finanziamenti cinesi come predatori, anche le élite politiche africane sono complici», sostiene invece la dottoressa Lucy Corkin, ricercatrice associata alla Soas di Londra (School of Oriental and African Studies) ed esperta di rapporti Cina-Africa. «Incolpare la Cina fornisce un capro espiatorio conveniente, ma non assolve i governi dall'intermediazione di affari scadenti che non avvantaggiano la loro gente».