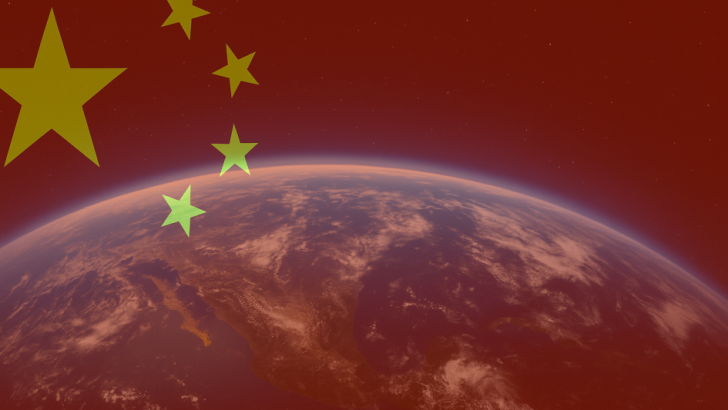I dazi imposti da Trump stanno mandando l’Africa tra le braccia della Cina

Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington, D.C., Stati Uniti, 7 agosto 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Laddove Trump si diletta a scatenare tempeste commerciali, brandendo a destra e a manca l’arma dei dazi, a volte la Cina interviene per approfittare della situazione di caos e riportare una quiete che, soprattutto a Pechino, potrebbe fare un gran bene. L’esempio più eclatante è l’Africa, continente dal potenziale immenso e ancora lontano dall’essere sfruttato appieno, che negli ultimi mesi s’è vista alzare il conto dall’inquilino della Casa Bianca a cifre che difficilmente potrà permettersi. Impossibile anche soltanto immaginare trattative o contro-dazi: troppo alto il divario di potere. E allora la Cina cosa decide di fare? Annuncia un patto commerciale globale portando a zero i suoi dazi sulle importazioni da 53 paesi africani su 55 (tutti quelli nei quali ha una rappresentanza diplomatica: uniche eccezioni sono Eswatini e Repubblica Democratica Araba Saharawi). Una decisione che Pechino aveva in parte già annunciato lo scorso dicembre, un mese prima dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca, segno che sapevano già che qualcosa, in materia di commercio, si sarebbe mosso in tal senso. Lungimiranza, appunto. «I paesi africani non possono far altro che rafforzare il commercio sud-sud, tra le nazioni in via di sviluppo», ha commentato alla Cnn il ricercatore sudafricano Neo Letswalo. «Gli Stati Uniti stanno gradualmente perdendo il loro status di leader globale: e più i paesi diventano meno dipendenti dagli Usa, maggiori sono le opportunità per la Cina di diventare un’alternativa».
Certo, le manovre spericolate e spesso umorali di Donald Trump (ha da poco portato i dazi al 50% per India e Brasile, colpevoli l’una di acquistare petrolio russo, l’altra di perseguire giudiziariamente l’ex presidente Bolsonaro) sono una variabile difficile da calcolare sul lungo termine. Ma la fotografia attuale, per quel che riguarda il continente africano, dice che Algeria, Libia e Sudafrica sono le nazioni più colpite, con l’imposizione di una tariffa del 30% per le merci dirette verso gli Stati Uniti. Appena dietro la Tunisia (25%), poi tutte le altre, con un 15% generalizzato. La Casa Bianca ha inoltre già avvisato che stabilirà una sanzione aggiuntiva del 40% sui cosiddetti trasbordi, vale a dire le merci che vengono spedite da un paese ad alta tariffa a un paese a bassa tariffa prima di essere inviate negli Stati Uniti. Un’applicazione puntuale dello slogan trumpiano “Trade, not aid”, vale a dire “commercio, non più aiuti a fondo perduto”. Come riportava Bloomberg il mese scorso: «Il messaggio del presidente degli Stati Uniti all’Africa sembra chiaro: stiamo passando dagli aiuti al commercio... A lungo termine questo sarà molto più efficace, sostenibile e vantaggioso di qualsiasi altra cosa che potremmo fare insieme». Ma i rapporti tra Stati Uniti e Africa nel suo insieme sono tutt’altro che sereni, soprattutto dopo l’imposizione, lo scorso giugno da parte di Trump, di un blocco totale della concessione dei visti per 7 paesi africani (Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libia, Somalia e Sudan) e parziale per altri 3 (Burundi, Sierra Leone e Togo).
Un provvedimento così motivato dalla Casa Bianca: “Gli Stati Uniti devono essere vigili durante il processo di rilascio dei visti per garantire che gli stranieri ammessi negli Usa non intendano danneggiare gli americani o i nostri interessi nazionali». Non proprio un gesto d’amicizia. Secondo un sondaggio realizzato lo scorso maggio dal centro studi Afrobarometer in 39 stati africani, il “sorpasso” della Cina rispetto agli Stati Uniti è già avvenuto, almeno in termini di reputazione: secondo il 60% degli africani intervistati la Cina svolge un’influenza positiva sul continente, contro il 53% di pareri favorevoli agli Usa. Lo stesso sondaggio certifica peraltro che il gradimento della democrazia in Africa è in calo: “In tutto il continente, il 45% degli africani pensa che i propri paesi siano per lo più o completamente democratici. Ma solo il 37% afferma di essere soddisfatto del modo in cui funziona la democrazia nelle proprie nazioni”.
Il Lesotho dichiara lo stato di calamità
Tornando alla questione dazi: com’era prevedibile le ripercussioni maggiori si stanno riversando sui paesi più poveri, come il piccolo Lesotho, che Trump ha definito «un paese di cui nessuno ha mai sentito parlare», anche se qui c’è una delle principali fabbriche di produzione dei jeans Levi’s e Wrangler (26 milioni di jeans prodotti lo scorso anno) e lo scorso anno le esportazioni negli Usa hanno raggiunto il valore di 237 milioni di dollari, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, mentre al contrario gli Stati Uniti hanno esportato merci per 3 milioni di dollari. Il primo ministro del Lesotho, Samuel Matekane, aveva dichiarato che l’enorme tariffa (inizialmente fissata al 50%, poi ridotta al 15%), combinata con l'interruzione degli aiuti statunitensi alla nazione montuosa, interamente circondata dal Sudafrica, abitata da poco più di 2 milioni di persone, «ha paralizzato le industrie che in precedenza sostenevano migliaia di posti di lavoro». E perciò ha dichiarato lo stato di calamità. Fino all’insediamento di Trump, il Lesotho beneficiava di un accordo commerciale che consentiva, anche ad altri paesi subsahariani, di esportare merci negli Stati Uniti senza alcun dazio sulla base dell’African Growth and Opportunity Act, che dal 2000 è stato un muro portante per le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Africa (soprattutto nei settori dell’abbigliamento, dell’agricoltura e dell’automotive) ma che scadrà il prossimo 30 settembre, lasciando aperte sia incognite (sarà prorogato?) sia opportunità. Ma è innegabile che, come spiega l’economista Lionel Zinsou, «con l’aumento dei doveri doganali, l’accesso al mercato americano può diventare proibitivo, riducendo così la competitività dei prodotti locali e rallentando la crescita economica» delle nazioni africane, oltre ad avere un probabile impatto sull’occupazione, con perdita di posti di lavoro.
Perché le potenzialità dell’Africa, come si accennava prima, sono immense. E perché gli indicatori di crescita per il 2025 sono eccellenti, anche se l’ultimo report a fotografare la situazione è stato l’Africa Outlook dell’Economist Intelligence Unit (Eiu), stilato dal settimanale britannico alla fine dello scorso anno, dunque quando il ciclone Trump era ancora lontano dall’essere previsto. Quel rapporto, che comunque resta in buona sostanza valido, sosteneva che 12 paesi africani figurano nella Top 20 degli Stati a più rapida crescita al mondo, tra cui il Senegal (favorito dalle entrate derivanti dal petrolio e dal gas), il Rwanda (grazie alla ritrovata solidità delle politiche macroeconomiche), la Libia, la Costa d’Avorio, l’Uganda e l’Etiopia. E che un segno positivo di crescita potrebbe riguardare in tutto 44 nazioni africane, grazie soprattutto al miglioramento delle condizioni finanziarie, al calo dell’inflazione e all’aumento degli investimenti esteri.
E se da un lato Washington sembra non vedere queste opportunità («Il presidente Trump sta usando i dazi come uno strumento necessario e potente per mettere l’America al primo posto dopo molti anni di deficit commerciali insostenibili che minacciano la nostra economia e la sicurezza nazionale», ha scritto la Casa Bianca in una nota), dall’altro la Cina è pronta ad ampliare la sua quota di mercato nel mercato africano: il che di per sé non è una novità, dal momento che il primo prestito in denaro, da Pechino alla Guinea, risale al 1960. Come ha spiegato Gwede Mantashe, ministro sudafricano delle risorse minerarie e petrolifere: «Se gli Stati Uniti impongono tariffe elevate, dobbiamo cercare mercati alternativi. Il nostro principale partner commerciale è già la Cina, non gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il numero due». Il “patto commerciale” tra Cina e Africa è stato poi ulteriormente rafforzato lo scorso anno, quando Pechino ha annunciato investimenti per oltre 50 miliardi di dollari e l’apertura anche alle grandi economie del continente: Nigeria, Sudafrica, Egitto, Kenya e Marocco.

Le gru sistemano i container dalle navi all'interno del terminal container della Kenya Ports Authority (KPA) nel porto di Mombasa, Kenya, 30 luglio 2025. REUTERS/Laban Walloga
I rischi della “trappola del debito”
Ma c’è chi predice prudenza e attenzione: abbracciare le immense disponibilità cinesi ha un costo, in termini commerciali, ma anche di geopolitica. Qualche dato: l’importo totale dei prestiti documentati dalla Cina all’Africa è attualmente di 182,3 miliardi di dollari, spalmati su 1.306 operazioni di prestito, soprattutto orientati su progetti nel settore energetico (62,72 miliardi di dollari per la costruzione di centrali elettriche), dei trasporti (52,65 miliardi di dollari, che hanno finanziato ferrovie, autostrade e porti), nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (15,67 miliardi di dollari). In cima alla lista dei paesi africani con i più alti prestiti dalla Cina c’è l’Angola (46 miliardi di dollari), seguito da Etiopia (14,5 miliardi), Egitto (9,7 miliardi) e a pari merito Kenya e Nigeria (9,6 miliardi). Scriveva al proposito, pochi mesi fa, la rivista di analisi The Geopolitics: «Gli aiuti militari e gli investimenti su larga scala della Cina, principalmente attraverso la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB) e la Belt and Road Initiative (BRI), hanno recentemente aumentato l’impronta della Cina in Africa e sollevato preoccupazioni riguardo agli effetti a lungo termine. Il concetto di “diplomazia della trappola del debito”, comunemente usato per caratterizzare le politiche di prestito della Cina in Africa, è al centro di queste preoccupazioni. Questo fenomeno descrive come la Cina presti quantità eccessive di denaro ai paesi africani Etiopia, Angola, Sudan, Congo, Kenya e Nigeria per costruire dipendenza e ottenere leva quando queste nazioni hanno difficoltà a ripagare i loro debiti. La crescente influenza della Cina sull’Africa solleva preoccupazioni sul fatto che le sue politiche finanziarie spingano i paesi del continente in cicli di debito ingestibili ed erodano la loro sovranità». A volte non servono le armi: le nazioni si conquistano anche così.