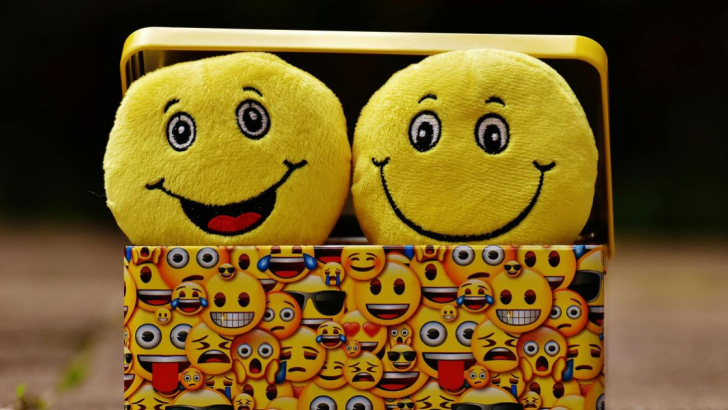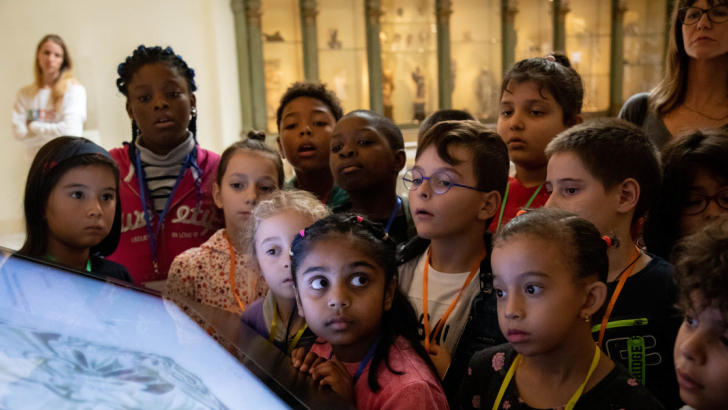Disinformazione: vecchie strategie per nuovi inganni

Foto: Adobe Stock
“La disinformazione non nasce dal nulla, ma è costruita con metodo, finanziamenti e strategie precise”. È questa la rivelazione fondamentale di Mercanti di dubbi (Merchants of Doubts), libro bestseller scritto dagli storici della scienza statunitensi Naomi Oreskes ed Erik M. Conway, pubblicato nel nostro Paese in edizione aggiornata nel 2025. Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico, comincia da qui per presentare un secondo volume degli stessi autori, edito per la prima volta in lingua italiana sempre nel 2025: Il grande mito (The Big Myth) dialoga con l’opera precedente e ne amplia i significati, spiegando le ragioni per cui per lungo tempo tante persone abbiano trovato convincenti determinate narrazioni. E offre una chiave di lettura per il presente.
Naomi Oreskes e Massimo Polidoro si confronteranno su questi temi il prossimo 5 dicembre nel corso del convegno nazionale di comunicazione della scienza della Sissa di Trieste. Qualche anticipazione in una lunga intervista a Polidoro.
Partiamo dalle premesse: chi sono i “mercanti di dubbi”?
Si tratta di una definizione coniata da Oreskes e Conway. I mercanti di dubbi sono dei professionisti del discredito: consulenti, think tank, comunicatori pagati per seminare incertezze e, purtroppo, anche scienziati. Scienziati che accettano di mettere in vendita la propria professionalità – non necessariamente solo per soldi, anche se in alcuni casi è così – per seminare dubbi e incertezze su risultati scientifici solidi, quando questi danneggiano eventuali interessi economici o politici.
Oreskes parte dall’esempio dell’industria del tabacco. Quando le prove sull’associazione tra fumo e cancro ai polmoni diventano schiaccianti e incontrovertibili, la strategia delle industrie è di insinuare il dubbio su questi risultati. Assoldano scienziati compiacenti, pagati o comunque disponibili a sostenere gli interessi delle aziende, che compaiono in televisione dando spazio a queste posizioni. Il risultato è diffondere l’idea che la scienza sia divisa e non vi siano ancora certezze.
In seguito, questo schema viene riciclato su molti altri temi: dal buco nell’ozono ai pesticidi, dall’inquinamento industriale al cambiamento climatico. Questi personaggi non producono nuova scienza, ma mettono in dubbio quella esistente, enfatizzando ogni fisiologica incertezza della ricerca scientifica, dato che la scienza non produce verità dogmatiche, ma conoscenza probabilistica. Lo scopo è bloccare qualsiasi tipo di regolamentazione e tutela relativa alla salute, all’ambiente o a qualunque altro ambito che possa minare eventuali interessi economici.
Come ci si può difendere dalle manipolazioni dell’informazione?
Innanzitutto diventando consapevoli che esistono persone che agiscono in questo modo. I mercanti di dubbi non attaccano la scienza nel suo complesso, ma ne amplificano le fisiologiche incertezze. Quindi serve guardare innanzitutto al consenso su una determinata affermazione, non al singolo esperto che sostiene il contrario, screditando risultati che invece sono solidi.
In secondo luogo bisogna chiedersi se esistono conflitti di interesse, chi paga le ricerche, dove vengono pubblicate, se le testate sono peer reviewed e credibili, oppure se c’è un interesse non dichiarato.
E ancora, dobbiamo saper cogliere dei segnali d’allarme quando qualcuno sostiene che “la scienza non è concorde”, che “è tutto da dimostrare”, che “ci sono studi che affermano il contrario”. A quel punto bisogna domandarsi di che studi si tratta, quanti sono, dove sono stati pubblicati, quanto è credibile la testata e rispetto a quanti altri sostengono il contrario.
L’era digitale ha reso la disinformazione più orizzontale: chiunque può diffondere contenuti che diventano virali. I mercanti di dubbi dunque esistono ancora o siamo passati a un sistema più frammentato di manipolazione?
I mercanti di dubbi esistono ancora, con una differenza però rispetto a un tempo: si sono moltiplicati i loro megafoni. Inizialmente erano pochi: le industrie, le lobby, i think tank, le “istituzioni” create dalle aziende stesse fingendo che fossero organi indipendenti. Ed esistevano pochi canali di comunicazione: televisione, radio, conferenze stampa, rapporti ufficiali.
Oggi ci sono ancora strutture organizzate che continuano ad avere grande interesse a seminare dubbi su clima, vaccini, pesticidi, energia, ma in aggiunta c’è una miriade di piccoli amplificatori: influencer pagati, pagine social, canali Telegram, YouTuber, utenti singoli che, catturati da un certo tipo di ideologia, rilanciano quei dubbi anche ignorando da dove arrivino le informazioni.
I mercanti di dubbi non sono spariti: sono ancora i registi di un certo tipo di propaganda. Producono i messaggi, le narrazioni. E la distribuzione è diventata orizzontale, frammentata e virale.
Quali sono le leve emotive che si usano per convincere il pubblico?
Il primo pulsante da premere è sempre quello della paura, dell’ansia. La paura è molto potente perché ci spinge a cercare conferme, e non a verificarle. Il secondo è l’indignazione che induce le persone a schierarsi contro le élite. È la leva che riesce a trasformare un dubbio in una battaglia. Per esempio, quando si ha la convinzione di essere in qualche modo ingannati o che la scienza sia soggetta a controllo. Questo tipo di indignazione crea un senso di appartenenza, sviluppa l’idea di far parte di una tribù, di un gruppo, dà un’identità. E quando una convinzione diventa identitaria è difficile da abbandonare.
La terza leva emotiva su cui spingere è la speranza consolatoria. Molte false credenze attecchiscono perché rassicurano: quando si pensa, per esempio, che il mondo segua un ordine segreto; che esista una cura per ogni male che viene tenuta nascosta; che pochi malvagi governino il mondo e che quindi possano essere sconfitti. Quando il dato scientifico è scomodo, il dubbio – non quello autentico e importante alla base della scienza – diventa un alibi per non cambiare nulla.
Si può affermare dunque che la disinformazione non sia solo un problema di conoscenza, ma anche di potere?
Assolutamente. La disinformazione non nasce dalla mancanza di istruzione, non è questione di “analfabetismo scientifico”. Riguarda piuttosto chi ha risorse e visibilità tali da poter decidere cosa può essere considerato vero e cosa invece può venir messo in dubbio, orientando in questo modo il dibattito.
Non servono esperimenti o prove: basta spostare l’attenzione. È quello che vediamo fare abitualmente da certi personaggi che, non avendo argomenti da sostenere, tanto meno scientifici, si inventano ogni giorno argomenti assurdi e vergognosi. Basti pensare a Trump. Se si crea incertezza, se si sposta la discussione, le regolamentazioni vengono rimandate, se non sospese. E chi ha interessi in gioco continua indisturbato con le proprie azioni.

Foto: Envato
Con Trump la disinformazione è diventata parte del gioco politico….
Nel suo caso la disinformazione è sempre stata parte del gioco politico. Il Washington Post, ha contato più di 30.000 affermazioni false o fuorvianti fatte da Trump durante il primo mandato. Allora si tentava ancora di frenarlo, anche all’interno del Partito Repubblicano: alla Casa Bianca c’era chi in qualche modo cercava di opporsi, di contenere quegli eccessi assurdi, di indirizzare verso politiche più sensate. Ora non ci sono più sforzi in questa direzione. Trump è circondato da persone che lo assecondano, che perseguono interessi estremi. La disinformazione è la regola di base e non è più nemmeno mascherata.
L’intelligenza artificiale cambierà ancora una volta il modo in cui si manipola o si difende la verità scientifica?
L’intelligenza artificiale è solo uno strumento: è il modo in cui viene usata a fare la differenza. Da un lato l’AI può moltiplicare le forme di manipolazione: permette di creare contenuti molto più convincenti – deepfake, voci, video che sembrano autentici – e di personalizzarli sul profilo psicologico di chi ne usufruisce, basandosi sulle sue convinzioni e i suoi pregiudizi. Si possono addirittura automatizzare la produzione di contenuti che inondano la rete con visioni alternative dei fatti. E questo è pericoloso.
Dall’altro lato, però, l’intelligenza artificiale può essere anche uno strumento di difesa, perché può aiutare a riconoscere reti coordinate di disinformazione, bot, schemi ricorrenti di manipolazione. Può facilitare il fact checking, il confronto tra le fonti, la verifica di immagini e video. A chi fa giornalismo, a chi lavora nella ricerca, ma anche a tutta la cittadinanza può fornire strumenti che altrimenti non si potrebbero mai avere.
La domanda di fondo però non cambia: chi controlla questi strumenti? Se restano nelle mani di pochi attori opachi – come quelli che oggi gravitano intorno a Trump – il vantaggio non può che andare ai manipolatori. Se invece vengono usati in modo trasparente, aperto, regolato, potrebbero diventare alleati della democrazia. Ancora una volta, dunque, servono regole. Regole che l’Europa, prima tra tutte, aveva cercato di darsi in modo intraprendente. Oggi però vengono contestate, soprattutto dagli Stati Uniti, rallentate e, in alcuni casi, fermate. Esattamente come la strategia dei mercanti di dubbi.
Come si difende la fiducia nella scienza senza cadere nel dogmatismo scientifico?
Come sostiene Naomi Oreskes, non dobbiamo avere fiducia nei singoli scienziati ma nella comunità scientifica. I fatti scientifici si costruiscono attraverso verifiche ed esperimenti: quanto più sono numerosi, in tutto il mondo e in contesti diversi, tanto più i risultati diventano credibili. Ed è questo che ci aiuta ad avere fiducia.
Oreskes ha scritto un libro dal titolo Perché fidarsi della scienza, in cui spiega che bisogna dare credito al processo della scienza. Il processo scientifico prevede che ognuno possa avanzare le proprie ipotesi, seguendo però determinate regole: si devono rispettare i metodi, fare verifiche, rendere disponibili tutti i dati per permettere agli altri di replicare gli esperimenti. È possibile commettere errori, naturalmente, che si possono correggere, ma tutto deve avvenire in modo trasparente. E il consenso si forma nel tempo. La fiducia si costruisce anche svelando i meccanismi della scienza, sempre in un’ottica di condivisione delle conoscenze.
C’è inoltre un altro elemento importante da considerare e cioè l’umiltà, che è profondamente radicata nella scienza, anche se non sempre negli scienziati. L’umiltà rende consapevoli del fatto che le conoscenze acquisite potrebbero essere solo una parte del tutto, che si potrebbero ottenere nuove prove e nuovi elementi. È questa umiltà che permette la correzione, l’ampliamento delle conoscenze. Quando invece gli scienziati giudicano e ridicolizzano – e ne abbiamo visti tanti, purtroppo – non fanno che alimentare la sfiducia e la diffidenza in persone che poi magari tendono ad abbracciare teorie complottiste.
Nel 2023 Oreskes e Conway pubblicano The Big Myth, uscito in traduzione italiana proprio recentemente (Il grande mito). Qual è il significato di quest’opera?
Il sottotitolo del libro è molto esplicativo: come il business ha creato la leggenda del libero mercato e ci ha insegnato a odiare il governo. Il volume spiega perché le industrie siano così motivate a coltivare il dubbio per confondere il pubblico. E la ragione risiede nella volontà di difendere una precisa visione del mondo, non solo imprenditoriale. Una visione secondo cui libertà economica e libertà politica appaiono inscindibili, e qualunque tipo di regolamentazione viene vista come una sorta di tirannia.
Il libro smonta invece questi meccanismi, ripercorrendo l’uso ingannevole dell’informazione fin dai tempi di Roosevelt, di Reagan. Racconta la demonizzazione di scienziati come Rachel Carson. È un viaggio che completa in un certo senso Mercanti di dubbi, perché ci aiuta a capire che la responsabilità, la libertà anche economica sono concetti da approfondire, se vogliamo capire la strada che stiamo percorrendo e dove intendiamo andare.