Le emoji e il problema del linguaggio chiaro
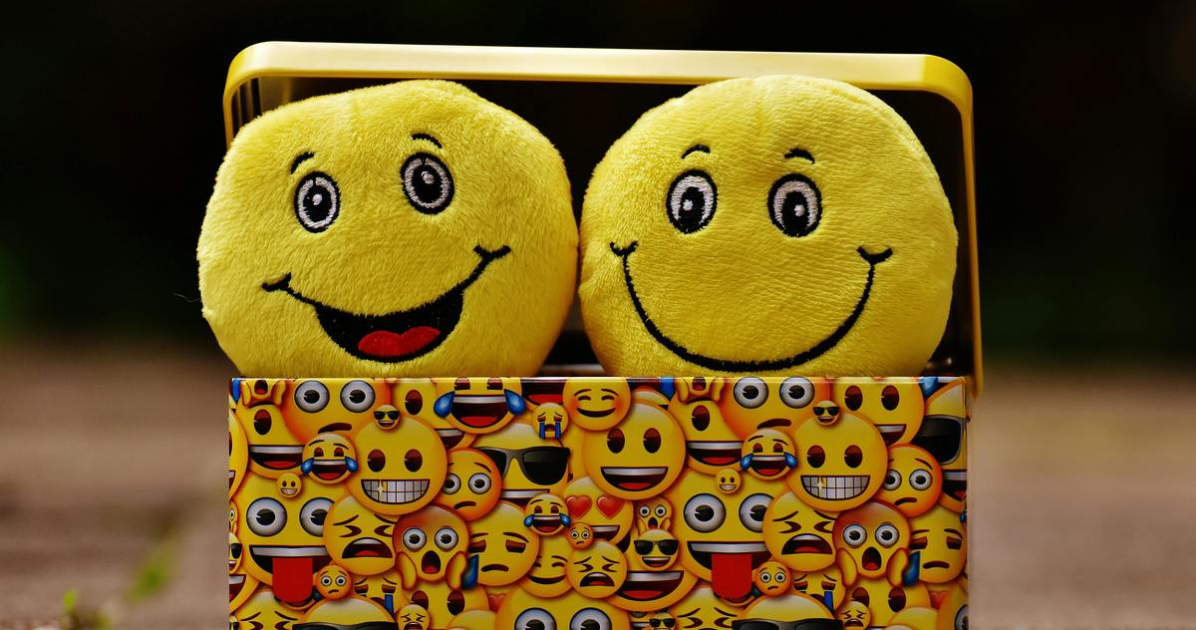
“Sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci tu” è una frase che si legge di frequente nei commenti sui social network, con buona pace dei principi base del plain language (linguaggio chiaro) che prevedono che il lettore sia messo nella posizione di comprendere un testo in modo da poter trovare quello che gli serve, capire quello che trova e usare quello che capisce.
Il linguaggio chiaro è un principio di civiltà, perché scrivere (e parlare) in modo comprensibile significa rispettare chi ci legge, evitare fraintendimenti, risparmiare tempo, energie e magari anche cause legali.
Eppure, nell’era dei messaggi istantanei, dei vocali da dieci secondi e delle risposte a colpi di emoji, la comunicazione rischia di diventare una giungla semantica che divide generazioni e culture. Basta un “👍”, un pollice alzato usato nel modo sbagliato per avere problemi, perché i messaggi brevi e simbolici, se slegati dal contesto, diventano un terreno fertile per l’ambiguità. La chiarezza, al contrario, ha bisogno di intenzione, di precisione, e spesso di qualche parola in meno (purché ben progettata).

In questo articolo vedremo perché comunicare in modo chiaro è così importante, cosa c’entrano Churchill e le emoji, e come possiamo evitare che un gesto o una faccina ci mettano nei guai.
Un problema di tempo e attenzione
Negli ultimi anni, con l’avvento di Internet prima e degli smartphone poi, le modalità di comunicazione sono cambiate molto: i messaggi si sono moltiplicati, ma l’attenzione con cui li produciamo è diminuita, perché gli interlocutori si aspettano risposte veloci e quindi le persone non hanno tempo di pensarci troppo (anche se la disattenzione può portare a fraintendimenti che per essere risolti richiederanno molto più tempo di quello che si sarebbe impiegato a produrre un messaggio chiaro e ben progettato).
Ed ecco che in questo modo ci troviamo ogni giorno a decifrare messaggi come “👍”, senza sapere se chi ci scrive è d’accordo, infastidito o semplicemente troppo stanco per digitare qualcosa di più strutturato. Il punto è che, quando manca il contesto, anche un semplice pollice in su può portarci in un campo minato semantico.
Quando il pollice in su ti giudica
Partiamo proprio da questa emoji “👍”, che sembra innocua ed è una delle più antiche e più usate al mondo. Compare in milioni di messaggi ogni giorno e ha tutte le carte in regola per essere considerata universale, ma forse è comprensibile solo nella maggior parte dei casi, il che non è sufficiente.
Sulla carta (o meglio, sullo schermo) dovrebbe comunicare approvazione, accordo, supporto, un giudizio positivo, insomma.
Il suo abuso, però, ne ha esteso i significati. Rispondere con il pollice alzato è molto comodo, è uno dei primi simboli che si trovano sulle tastiere visuali dei sistemi di messaggistica più popolari e Facebook per anni lo ha reso il modo più rapido per chiudere una conversazione. E, certo, può significare “Ok” o “sono d’accordo”, ma a un certo punto ha cominciato a caricarsi di un’ambiguità sottile, assumendo il significato di “voglio chiudere questa conversazione perché non ha senso parlare con te”. Una versione visiva istantanea dell’”ok boomer” diventato virale nel 2019 quando Chlöe Swarbrick, deputata neozelandese del partito dei Verdi, stava parlando di cambiamento climatico e un collega più anziano l'ha interrotta con un commento non del tutto udibile, ma probabilmente paternalistico. La deputata aveva usato “ok boomer” come intercalare tranchant, che le aveva permesso di non perdere il filo del discorso e continuare a parlare con passione come se nulla fosse.
Anche una risposta con il pollice in su può interrompere una conversazione sgradita e chiuderla senza appello: è asciutto, sintetico e definitivo. Passivo aggressivo, se vogliamo dirla tutta.
L’uso delle emoji è cambiato nel tempo
Le emoji nascono come strumenti para-linguistici: non sono parole, ma aggiungono un elemento emozionale e visivo al testo. In questo senso funzionano come il tono di voce, le espressioni del viso o la postura: un “grazie” può essere gentile o sarcastico, a seconda del modo in cui lo si dice, e senza vedere la persona che manda il messaggio o avere un minimo di contesto regolarsi è difficile: per questo aggiungere un simbolo può essere utile a chiarire il significato e l’intenzione.
Con le emoji il problema nasce quando vengono usate al posto delle parole. In uno studio pubblicato nel 2015, Stark e Crawford osservano che “l’uso delle emoji si è evoluto da supporto affettivo a sostituto simbolico di frasi intere, ma senza la stabilità semantica che garantisce la comunicazione chiara”. Un’emoji da sola può dire tutto e niente: un cuore rosso in risposta a un messaggio testuale può voler dire “grazie di cuore”, oppure “non ho voglia di rispondere”, e ci sono casi in cui fa tutta la differenza del mondo, basti pensare a quando si messaggia con un potenziale partner. Un’emoji con gli occhi al cielo può esprimere frustrazione, sarcasmo o semplice stanchezza, e il destinatario dovrà capirlo da solo, arrovellandosi su un contesto che però non può comprendere né grazie al testo né grazie alle espressioni facciali o al tono dell’interlocutore.
Sociolinguistica delle emoji: conflitti generazionali e malintesi culturali
Ma perché una emoji dovrebbe creare tanta confusione? La risposta non è solo nella psicologia individuale, ma anche nella sociolinguistica.
Diversi studi hanno dimostrato che le emoji vengono interpretate in modo diverso a seconda dell’età, del genere e della cultura. Un articolo di Monica Riordan, ricercatrice specializzata in psicologia sociale del linguaggio e comunicazione mediata da computer, pubblicato su Journal of Computer-Mediated Communication e citato in un articolo scientifico, ha evidenziato come le generazioni più giovani tendano a vedere le emoji più letteralmente, mentre boomer e millenial le usano con un intento più simbolico o chiarificatore. Il risultato? Il pollice in su può sembrare neutro a un cinquantenne, ma passivo-aggressivo a un ventenne.
A questo si aggiungono anche le differenze culturali. In Medio Oriente, ad esempio, il pollice in su può essere percepito come offensivo. In Grecia e in alcuni Paesi balcanici, anche il gesto del “ciao” con il palmo aperto può avere un significato volgare. Le emoji che rappresentano gesti della mano (👌, 🤘, ✌️) non sono interpretate ovunque allo stesso modo: negli Stati Uniti, per esempio, il gesto 👌fatto unendo in un cerchio pollice e indice è stato associato a gruppi di estrema destra: su 4chan, noto forum anonimo spesso frequentato da troll e gruppi estremisti, nel 2017 si è diffusa una campagna satirica che voleva far credere che questo gesto rappresentasse le lettere "W" e "P", cioè "White Power". Anche se la campagna era nata come trollata, l’emoji è stata effettivamente adottata da alcune frange dell’estrema destra americana, al punto che due anni dopo la Anti-Defamation League (ADL, un’organizzazione che monitora l’antisemitismo e l’odio razziale) l’ha inclusa nella sua lista di simboli d’odio.
Non solo emoji: il caso di Churchill
In tempi non sospetti e sicuramente meno tecnologici, anche Winston Churchill è caduto in una trappola simile: adottò il gesto della “V” con indice e medio alzati a formare questa lettera, che stava per “vittoria” e che diventò uno dei segni più iconici della propaganda alleata. Il gesto fu usato ovunque: manifesti, comizi, fotografie ufficiali, ma all’inizio Churchill lo faceva al contrario, cioè con il palmo della mano rivolto verso se stesso.
Questo ha creato non pochi imbarazzi diplomatici, perché nel Regno Unito (e in altri Paesi anglofoni), quel gesto con il palmo verso l’interno è considerato un insulto volgare, l’equivalente britannico del nostro “gesto dell’ombrello” o del dito medio. Insomma: invece di trasmettere fiducia alla nazione, Churchill stava mandando a quel paese fotografi, giornalisti e cittadini ogni volta che sbagliava.
Fu il suo entourage a farglielo notare, e da allora il primo ministro imparò il gesto corretto, come si vede nei celebri scatti ufficiali.

“Winston Churchill gives V sign after lunchtime meeting with John Foster Dulles, September 17, 1954” di Levan Ramishvili
Il fatto che persino Churchill, uomo di retorica e propaganda, abbia potuto sbagliare un gesto così carico di significato è un’ottima dimostrazione di quanto i segnali non verbali siano delicati e tutt’altro che universali: se perfino un leader politico in guerra può confondersi, figuriamoci cosa può accadere con una emoji inviata senza pensare.
La teoria dietro la pratica: chiarezza, contesto, cooperazione
La comunicazione chiara è un tema molto più serio di quanto sembri. Teorie come quella del Plain Language Movement insistono sull’importanza di evitare ambiguità, ridondanze e frasi inutilmente complicate per favorire una comprensione immediata. Chi scrive un testo viene invitato a non perdersi in artifici inutili, ad andare dritto al punto e a usare meno parole possibili. A volte, però, le parole, o le emoji, non sono sufficienti a restituire il contesto: una delle massime conversazionali di Paul Grice, filosofo del linguaggio, era quella della quantità: non dire né troppo né troppo poco. Una emoji da sola viola questa norma, perché obbliga il destinatario a una vera e propria operazione ermeneutica.
La comunicazione deve essere un atto cooperativo, e se una delle due parti gioca a fare il mimo con le emoji, l’altra si ritrova a indovinare intenzioni, emozioni e sfumature di significato senza avere gli strumenti per farlo.
Le conseguenze legali di un emoji
Se non foste ancora convinti a non usare le emoji alla leggera, un pollice in su pigiato senza pensare può diventare anche molto costoso: nel 2023, un agricoltore canadese è stato condannato a pagare oltre 80.000 dollari per averlo usato in risposta a un contratto inviato via messaggio. Il giudice ha stabilito che l’emoji, in quel contesto, equivaleva a una firma digitale e quindi aveva valore legale, perché la situazione era molto chiara.
Il caso è stato citato in numerosi articoli sul tema dell’ambiguità legale della comunicazione digitale, e ha aperto un dibattito: possiamo davvero usare emoji in contesti formali, senza il rischio di essere fraintesi? Nel dubbio forse sarebbe meglio evitare.
Riportare le emoji al loro uso originario
Nessuno sta dicendo di abolire le emoji, che sono strumenti espressivi, creativi, perfetti per alleggerire una conversazione, per aggiungere tono e calore alle parole, per comunicare con efficacia quando manca il linguaggio del corpo, ma andrebbero usate con criterio. Come dice la guida del Plain Language Association International, la chiarezza non è solo una questione di semplicità linguistica, ma di intenzione comunicativa: capire cosa si vuole dire, e trovare il modo migliore per farlo arrivare al destinatario nel modo più semplice e immediato possibile.
Dobbiamo tenere presente che le emoji non sono un linguaggio universale, ma segnali flessibili, plasmati dalla cultura, dalla generazione e dal tono della conversazione: pretendere che basti una faccina o un pollice per comunicare in un mondo pieno di sfumature, è come pensare che basti un bignami per spiegare tutta la filosofia di Kant.









