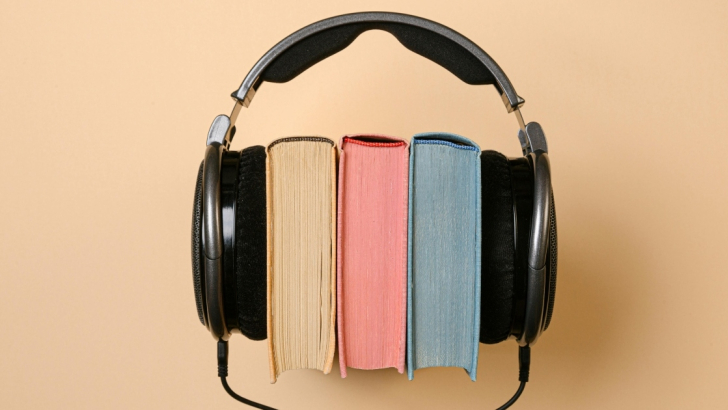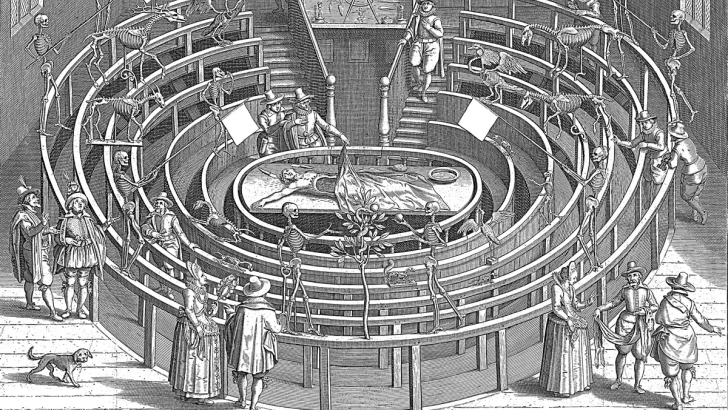La colonia: la ritirata silenziosa da un presente troppo frenetico

In un panorama editoriale popolato da romanzi sulle derive settarie incardinati nel genere horror o thriller psicologico, La colonia di Annika Norlin (2025, Edizioni E/O) rappresenta un’anomalia. Nessun culto sanguinario, poca manipolazione mentale, forse anche inconsapevole e una leader carismatica suo malgrado, a sua volta in fuga dalle implicazioni del comando.
Eppure l’inquietudine serpeggia tra le pagine, ed è legata alla pacatezza silenziosa di chi ha smesso di lottare contro il mondo e ha semplicemente scelto di uscirne. La colonia racconta una fuga dal rumore, dall’efficienza, dal sovraccarico sensoriale e cognitivo che caratterizza la vita metropolitana contemporanea, ma lo fa con toni dimessi, meditativi, intrisi di malinconia più che di tensione narrativa.
L’abbandono del mondo civilizzato, un passo alla volta
Il romanzo alterna le osservazioni di Emelie, voce narrante intimista e smarrita, con brani scritti e raccontati dai membri del gruppo con cui si troverà a interagire, in particolare da giovane Låke, che non ha mai conosciuto un mondo diverso da quello isolato della Colonia. Emelie è una giornalista freelance, calata fino al midollo in un contesto metropolitano, che ha vissuto per anni immersa nella macchina dell’efficienza e dell’autosfruttamento: sostituzioni, promesse di impiego, riunioni, multitasking. “Avevo molte spese – racconta – il mutuo era oneroso, ma amavo ogni singolo metro quadrato di quella casa, che attestava la mia autonomia. Ero pronta ad ammazzarmi di lavoro per poter continuare ad averla. Ero la tiranna di me stessa. Ero così orgogliosa della mia vita. Se qualcuno mi avesse guardata da fuori, avrebbe persino potuto credere che sapessi cosa stavo facendo”.
Neanche per un secondo Emelie si è chiesta se quello che faceva e sentiva fosse giusto, finché, inevitabilmente, qualcosa si è spezzato: la sua narrazione iniziale è un ritratto nitido di burnout: palpitazioni, insonnia, irritazione cronica, senso di colpa. Non c’è una frattura netta, un trauma, un crollo hollywoodiano, una scena madre da raccontare agli amici: semplicemente una mattina Emelie non riesce più ad alzarsi, perché il disagio accumulato nel tempo travalica il confine della sopportazione.
“ L’inquietudine è lì, come pure l’irritazione, e insieme fanno una piccola riunione, e tu non hai nessun posto dove scappare, nessuno. Sei bloccato dentro te stesso, nel tuo stesso corpo disgustoso Annika Norlin
Da qui la decisione di ritirarsi nel nord della Svezia, nei boschi attorno alla terra della nonna morta. Una ritirata silenziosa di cui mette a parte solo una conoscente: gli amici e i colleghi con cui passava tutto il suo tempo non la cercano, ma si limitano a sostituirla, come si fa con gli oggetti che non rispondono più alle aspettative degli utenti, come se prendersi il lavoro di un altro all’ultimo minuto o uscire per una festa fino all’alba anche quando il corpo urla “fermati!” non fosse abbastanza per avere un ruolo nella vita degli altri.
Un altro mondo è possibile?
Dalla sua tenda nel bosco, Emelie nota un gruppo di sette persone che vive nella foresta in modo radicalmente diverso: mangiano insieme, ringraziano i pesci che pescano prima di consumarli, si lavano a vicenda, si toccano senza nessuna malizia e dormono sotto le stelle pur avendo una casa. Gli appassionati del genere avranno riconosciuto alcuni topoi dei libri sulle sette, ma qui non c'è nulla di esoterico o inquietante, risulta semplicemente un comportamento molto strano. Ed ecco che si fa strada l’ipotesi di una convivenza più lenta, non codificata, che si costruisce man mano nei gesti minimi, che si trasformano in riti collettivi: dividere il pane, passare una spugna sul braccio dell’altro, raccogliere le patate senza parlare. Ed ecco che Emelie viene accolta nel gruppo, perché, come gli altri membri, è una fuggiasca, che può perdersi nell’eterno presente di questa Colonia.
Un eterno presente che non risolve, ma protegge
È importante rilevare anche ciò che manca: la retorica della salvezza. Tutti i personaggi sono scappati da qualcosa, ma nessuno parla mai di guarigione, nessuno fa proselitismo, nessuno inizialmente si interroga sul futuro, malgrado siano passati anni dalla costituzione del gruppo originario. La colonia esiste semplicemente come spazio di sospensione, il mondo esterno non è un nemico da combattere, ma qualcosa a cui non si può tornare, anche se ogni personaggio ha un motivo diverso che gli fa vedere la vita tradizionale come impraticabile.
Il titolo stesso, La colonia, evoca ambiguità. Rimanda a un mondo parallelo, autarchico, ma anche ai ricordi infantili: le colonie estive, i campeggi, la cura collettiva. È un universo chiuso, ma non chiuso da sbarre o dottrine, semplicemente dalla volontà di chi ha bisogno di una pausa dal mondo, e anche chi, nella seconda parte della storia, vorrebbe uscirne non riesce a decidersi, perché nella colonia si sente protetto, e l’alternativa a quel mondo può essere molto peggiore. Emelie, la protagonista, non viene risucchiata da una setta, non subisce lavaggi del cervello, si presenta già rotta, e trova in questo nuovo modo di vivere una soluzione, non necessariamente la migliore, al suo disagio: nessuno la trattiene, e anche se, con il favore dell’alcol, viene colta da dubbi sulla piega che prendono i rapporti nella colonia, non vuole scappare. Eppure nessuno glielo impedirebbe: se volessimo vedere la colonia come una trappola, ci si sarebbe messa da sola.
La simbologia del formicaio
Tra i fili conduttori del romanzo spicca una presenza minuscola e insistente: le formiche. Appaiono ovunque, come metafora flessibile e ambivalente. All’inizio, Emelie descrive la sua vita cittadina come un "formicolio": i corpi schiacciati nel bus, i passi nelle scale mobili, il ritmo incessante.
“ Sono chiusi nei loro mondi, diretti verso qualcosa d’importante, lo si percepisce. In tutti gli sguardi c’è una direzione. Si è tutti parte del formicolio Annika Norlin
Ma quando una donna del gruppo sosta davanti a un formicaio per minuti interi, con lo sguardo ipnotizzato, il senso si ribalta: le formiche non sono più il simbolo di ritmi brulicanti e alienati, ma diventano quello di interdipendenza, di reti silenziose collaborative, di un ordine rispettato a beneficio della collettività.
La metafora del formicaio attraversa tutto il romanzo come una corrente sotterranea: Norlin non la esplicita mai fino in fondo, ma la lascia agire per accostamenti, intuizioni, gesti minimi. Il formicaio è ambivalente: da un lato rimanda a una società iper-organizzata, instancabile, apparentemente impersonale, cioè quella che Emelie ha lasciato; dall’altro diventa emblema di una rete organica, dove ogni movimento ha senso solo in relazione agli altri. È questa ambivalenza che rende la metafora così potente: in quel brulicare ansiogeno, c’è anche qualcosa di contemplativo, di ipnotico, perfino di rassicurante. Le formiche non parlano, non giudicano, non chiedono nulla, eppure costruiscono, cooperano, persistono a livello di gruppo nonostante tutto.
Nel romanzo, quindi, il formicaio non è né infernale né utopico: è una struttura che funziona senza padroni, senza slogan, senza obiettivi esterni, e in questo somiglia proprio alla colonia. L’identificazione delle formiche con i membri del gruppo non è totalizzante, ma suggerisce una possibilità di pensarsi parte di un tutto, senza perdere la propria singolarità. È anche una forma di resistenza: diventare minuscoli per sottrarsi allo sguardo degli altri, di chi non è in grado di capire.
La maledizione del leader
Può esistere un gruppo dove non emerga un leader? Forse no, ma anche in questo caso La colonia si discosta dallo stereotipo: tra le figure più enigmatiche del gruppo c'è Sara, la donna che sembra esercitare una forma di leadership silenziosa e in qualche modo rispettosa. Non dà ordini, non offre spiegazioni, eppure gli altri la seguono: l’hanno messa nella posizione di decidere per loro, glielo hanno chiesto come avevano fatto altre persone nel mondo che lei aveva abbandonato anche per questo. Emelie la osserva a lungo, cercando di capirne il ruolo, e scopre che la sua influenza non nasce dalla parola, ma dalla costanza dei gesti. Sara cucina, accende fuochi, cura gli altri. È la prima a svegliarsi e l’ultima ad addormentarsi. Non cerca il potere, anzi, in qualche modo sembra che per lei sia un peso: è carismatica suo malgrado e, sempre suo malgrado è una leader, proprio perché non vuole esserlo.
È interessante come Norlin costruisca questa figura femminile senza mai idealizzarla: Sara può essere brusca, schiva, perfino scostante, e in alcune pagine sembra quasi infastidita dalla presenza di Emelie, come se percepisse in lei una minaccia latente all’equilibrio precario della colonia. Ma proprio in questa imperfezione risiede la sua credibilità: Sara è una donna stanca, a tratti provata, senza una direzione da seguire o degli obiettivi che la caratterizzino, ma ancora capace di offrire agli altri quello di cui hanno bisogno. Non fonda la colonia, non la dirige: la abita. E, abitandola, la custodisce.
Né utopia, né distopia
Un altro elemento che rende La colonia così interessante è il suo rifiuto delle categorie assolute. Non è una distopia, ma nemmeno un’utopia: non c’è la denuncia furiosa del mondo capitalista, né l’esaltazione naïf della vita semplice, il bosco non è migliore della città ma è solo, in certi momenti, più sopportabile. Emelie non diventa una persona nuova, non guarisce, ma almeno impara a stare ferma, a convivere con il vuoto.
Il gruppo, a sua volta, non è esente da ombre. Non tutto è spiegabile, e alcune dinamiche restano volutamente opache, altre sono addirittura negative. Låke, vive l’esclusione dolente di chi non è fuggito, ma è nato nella colonia: per lui il mondo esterno non esiste, a volte danza da solo, a metri di distanza da tutti gli altri. La donna che sembra sua madre, anche se questo non sembra importare molto a nessuno, lo tratta con durezza, mentre i membri più anziani sembrano esercitare un’autorità silenziosa su di lui. Non si tratta di un’armonia perfetta, ma di una coesistenza con luci e ombre, e questo la rende più credibile, più viva.
Dal diario di Låke emerge una lingua infantile, piena di errori, ripetizioni, formule ma anche di stupore. È attraverso i suoi occhi che vediamo l’altra faccia della colonia, un luogo di protezione, sì, ma anche di esclusione. Lui vuole solo che qualcuno gli dica che è bravo, che qualcuno lo ascolti, che gli dia un ruolo, ma siccome non si è mai trovato a dover scappare da qualcosa non si è mai integrato del tutto in questo formicaio, è l’unico che non lo ha scelto.
Un romanzo sulla fuga silenziosa
La colonia è un romanzo sottile e spiazzante proprio perché non punta sulla sorpresa, ma sulla riflessione. Non spiega, non denuncia, non salva, si limita a mostrare con una scrittura piana e asciutta cosa succede quando si smette di credere che vivere significhi correre, produrre, ottimizzare. I personaggi non sono eroi né martiri, sono solo persone che hanno smesso di provarci, e nel loro quieto abbandono, nel loro ritiro silenzioso, si intravede una forma di pacata critica alla civiltà.
La colonia è un libro che parla del desiderio di sparire senza fare rumore, e, nella sua delicatezza, lascia un’impronta fortissima. Non racconta la fuga in un culto esoterico, ma la fuga da un culto anche più pervasivo, per quanto raramente sia riconosciuto come tale: quello della normalità produttiva e soverchiante, che non si preoccupa di lasciare indietro chi non ce la fa. Il fatto che tutto questo venga narrato senza clamore rende la lettura ancora più perturbante, perché ci suggerisce che, forse, chi ha scelto di stare nel bosco non è un pazzo né un illuso. Forse è solo qualcuno che ha trovato un modo per ribellarsi.