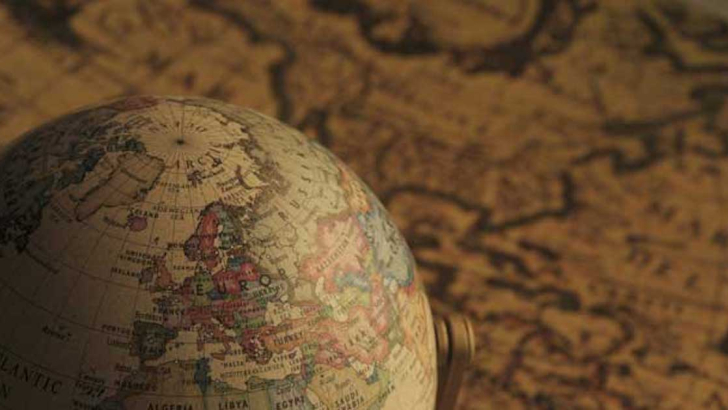La lontananza e la vicinanza delle isole, relative teorie ed esperienze

Foto di Asad Photo Maldives
Il modo in cui i sapiens si sono adattati a vivere bene su isole meriterebbe un’autonoma ricostruzione antropologica. I caratteri e le forme dell’occupazione degli spazi insulari circondati da acque e lontani dalla terraferma sono in parte addirittura paralleli e connessi con quelli e quelle relativi agli spazi terrestri più lontani dal mare. Tuttavia, su un’isola si risiede con innegabili specificità: da come ci si protegge, e da quali eventi meteorologici e geologici, a come e cosa si caccia e si mangia o, poi, si coltiva e si alleva, da come si delimita il territorio a come, poi, lo si protegge da altre specie o da altri umani che lo minacciano, dai modi e luoghi di attracco e, poi, arrivo a quelli di eventuale dipartita. Anche rispetto alla conservazione della scelta d’isolamento non c’è solo l’isolamento detentivo con l’esilio o in una “prigione” (autoimposti o imposti ad altri). Vi sono l’isolamento dei malati nel corpo e nella psiche, dei contagiati contagiosi e dei moribondi, degli eremiti e delle comunità religiose. E, ogni volta, tutto il personale umano connesso a queste attività, almeno alla partenza, con relativi nomi e carte, porti e imbarcazioni, fari e fortificazioni, miti e utopie.
L’isola può essere più o meno vicina o lontana, concetti comunque relativi. La biogeografia insulare data poco più di sessanta anni, visto che se ne fa coincidere l’inizio con la pubblicazione di un noto saggio degli americani Robert MacArthur e Edward Wilson del 1967, basato su molte ricerche empiriche e che gli studi successivi hanno in buona misura confermato. Secondo i due illustri studiosi, in sostanza, il numero di specie presenti su un’isola (o su altri habitat “isolati”) è inversamente proporzionale alla distanza dall’area sorgente, il continente (o la barriera), e direttamente proporzionale alla dimensione, oltre che variamente connessa, come ogni altro luogo terrestre, a latitudine, longitudine e altitudine. Sulla base di questa intuizione è stato proposto un vero e proprio modello interpretativo, con l’ausilio della matematica e della geometria. Nel corso dei decenni la materia risulta sempre più approfondita, con integrazioni e correzioni alla teoria. Quel che sembra abbastanza confermato è che il tasso di estinzione diminuisce al crescere della superficie; il tasso di colonizzazione diminuisce al crescere del grado di isolamento dell’isola; il tasso di speciazione aumenta in proporzione alla superficie dell’isola e alla lontananza dai continenti.

In realtà, le peculiarità biologiche ed evoluzionistiche delle isole erano state in parte già evidenziate dai primi naturalisti nel periodo dei grandi viaggi di esplorazione. La teoria dell’evoluzione, poi, nacque con Darwin e Wallace proprio a seguito di osservazioni fatte su isole e arcipelaghi: vi abbiamo già accennato in precedenza.
Puoi leggere anche:
Noi talora abitiamo le isole con la mente e con il corpo, ma cos’è un’isola?
Le isole, laboratorio per cambiamenti climatici antichi e moderni
Altro aspetto interessante e che merita di essere approfondito appare la migrabilità delle specie e dei luoghi, in relazione all’evoluzione della vita e alla capacità di movimento. Come detto, fisicamente l’isola è una terra emersa interamente circondata dall’acqua e può trovarsi nelle acque sempre interconnesse di un fiume, di un lago, di un mare o dell’oceano. In realtà, anche le grandi masse continentali, se le osserviamo da lontano in modo da poterne percepire l’intera superficie, ci appaiono come grandi isole circondate dall’oceano. Per limitare la relatività nella comparazione di caratteri e grandezze delle isole risulta utile verificare le attuali definizioni del diritto internazionale.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) è stata definita con un lungo processo di negoziazione attraverso una serie di Conferenze delle Nazioni Unite cominciate nel 1973 ed è stata finalmente aperta alla firma a Montego Bay, in Giamaica, il 10 dicembre 1982. Nel corso dei vari incontri fu proposto di considerare l’isola come un territorio continentale quando la sua estensione superava il 10 per cento del territorio oppure il 10 per cento della popolazione del continente di riferimento. Furono dunque introdotte percentuali e scale quantitative per classificare ed elencare isole. Furono prese in considerazione anche lontananza e vicinanza: un’altra ipotesi fu quella di determinare una distanza minima dalla costa per distinguere i due regimi giuridici. Queste indicazioni rimasero, peraltro, a livello teorico e, dopo la conferenza di Montego Bay, solo gli scogli non adatti a stanziamenti umani permanenti o all’espletamento di attività economiche non sono tenuti in conto ai fini della delimitazione del mare territoriale.
“ La percezione dell’isola e dell’isolamento sono dunque, almeno in parte, soggettive e relative
Perché esista un’isola certo serve una terraferma cui contrapporla: il “continente”, come gli isolani chiamano l’Italia peninsulare o come i britannici chiamano l’Europa continentale. Anche gli abitanti delle isole del Re, delle isole Furneaux e di altre isolette si riferiscono alla Tasmania come mainland (continente, terraferma). Tuttavia la Tasmania è essa stessa un’isola, sebbene molto più grande, e i suoi abitanti intendono per mainland l’Australia, a sua volta isola. L’isola quindi può essere considerata tale in quanto esiste nelle vicinanze una terra emersa più grande che ne costituisce la controparte “continentale”. Ne consegue che, non avendo i grandi blocchi continentali una “terraferma” con cui confrontarsi, essi sono senza dubbio continenti e non isole.
La vita parallela e biodiversa di continenti e isole marine percorre l’intera evoluzione umana: la fisicità e le percezioni di un’isola sono mutate nel tempo. Inoltre, la comparazione dovrebbe riguardare progressi e fenomeni del popolamento umano: l’arrivo diacronico nei vari continenti e nelle varie isole marine a partire dall’origine africana; la crescita, pur non lineare, della popolazione nei vari ecosistemi e sul pianeta; le migrazioni e il meticciato sempre intensi, ovvero le migrazioni prevalenti verso talune latitudini interne ed esterne ai continenti e alle isole marine, più libere verso terre fertili o coste, valli, città e metropoli, più forzate come fuga, esilio, esodo, deportazione, diaspora o detenzione lungo i tragitti; l’esistenza e la disponibilità di differenti tecniche di trasporto e di strumenti tecnologici di comunicazione di massa. Il sentirsi isolati su una piccola isola non è un sentimento umano immutabile, nemmeno quando si aggiunge la detenzione. Quel che più conta a livello teorico e pratico è l’allontanamento, il distacco, la separazione fisica che andare su un’isola o andar via da un’isola determina rispetto a quello specifico ecosistema (insulare).
In un volume sulle isole carcere di tutti i tempi (sapiens) e di tutti i luoghi del mondo, mi è capitato di proporre una classificazione mirata, sia sulla grandezza che sulla distanza.
Puoi leggere anche: La storia delle "Isole Carcere" in un libro: da culla di biodiversità a luoghi di confino per i sapiens
Ho inserito nell’elenco globale (almeno duecentosettanta) solo quelle non troppo grandi e, fra le più grandi, solo pochissime, quelle molto distanti dalla terraferma di riferimento (per quanto sia discutibile indicare valori assoluti validi in ogni epoca e in ogni luogo). All’inizio del terzo millennio si può ipotizzare una dimensione oltre la quale l’elemento di isolamento (anche detentivo) perde importanza assoluta: la Sicilia è un’isola circondata da tante (meravigliose) isole, tuttavia al proprio interno ha svariati ecosistemi, costieri e interni, collinari e montani, assolati e ombrosi, isolati e metropolitani; luoghi diversamente accessibili, più e meno; tanta terra molto lontana dalle acque marine. Inoltre, se per migliaia di anni la distanza ha fatto grande differenza, ormai è un dato certificato eppure relativo. Da decenni voliamo rapidamente da un aeroporto all’altro, a centinaia o migliaia di chilometri. Nei millenni, fino ai percorsi intercontinentali delle grandi navi, quasi ogni isola oceanica sembrava molto lontana e di “uso” disagevole; dopo l’introduzione del motore a bordo vi è stato un ulteriore salto di qualità in ogni bacino o mare o lago del pianeta; ancor più le cose sono cambiate quando gli aerei si sono aggiunti alle navi, garantendo tempi molto più brevi per i trasferimenti dei passeggeri, turisti, lavoratori, carcerieri, prigionieri che fossero; anche per chi ci vive o ci capita pesa che talora sia comunque impossibile fuggirne (per la forza “contraria” del mare soprattutto).
“ Poi ci sono sempre state e restano rilevanti molte isole ancora lontanissime, alla fine del (nostro) mondo
Puntini, capocchie di spillo, atomi geografici, ecosistemi sperduti. Alcune isole sparse nella vastità degli oceani rappresentano, forse, l’ultima frontiera dell’avventura. Inaccessibili e dimenticate dalle rotte principali, rimangono fuori dai radar della vita quotidiana. Luoghi lontani da tutto e spesso immersi in un clima ostile; francobolli sulla superficie dell’enorme interconnesso bacino oceanico, di acque e di mari che, per essere raggiunti, a volte necessitano ancora di giorni di viaggio in nave. Probabilmente sono irrilevanti nel contesto socioeconomico mondiale, tuttavia pensiamoli come microcosmi, specchi che riflettono sfide globali: il cambiamento climatico, i conflitti geopolitici, la conservazione della biodiversità, e anche la sopravvivenza delle culture umane in condizioni estreme come metafora dell’intera esistenza sapiens.
Il viaggio verso le isole e il concetto di insularità hanno da sempre esercitato un fascino particolare su scrittori, filosofi e pensatori, intrecciandosi con temi che spaziano dall’isolamento alla scoperta, dall’utopia alla riflessione esistenziale; una molteplicità di significati che variano a seconda delle epoche storiche e delle dinamiche sociali; da un lato una separazione dal mondo ordinario, dall’altro un luogo privilegiato per la sperimentazione, l’introspezione e la creazione di nuove narrazioni. Le isole occupano un posto centrale nella mitologia e nella letteratura, innanzitutto greca e romana. Il Rinascimento ha poi spostato l’accento dalla dimensione simbolica a quella filosofica. Successivamente, le letterature nazionali e l’antropologia hanno ampliato la dimensione epica e lirica con ulteriori consapevolezze identitarie e scientifiche, mantenendole uno dei simboli più potenti e versatili del nostro immaginario culturale.
Recentemente è uscito un interessante volume che parla di molte di loro: Marco Lupis, Ai confini del mondo. Storie da isole lontane (Il Mulino Bologna 2025). L’esperto giornalista Marco Lupis (Roma, 1960) è stato per oltre trent’anni inviato di guerra, fra l’altro a lungo corrispondente da Hong Kong per la Rai e per le maggiori testate italiane. Raccoglie ora in questo vivace curioso volume i resoconti dei suoi viaggi in alcune delle isole più remote, combinando narrazione giornalistica, approfondimenti di personaggi e vicende storiche, descrizioni evoluzionistiche e paesaggistiche, sempre accanto ad acute esperienziali riflessioni personali, ben “oltre le carte geografiche”. Ovviamente non si parla del nostro piccolo mar Mediterraneo, mai “remoto”, confine liquido di continenti, migrazioni, civiltà, religioni, commerci. Correttamente l’autore distribuisce isole e arcipelaghi in quattro parti quasi ai confini del mondo (da cui il titolo).
La prima parte riguarda il Pacifico infinito: Le Curili; Sachalin; Le Marchesi; Pitcairn; Nauru; Mindanao; Le Figi (e le Salomone); Le Molucche. La seconda parte narra gli Abissi dell’Atlantico: Tristan de Cuhna; Ascension Island; Sant’Elena; Trindade; Machias Seal Island. La terza parte affronta alcuni Margini dell’Africa: Socotra; Le Comore e Mayotte; le isole Sparse; Timor. Infine la quarta parte accenna a Terre di Giacchio e Fuoco, al cosiddetto Sesto Continente: Deception Island, Pelagosa (epilogo). Nell’insieme abbiamo diciannove intensi godibili capitoli prima dell’utile indice dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli. Frequenti i riferimenti alla schiavitù coloniale e alle migrazioni forzate, verso e da quelle isole e quegli arcipelaghi; più sporadici i cenni alle funzioni pure terribilmente detentive di alcuni di quegli ecosistemi insulari.