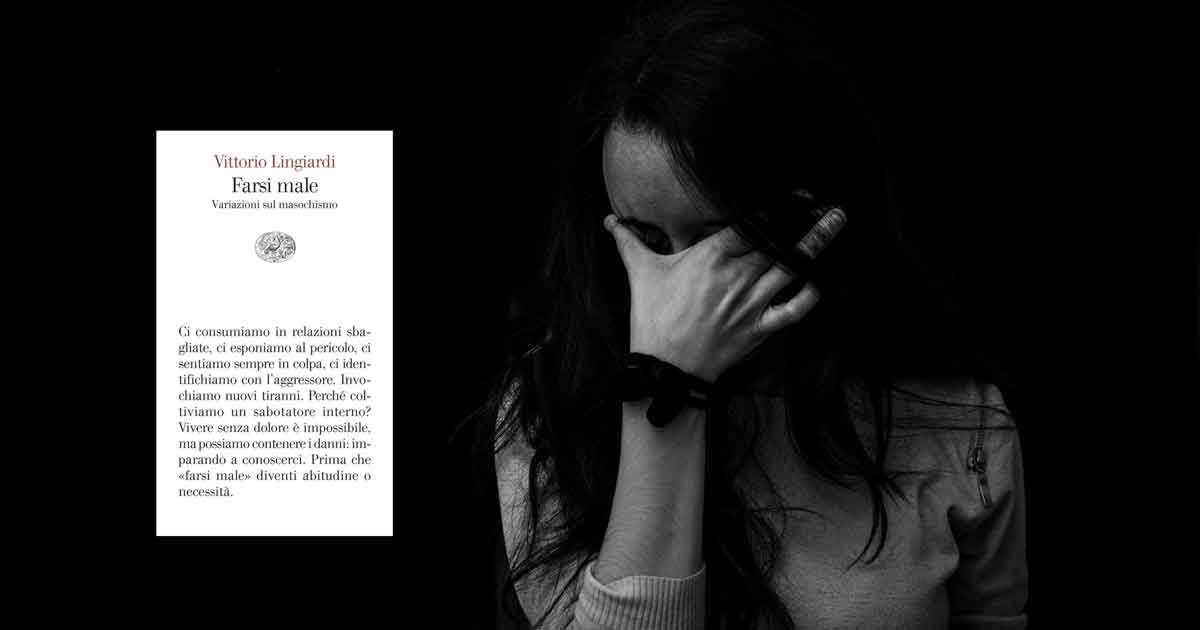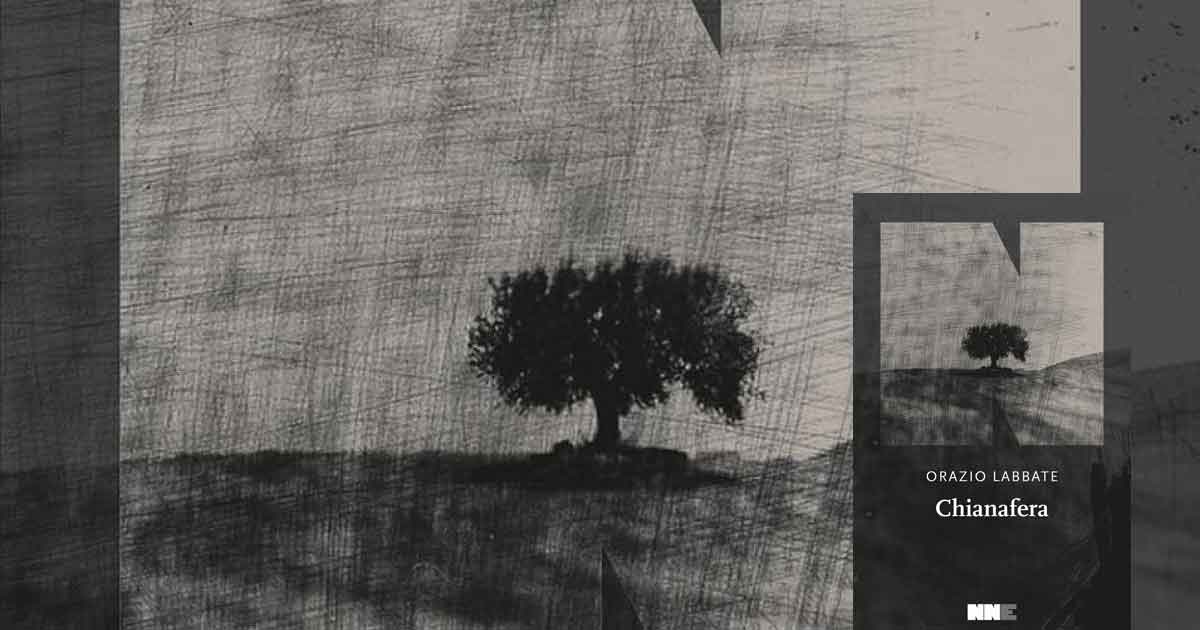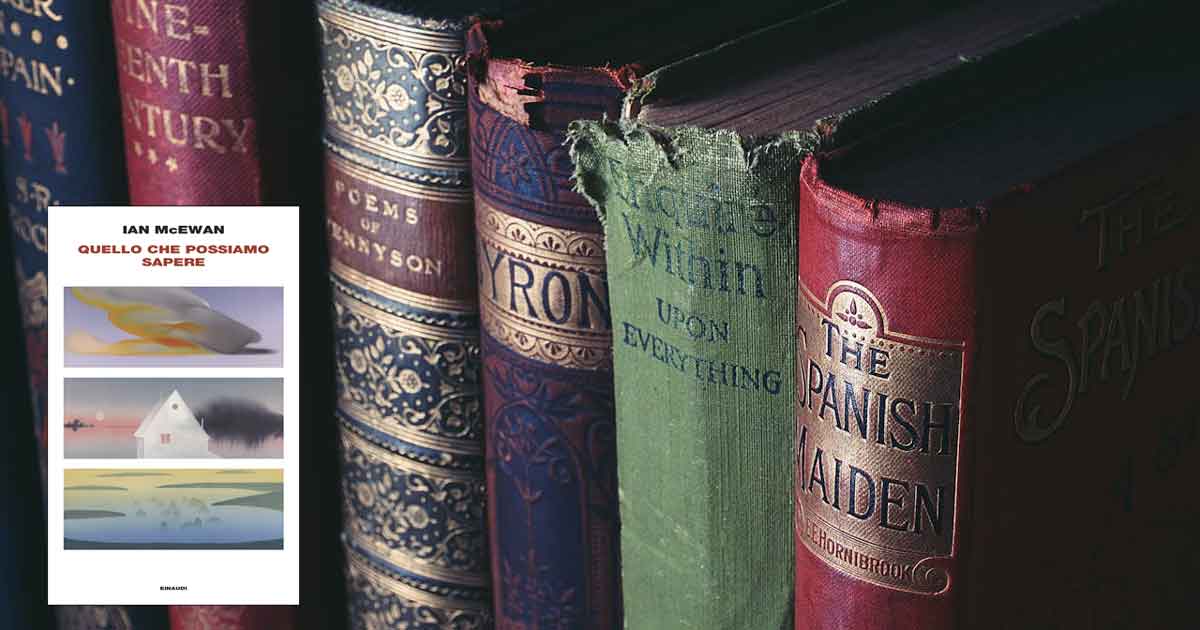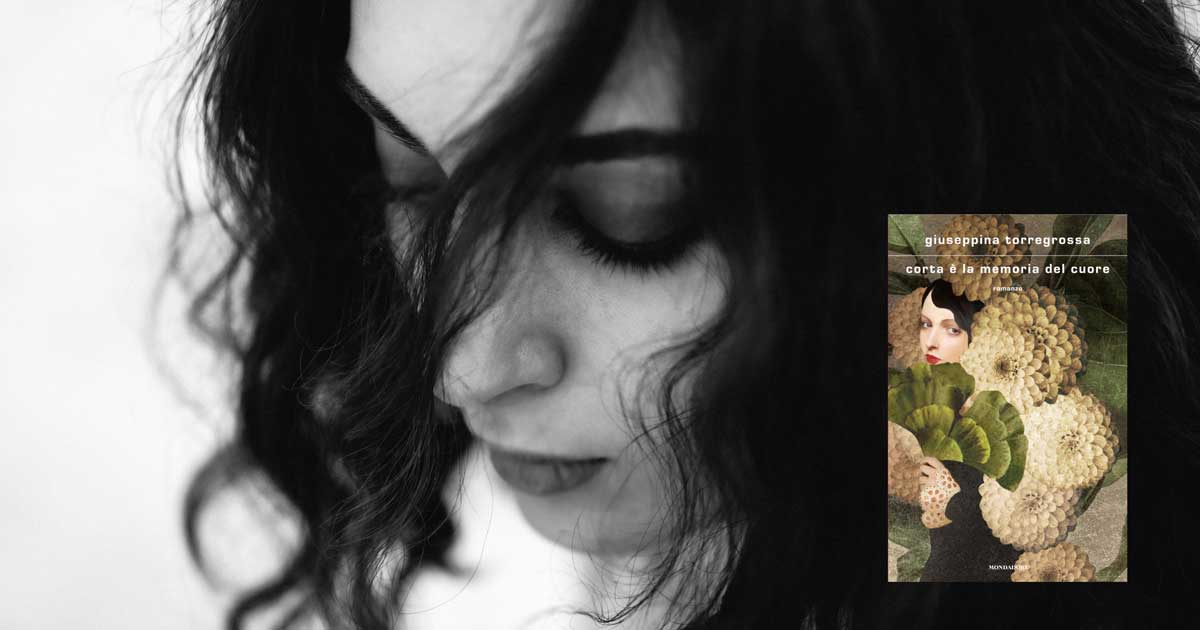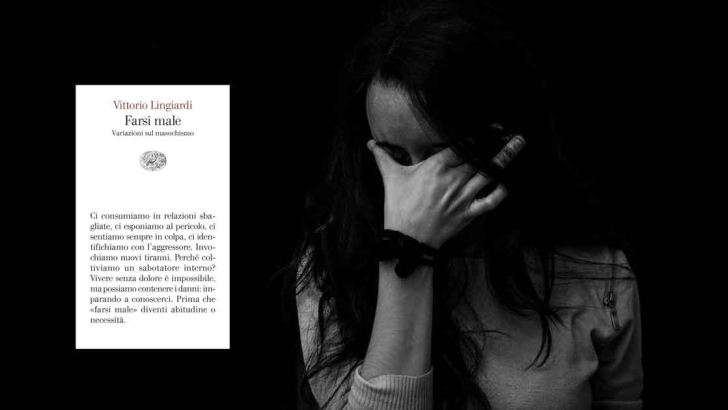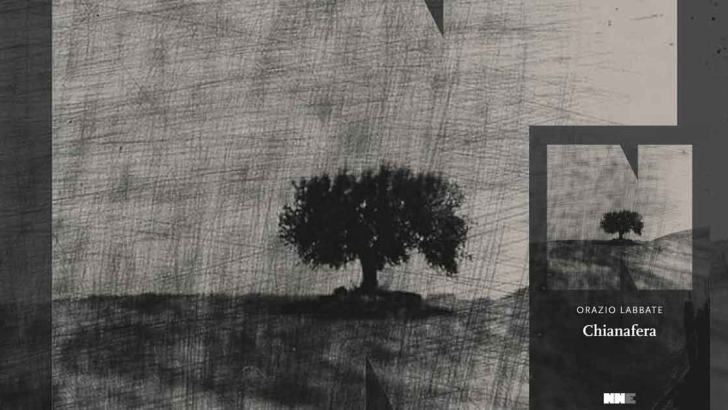Sullo Scaffale: Scelgo tutto di Valerio Mieli

Immaginiamo di fare il gioco dei se. Cosa sarebbe successo se quella volta invece di restare fossi andato? Se non mi fossi innamorato di lei? Se l’avessi lasciata invece di restarci insieme? Se avessi ascoltato quella voce che mi suggeriva di non avere figli? Se mi fossi permesso di essere più indulgente con me stesso?
Ecco: Valerio Mieli, noto per la regia di Dieci inverni, film diventato di culto con il passaparola, fa esattamente questo nel suo nuovo romanzo uscito da poco per La nave di Teseo. Il titolo è provocatorio: Scelgo tutto, e infatti allude al desiderio di vivere ogni possibile esperienza ma anche, insieme, alla capacità di accettare tutto quello che ci capita, come a dire: tutto quel che mi accade, io lo scelgo.
La storia – anzi le storie – sono quelle di Cosimo, poco più che ventenne, che lascia la sua bella, e, ascoltando un consiglio ricevuto una sera, si trasferisce a Parigi; e di Cosimo che invece resta a casa, insieme a Sabina. E di tutto ciò che poi ne consegue.
Sono strade apparentemente divergenti quelle che si snodano sotto i nostri occhi, ma i personaggi, gli accadimenti, le dimensioni esistenziali ritornano, si incastrano, si dispongono in modo chiastico oppure agli antipodi, solo a volte sono allineate.
E nella “vita aggiuntiva” di Cosimo, che non si sa quale delle due sia (e potrebbero essere anche tre, cinque, infinite) succede quello che succede in ogni vita. Gioie, fallimenti, insuccessi, malattie, figli, case, separazioni, matrimoni, liti, riappacificazioni si mescolano e solleticano il lettore a chiedersi cosa abbia influito su cosa, se ci sia una direttrice rintracciabile, se nell’universo valga un qualche principio di causa-effetto, se sia possibile immaginare una convergenza di eventi solo perché noi siamo noi, come se il destino lo portassimo scritto nel DNA.
E infatti a volte Mieli ci spinge a pensare che: “Noi non decidiamo niente di niente! Siamo come spettatori al cinema!” ma anche che: “Ve bene, non decidiamo niente. La libertà è tutta illusione. Siamo come spettatori al cinema. E allora? Che male c’è? Il cinema ci piace a tutti, no?”
Fino a quando non ci rendiamo conto di qualcosa di incredibilmente liberatorio, che ci scagiona da ogni tentativo di preconizzare il futuro e, insieme, di tornare ossessivamente su ciò che è stato e magari sarebbe potuto essere diverso: “L’incertezza del domani è una febbre dolcissima”.
Abbiamo intervistato Valerio Mieli.
Lo sliding door è qualcosa che ci affascina perché ci permette di pensare alle “vite possibili”: ci fa chiedere cosa sarebbe successo se, e poi se, e ancora se. Ma in letteratura (come nel tuo romanzo) questo “gioco” cosa diventa? Cosa ti ha permesso di scoprire?
Mi ha permesso di trovare una qualche risposta a dei rovelli esistenziali miei, ma anche molto comuni. Una risposta che non si riassume, purtroppo, in una sola frase, del tipo: “Tranquilli, qualunque scelta porta allo stesso risultato, saremo noi stessi sempre e comunque” oppure: “I legami sono sempre più importanti dell’avventura, dell’ambizione”, o, ancora: “Esiste/non esiste il destino” ecc. A fatti simili che capitano alle due “versioni” di Cosimo, talvolta entrambi reagiscono allo stesso modo. Talvolta no. Talvolta va bene comunque, sia che Cosimo abbia scelto A sia che abbia scelto B. Talvolta no. Io non sapevo la risposta prima di scrivere: sono stati risultati, per così dire, sperimentali (e di questo sono molto contento). Perciò era così importante, per me, che i personaggi fossero credibili. Era imprescindibile conoscerli in tutte le loro sfaccettature, nei loro cambiamenti e anche nell’ulteriore dimensione della possibilità. Quella che invece a noi – che abbiamo una vita sola – non è data.
Il conflitto, il destino, la possibilità di esercitare una scelta (il libero arbitrio in definitiva!) sono tutti temi che fortemente innervano questo tuo lavoro: c’è stato un episodio specifico della tua vita che ti ha portato a interrogarti su questi aspetti?
Un episodio particolare non direi. Però la domanda “come vivere?” è stata centrale per me da quando mi ricordo di essermi posto domande. Ho studiato filosofia, in definitiva, per trovare una qualche forma di risposta, e poi ho continuato con altri mezzi che mi sembrano in grado di soddisfarmi di più. Perché quella che cercavo – che cerco – è una risposta articolata, sfumata, anche contraddittoria. Se non sento che in qualche modo una storia o un progetto mi avvicinano a questa ricerca di senso, presto o tardi abbandono.
Sei romanziere, regista e anche sceneggi. Sono mestieri tangenti ma diversi. Quali sono le caratteristiche dell’uno o dell’altro che tu ritieni imprescindibili per la tua espressione artistica?
Sono mestieri molto diversi nella quotidianità: nello stile di vita che producono. Ma quello che cerco ha sempre lo stesso indirizzo, anche con la fotografia o il poco teatro che ho fatto. Cerco di usare l’emozione per esplorare le questioni esistenziali. Forse nella filosofia mi mancava l’emozione: avevo bisogno di calore, oltre che di verità, di storie che mi avvincessero per i conflitti emotivi che raccontano per poter capire. Emozione e onestà intellettuale non sono per forza in conflitto, anche se spesso è difficile farle coesistere.
Poi, fare il regista è molto più divertente. Più facile, anche, per me almeno. Si parte da qualcosa e lo si deve rendere al meglio. Scrivere, che sia per il cinema o un romanzo, significa passare dal nulla a qualcosa. Significa spremere, spremere ancora. Spesso quello che esce, dopo tutto quello sfiancante spremere, si rivela inutile. È vago. È furbo. O è utile, è onesto, ma è brutto. O è divertente ma falso. È preciso ma è noioso. È emozionante ma non è quello che vuoi dire. È quello che vuoi dire, ma suona trombone. Insomma, un bel cubo di Rubik. Invece il set è un grande circo. Se a guidarmi fosse il piacere, farei solo quello. Ma purtroppo sono convinto che il vero lavoro – il vero dovere – sia quello che si fa a monte del set. E poi, per ricompensa, si esce di casa e si va a “giocare in compagnia”.
Avere un grande successo con un’opera prima (penso al film Dieci inverni – che nasceva da un tuo romanzo) come influenza (se le influenza) le scritture successive?
Non direi che Dieci inverni ha avuto un grande successo. È più una percezione di oggi. È nato come il saggio di diploma al Centro Sperimentale, non doveva neanche uscire. Ci sono voluti molti anni perché in tanti lo vedessero. Anche per Ricordi? ricevo più messaggi di complimenti oggi di quando è uscito. Credo dipenda dal fatto che sono film andati avanti per passaparola. Hanno resistito e sono cresciuti malgrado fossero piccole uscite. Quando ho fatto Dieci inverni non avevo nessun’esperienza del mondo del cinema. Mi ci è voluto del tempo per capire come funzionasse. Oggi sono più consapevole e ho anche più forza di quanto ne avessi allora. Ma guardando indietro direi – per ritornare alle vite possibili – che è andata bene. E soprattutto un’altra vita, nella realtà, non esiste.
“ L’incertezza del domani è una febbre dolcissima Valerio Mieli