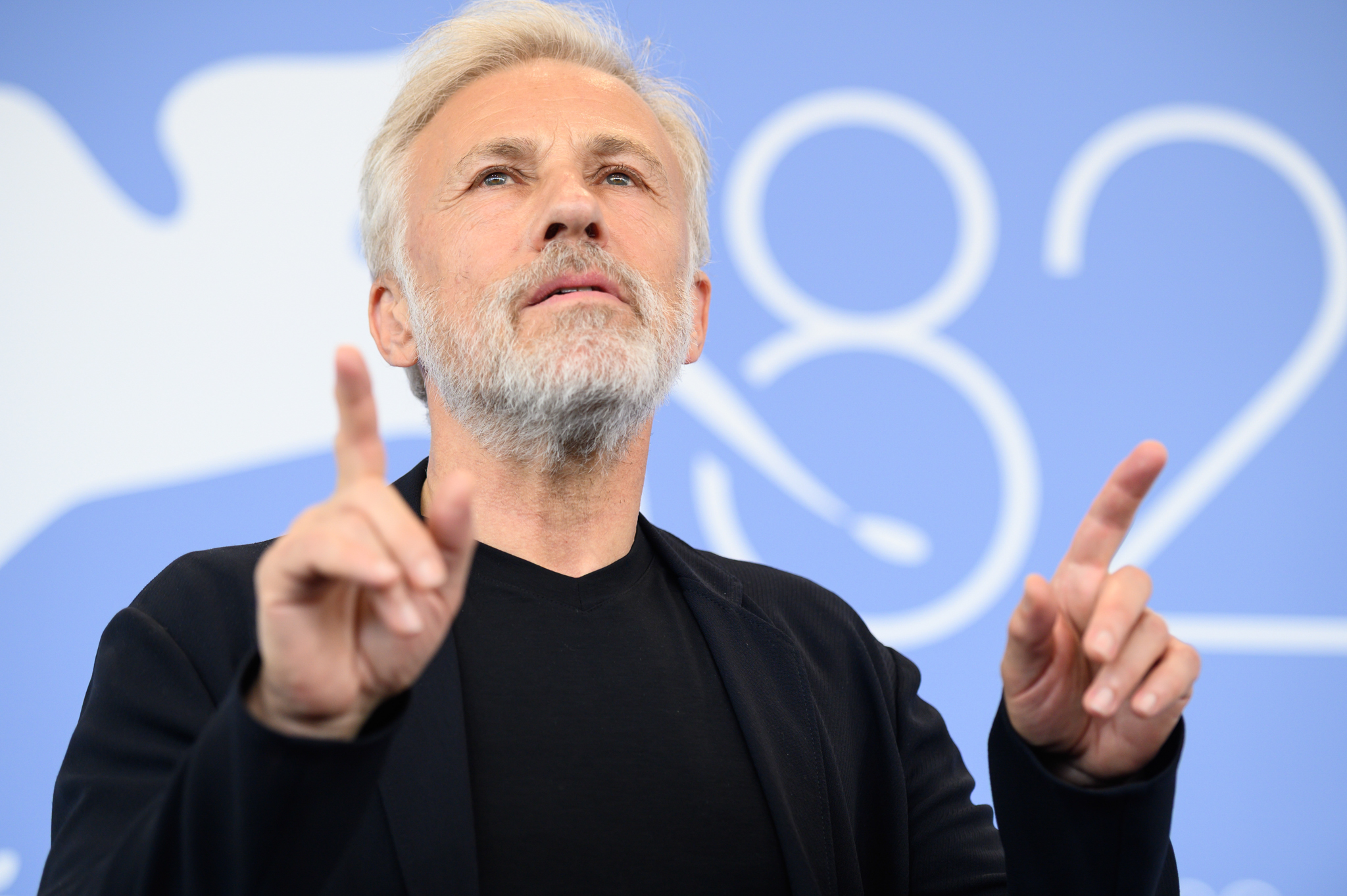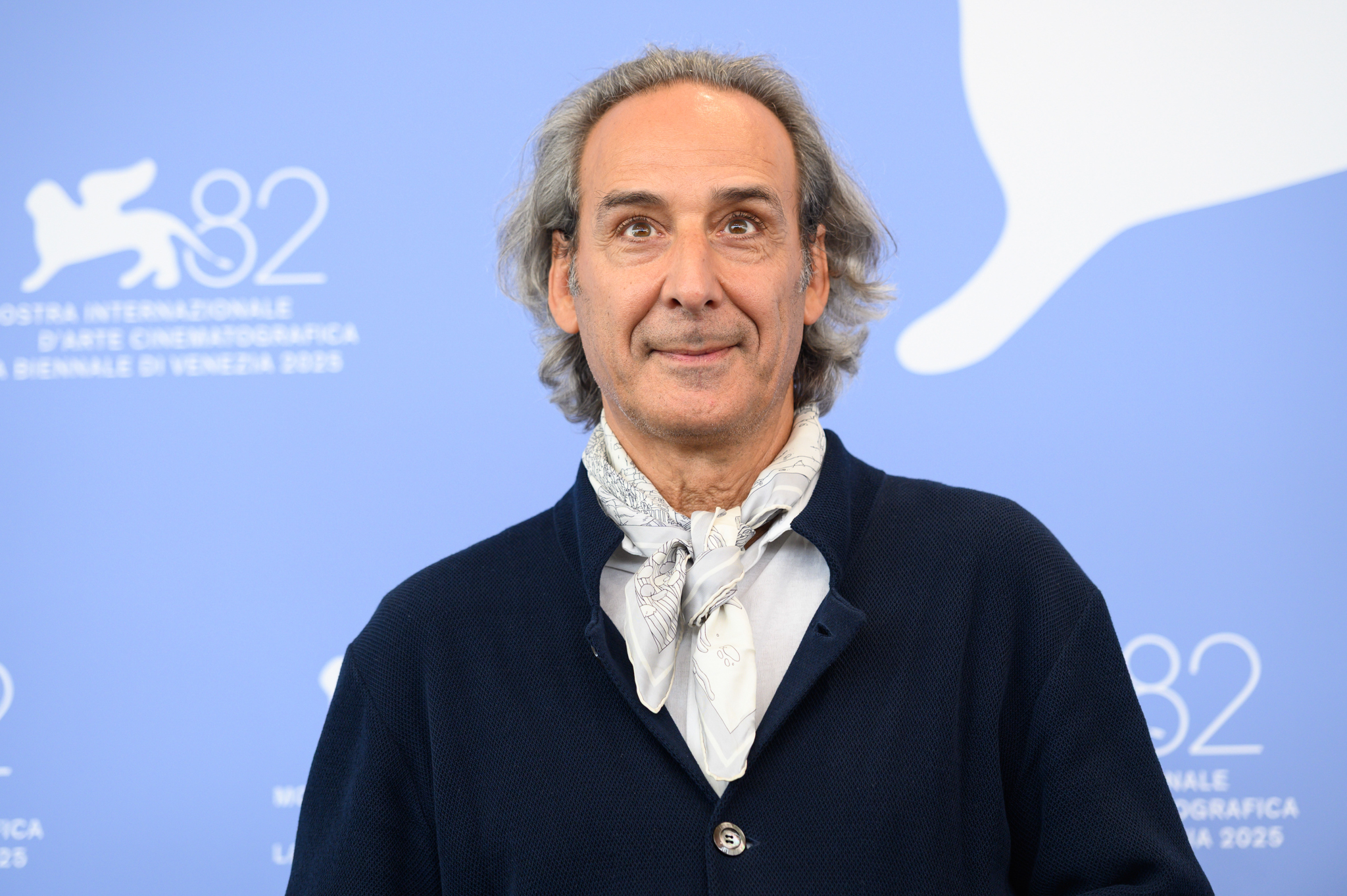Venezia 82: Frankenstein, un Prometeo per l’era dell’intelligenza artificiale

Il mito di Frankenstein torna sul grande schermo, e lo fa in grande stile: Frankenstein di Guillermo del Toro è uno dei titoli in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista messicano, che da sempre considera il mostro di Mary Shelley una sorta di santo patrono personale, porta al Lido il progetto che ha dichiarato di inseguire da una vita.
Una sceneggiatura conservativa
Sia chiaro: chi vuole andare a vedere questo film non deve farlo per la creatività della sceneggiatura, molto fedele all’originale e agli altri film che hanno già portato il libro sullo schermo: Victor rimane l’apprendista demiurgo, la Creatura resta il figlio rifiutato che reclama amore, l’inevitabile collisione tra padre e figlio è sempre il cuore della vicenda.
E qui arriva subito un elemento che lascia qualche perplessità. Spesso, quando un film decide di alternare più punti di vista, lo fa perché i personaggi hanno due versioni inconciliabili della stessa storia. In Frankenstein, invece, Victor e la Creatura si raccontano in due traiettorie davvero diverse, che si muovono in parallelo ma non si specchiano. È un’alternanza che rischia di urtare un po’, soprattutto considerata la durata del film.
Un’ambientazione diversa
L’unica novità è lo spostamento dell’ambientazione durante la guerra di Crimea, uno scenario che può aggiungere nuove suggestioni visive, che sono il punto di forza del cinema di del Toro. Ma al di là di questo contorno, la dinamica resta immutata e non cambiano la struttura e i ruoli archetipici: il mito non si reinventa, Del Toro lo sa bene: non è con lo script che vuole sorprendere gli spettatori, ma con le immagini e gli spazi che assumono la centralità di veri e propri personaggi.
Un mito antico che parla il linguaggio dell’AI
Il romanzo di Mary Shelley aveva già nel 1818 un sottotitolo programmatico: Il moderno Prometeo. La creatura di Frankenstein era il simbolo dell’hybris demiurgica, della sfida scientifica a Dio, del rischio di voler creare la vita senza essere pronti ad assumersene le conseguenze, come padri irresponsabili. Da allora, ogni adattamento ha associato quel mito alle paure e alle ossessioni del proprio tempo: l’elettricità, il progresso medico, l’ingegneria genetica.
Il film di Guillermo del Toro, pur restando fedelissimo alla trama classica, trova la sua attualità in una domanda che oggi ci perseguita più che mai: cos’è umano e cos’è artificiale? La Creatura che balbetta il nome del creatore e impara a muoversi nel mondo non è molto diversa da un’intelligenza artificiale che cresce per tentativi, assimilando input senza comprenderne davvero il senso.
Il mostro e gli algoritmi
E che cos’è il mostro se non un corpo patchwork che funziona come un algoritmo addestrato su frammenti di vite passate? È un essere che non ha memoria personale, ed è proprio qui che Frankenstein diventa attuale, nell’interrogarsi su chi è responsabile delle azioni di una creatura artificiale. Il creatore che l’ha costruita? O l’essere che, una volta nato, agisce di propria volontà? Che cosa significa “pensare”, e cos’è il ragionamento (questa domanda viene fatta esplicitamente)?
In questo senso il film non ha bisogno di cambiare la storia per sembrare nuovo: è il nostro sguardo a renderlo diverso. Nel 2024 il mito di Shelley ci parla dell’intelligenza artificiale con la stessa urgenza con cui due secoli fa parlava dell’elettricità. E la Creatura di del Toro diventa il nostro specchio: fragile e violenta, innocente e colpevole, assetata d’amore e incapace di riceverlo. Un algoritmo in carne e ossa, che chiede la cosa più umana che ci sia: essere riconosciuto
Ogni scena è un quadro
Se la sceneggiatura non osa, la fotografia e la scenografia spingono invece fino al limite. È qui che Frankenstein diventa l’opera totale di Guillermo del Toro.
La fotografia di Dan Laustsen, già al fianco del regista in La forma dell’acqua (vincitore del Leone d’Oro del 2017 e poi dell’Oscar) e Crimson Peak, lavora su contrasti estremi: neri profondissimi, luci che esplodono in bagliori quasi pittorici, tavolozze che oscillano tra ambra e ciano con improvvisi squarci di rosso. Ogni inquadratura sembra costruita come un dipinto romantico: il paesaggio diventa teatro, i volti sono scolpiti come figure barocche, i movimenti di macchina accompagnano la sensazione che lo spazio stesso respiri.
É la scenografia di Tamara Deverell a dare al film la sua imponenza fisica. Niente fondali digitali, visti ultimamente fin troppo spesso, ma set monumentali e tangibili: il laboratorio ricavato in una torre idrica a più piani, con la sua enorme finestra circolare come simbolo dell’eterno ritorno vita–morte; la nave montata su un gimbal meccanico, che oscilla realmente con gli attori a bordo; le dimore storiche usate per ricreare la casa dei Frankenstein, spazi che ricordano la grandeur di Barry Lyndon ma attraversati da un oscuro senso di rovina: tutto rende l’estetica del film un piccolo gioiello.
Un film che merita la sala
Chi scrive non è una purista della sala cinematografica, ma una scenografia del genere chiede di essere vista lì, sul grande schermo, perché su Netflix (dove uscirà il 7 novembre) rischierebbe di ridursi a sterile sfondo decorativo. I gradienti di colore, le texture delle superfici, la profondità dei neri non sopravvivono a uno schermo piccolo: vanno respirati nel buio della sala, dove ogni dettaglio prende vita.
Jacob Elordi, che interpreta la Creatura, lo ha detto chiaramente: non è un film da guardare distrattamente, ma un’esperienza immersiva, e ha ragione. Frankenstein non si guarda, si attraversa: è architettura, luce e materia che diventano narrazione.
Crimson Peak sotto steroidi
Chi ha amato Crimson Peak riconoscerà subito il tocco di Guillermo del Toro, ma noterà anche quanto il regista abbia spinto più in là la sua estetica. Se nel film del 2015 la casa era il personaggio principale, un organismo che sanguinava argilla rossa dalle pareti, con scale che si aprivano come ferite e corridoi che inghiottivano i protagonisti, in Frankenstein la scenografia è quasi ingegnerizzata.
Il laboratorio di Victor, ricavato da una torre idrica, è una vera cattedrale meccanica: piani su piani collegati da scale a chiocciola, tubature che pulsano come vene, e al centro una finestra circolare che richiama l’uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo di vita e morte intrecciate. Ogni spazio, compresa la nave dove viene raccontata la storia, diventa un congegno, un ingranaggio che ingloba i corpi e li costringe a muoversi al suo ritmo.
Eppure, al di là delle differenze estetiche, la radice resta la stessa: la convinzione che l’architettura non faccia da sfondo, ma sia drammaturgia vera e propria. In Crimson Peak la casa ammalata divorava i personaggi dall’interno; in Frankenstein è il mondo intero a sanguinare, dai campi di battaglia della Crimea al laboratorio-cattedrale.
Un mito invecchiato bene
Alla fine, si potrebbe accusare questo Frankenstein di non dire nulla di nuovo. La storia è quella di sempre, i ruoli sono immutati, e lo spostamento storico serve più a vestire i personaggi che a cambiare il senso del tutto. Ma il punto è proprio questo: non serviva cambiare la trama, serviva cambiare lo sguardo: è un gotico ingegnerizzato, monumentale e commovente, che ci ricorda che la domanda resta sempre la stessa: cosa vuol dire essere umani, e chi è il vero mostro?