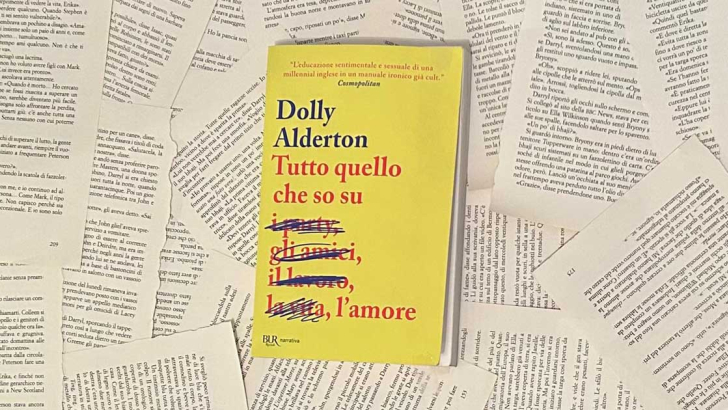Paolo Malaguti in un ritratto di Caterina Santinello
Paolo Malaguti vince la dodicesima edizione del Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi con il romanzo Il Moro della cima uscito lo scorso marzo per Einaudi.
Una vittoria praticamente annunciata, non solo per l’indiscutibile valore letterario del testo ma soprattutto perché Malaguti (già selezionato nella long list nel 2019 con Lungo la pedemontana), affezionato “cantore rigoniano” nelle forme e nei temi, con questa ultima fatica si avvicina indicibilmente alla sensibilità dello scrittore asiaghese.
Il Moro, infatti, in qualche modo ricorda quel Tönle Bintarn di cui Rigoni Stern racconta la storia nell’omonimo romanzo (vincitore peraltro del Bagutta e del Campiello nel 1979): entrambi affezionati alla montagna, entrambi incapaci di staccarsene, entrambi disincantati eppure colmi di un lirismo primitivo, hanno vissuto l’esperienza della Grande guerra (il Moro relativamente da giovane, Tönle ormai ottantenne) e, toccandone la potenza distruttrice, l'hanno affrontata.
Ma Malaguti del grande maestro, insuperato narratore della montagna e dei luoghi interiori dove essa ci conduce, ha soprattutto l’autenticità. In un periodo in cui, dalle Otto montagne di Paolo Cognetti in poi (libro che fu venduto in pressoché tutto il mondo, oltre ad aver vinto lo Strega nel 2017), molti, moltissimi si sono cimentati nella scrittura di romanzi “di montagna” perché sostanzialmente diventava una moda, Malaguti resta fedele alla sua ricerca letteraria, quella di una “letteratura buona” che non sciocca per colpire, che non si adagia sull’immagine retorica ma, anzi, restituisce la genuinità – spesso ironica, schietta, e senza troppi filtri – di un mondo che paradossalmente, in tempi di turismo di massa, è quasi inaccessibile nella sua veracità.
Ma chi è il Moro?
Persona realmente esistita di nome Agostino Faccin (1866-1951) è stato uno dei primi conduttori di rifugio ma Malaguti nel suo romanzo ne fa uno specchio in carne e ossa dei tormenti (e delle gioie) dell’animo umano. Così lo descrive: “Al mattino, quando si alzava per preparare la colazione agli ospiti [del rifugio], aveva notato come funzionava: finché era in mutandoni sul suo pagliericcio, con Too lì vicino, era lui, Moro Frun, all’anagrafe Agostino Faccin, nato a Borso il 4 novembre 1866.
Ma poi si infilava la giacchetta di velluto, sopra al taschino si appuntava la spilla d’argento con le due piccozze incrociate, calcava la berretta e prendeva la lanterna a carburo che teneva sempre con sé quando portava gente in giro per la Grapa. Allora diventava qualcosa d’altro. Era il Moro della cima, il guardiano del rifugio, quel burbero ed estroso personaggio che tanto bene si sposava con il paesaggio circostante”.
E com’è il Moro?
Il Moro è un uomo che non s’arrende alla sua vocazione, ch’è quella di stare in mezzo alle cime, fosse pure facendo la guida turistica ai “siori” che proprio negli anni della sua gioventù iniziano a scoprire le cime (“C’è poco da fare” pensa il Moro guardando quella gente “quando uno di fronte a una vacca non pensa al latte e al letame, ma a poeti vecchi di quasi duemila anni, vuol dire che appartiene a un’altra razza”). Così il giovane uomo silenzioso inizia a industriarsi con le parole perché se è vero, come si legge nel romanzo, che “le cose non hanno bisogno delle parole per esserci”, il Moro “un po’ alla volta capì che la storia più bella, se raccontata male, non vale un’ostrega, e l’aneddoto più insulso, se condito a dovere, rende più delle avventure di Bertoldo”. Lo stesso Malaguti si svela come narratore quando scrive: “Col tempo apprese che le storie sono come il formaggio: si parte sempre dalle stesse tre cose, latte, caglio e sale, eppure, a dosare diversamente gli ingredienti e i tempi di stagionatura, i risultati sono infiniti”.
Di riflessioni sulla potenza delle parole Malaguti ne fa diverse, a dirla tutta, e s’intuisce che l’autore nella forza dell’affabulazione crede eccome, anche quando afferma il contrario: “La sua sposa restava per lui [il Moro] più importante di tutte quelle persone con cui aveva ciacolato del più e del meno, e quindi concludeva che forse si dà troppa importanza alle parole, tant’è che i momenti più sereni della sua vita erano proprio quegli inverni nei quali a volte gli capitava di non parlare con nessuno per settimane, a volte per mesi”. Una riflessione del genere s’attaglia anche ai tempi nostri, quand’anche le parole dette sono state sostituite dal brusio di quelle urlate sulle bacheche social ma il risultato è lo stesso – che servirebbe un po’ di silenzio, cioè –, così come intramontabile, senza tempo e farmaco che la curi, è la paura dell’uomo del tempo che passa, più ancora della guerra che viene, allora come oggi. Il Moro solo nella sua montagna trova la pace: “Ecco cos’era quella strana e imprevista sensazione che la montagna gli aveva donato. Una libertà come mai ne aveva sperimentate. Forse ogni tanto qualcosa del genere c’era pure stato nella sua vita. Quando aveva preso il treno per tornare a casa finito il soldato. O, all’indietro, vaghi ricordi di giochi infantili, corse sui prati incendiati dal tramonto, infiniti pomeriggi nascosti nel fieno, senza il timore del tempo che passa” eppure quel tempo inesorabile scorre, inutile illudersi che non sia così, ma non per lei: “[…] Alla montagna non frega niente del passare degli anni e dei secoli, perché lei è più forte del tempo e degli uomini, e sarebbe stata ancora così, immutabile e serena, quando, di lì a cento anni, altri giovanetti avrebbero magari levato i bicchieri in quello stesso posto, salutando nientemeno che un nuovo millennio” (impossibile non pensare che l'autore possa far riferimento a sé che, classe 1978, al battesimo dell'anno Duemila era poco più che ventenne).
La montagna resta indenne a suo modo anche alla guerra, che l’attraversa, la scava, ci tiene nascosti i morti, e poco importa che gli uomini le cambino il nome (da la Grapa a il Grappa): è ai loro occhi che cambia, perché sono gli occhi degli uomini a cambiare. Scrive Malaguti: “La montagna è donna finché resta fertile, finché i suoi pascoli danno erba nuova e nuovi fiori anno dopo anno. Lassù quella che un tempo era stata la sua cima, casa sua, [del Moro cioè] erba non ne sarebbe più cresciuta. Era diventato quello che avevano cercato e voluto dalla guerra in poi. Il monte, il simbolo del popolo vittorioso, il sarcofago dei guerrieri morti nel fuoco e nel ferro”.
La vita, pare dirci la parabola di Agostino Faccin detto il Moro Frun, è un perpetuo cambiamento e attraverso questo, ch’è la storia di ciascuno e la Storia collettiva insieme, ci accompagna Paolo Malaguti con il suo narrare. Il Moro, chiosa l’autore “capiva bene che, anche ad aver studiato, le parole non sono che gusci fragili della realtà. Perché non esiste verbo che racchiuda in sé due vite trascorse assieme che vengono divise” come se la realtà, in fin dei conti, fosse ineffabile.
E, invece, il romanziere il verbo lo sa sempre trovare. E per fortuna.
“ Le storie sono come il formaggio: si parte sempre dalle stesse tre cose, latte, caglio e sale, eppure, a dosare diversamente gli ingredienti e i tempi di stagionatura, i risultati sono infiniti Paolo Malaguti