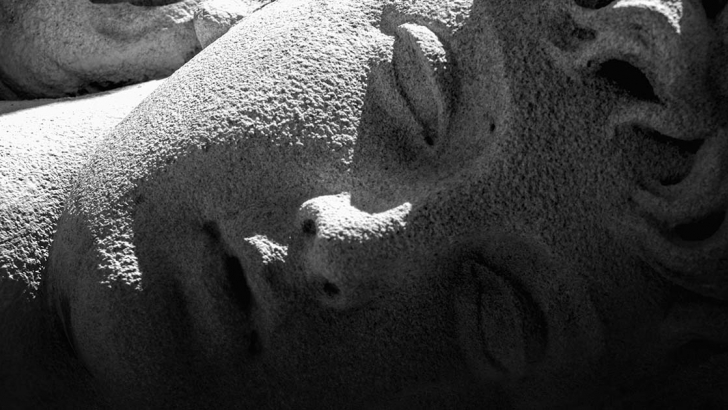La coscienza è un mistero ancora irrisolto

Foto: Vince Fleming / unsplash
Come facciamo ad essere consapevoli che esistiamo, che ci siamo e che esistono altre cose attorno a noi? La coscienza, come scrive Allison Parshall su Scientific American è “una delle più antiche domande sull’esistenza” che l’umanità si pone fin dalle origini del pensiero filosofico.
Nell’ultimo secolo, la natura e l’origine della coscienza sono state oggetto anche della ricerca in ambito neuroscientifico, che cerca di indagare, in primo luogo, in quale area del cervello nasca la coscienza e quali circuiti neuronali attivi. In questo filone si inserisce anche un recente studio pubblicato su Nature, frutto di un lavoro durato sette anni condotto da un gruppo internazionale di ricercatori, riuniti sotto il nome di Cogitate Consortium.
Lo scopo del lavoro condotto dal Cogitate Consortium era quello di confrontare con metodo sperimentale due delle principali teorie neuroscientifiche sulla coscienza. La prima è la dibattuta teoria dell’informazione integrata (IIT) – secondo la quale la coscienza richiederebbe l’elaborazione di un insieme di informazioni in modo altamente integrato e indivisibile, un processo che coinvolgerebbe soprattutto le aree posteriori del cervello. L’altra è la teoria dello spazio di lavoro neuronale globale (GNWT), secondo la quale la coscienza si manifesterebbe quando il cervello “accende i riflettori” su uno degli stimoli che riceve dal mondo esterno e si baserebbe sull’attivazione della corteccia prefrontale.
Il progetto Cogitate consortium rappresenta un esempio di “cooperazione competitiva”, in cui studiosi sostenitori di una o dell’altra delle due teorie in questione hanno collaborato tra loro, coinvolgendo anche ricercatori “neutrali” rispetto a entrambe le ipotesi di partenza. La fase sperimentale, svolta nel 2019 in diversi laboratori, ha coinvolto un campione complessivo di 256 partecipanti, la cui attività cerebrale è stata monitorata con diverse tecniche di imaging mentre eseguivano compiti visivi, come il riconoscimento di volti, lettere o altri oggetti presentati su uno schermo.
LEGGI ANCHE: Basta un ricordo per riscaldarsi
I risultati, però, non sembrano supportare né smentire del tutto nessuna delle due teorie, lasciando la questione ancora irrisolta. I primi esiti dello studio sono stati presentati nel 2023, determinando la chiusura di una celebre scommessa del 1998 tra il neuroscienziato Cristoph Koch e il filosofo David Chalmers. Koch, in particolare, scommise contro Chalmers che entro 25 anni gli studi neuroscientifici avrebbero scoperto le basi cerebrali della coscienza. Questa diatriba scientifica si è risolta perciò con la consegna di una cassa di vino e, soprattutto con la sconfitta del neuroscienziato.
Possibile che la ricerca delle basi neurali della coscienza sia una battaglia persa in partenza? Ne è convinto Riccardo Manzotti, professore ordinario di filosofia teoretica all’università IULM di Milano, che in diverse occasioni ha espresso un giudizio piuttosto critico verso questo tipo di approccio.
“Il problema è che si parte dai presupposti sbagliati” spiega Manzotti a Il Bo Live. “Nella fattispecie, si presume di sapere che la coscienza sia un fenomeno generato all’interno del corpo, nonostante negli ultimi centocinquant’anni non sia stata raccolta nessuna prova scientifica che giustifichi questa premessa. Se infatti un neuroscienziato non pensasse già di sapere che la coscienza si trova dentro il sistema nervoso, non gli verrebbe mai in mente di ipotizzare, sulla base di quello che effettivamente osserva studiando il cervello, che oltre ai neuroni, alle sinapsi, eccetera esista al suo interno qualcos’altro, di invisibile e impossibile da osservare direttamente, anche se si disponesse di una strumentazione estremamente sofisticata.
Si è supposto, quindi, che la coscienza sia una “non cosa” (perché non fisicamente osservabile) che si trova all’interno del sistema nervoso, un po’ come accadde in passato con il flogisto o il calorico: entità immaginate per spiegare certi fenomeni fisici, ma che si sono poi rivelate inesistenti”.
Secondo Manzotti, questo genere di ricerche sulla coscienza si limita quindi a monitorare alcuni tipi di attività neurale – per esempio, specifici pattern di attivazione o determinate connessioni tra aree cerebrali che si verificano mentre una persona svolge un certo compito – teorizzando che essi siano la coscienza. Tuttavia – osserva Manzotti – questa conclusione non è giustificata. “Chi ha stabilito che quei meccanismi cerebrali sono la coscienza? Si sta scambiando un segnale osservabile (l’attività cerebrale) per ciò che esso dovrebbe rappresentare (la coscienza)”.
Manzotti evidenzia, inoltre, alcuni limiti dell’approccio di cooperazione competitiva adottato nello studio in questione. “L’attività scientifica non dovrebbe consistere nel confronto di una teoria rispetto a un’altra per capire quale sia la più plausibile (o la meno implausibile)”, sottolinea. “Le teorie andrebbero giudicate sulla base di criteri razionali, quali l’economicità ontologica (il principio del rasoio di Occam, secondo il quale si preferisce la teoria che si basa sul minor numero di assunzioni non necessarie), la coerenza logica (l’assenza di contraddizioni interne) e la coerenza empirica (la compatibilità con i dati e le informazioni raccolte con l’esperienza). Inoltre, perché specificare che nello studio sono stati coinvolti anche studiosi “neutrali” rispetto a entrambe le due teorie di riferimento? La neutralità dovrebbe essere un requisito basilare per chiunque lavori a una ricerca scientifica.
Un altro problema riguarda l’obiettivo perseguito dagli autori, ovvero quello di “valutare se i meccanismi neurali proposti siano veramente necessari per la coscienza”. È una dichiarazione piuttosto debole. Anche essere vivi o avere un cervello è necessario per la coscienza. Il vero nodo, semmai, dovrebbe essere un altro: stabilire se quei meccanismi siano sufficienti per la coscienza. Solo in quel caso una dimostrazione assumerebbe un effettivo valore scientifico.
Per non parlare poi del fatto che in questo, così in molti altri articoli del genere, vengono utilizzati diversi termini ed espressioni che non hanno un significato concreto (ovvero non rimandano a qualcosa di osservabile o misurabile) e che non sono definiti in nessun punto, eppure sono cruciali per lo sviluppo dell’argomentazione. Tra questi troviamo, ad esempio, “consciousness”, “conscious dimensions”, “maintenance of conscious content”, “network connectivity specifies consciousness”, “information within a neural substrate”…
Torniamo quindi al problema iniziale: l’idea che la coscienza si trovi all’interno del cervello, che abbia un contenuto, e che nel substrato neurale siano presenti delle informazioni è fondata su assunzioni non dimostrate e mai realmente spiegate”.

Critico verso l’approccio neuroscientifico al problema della coscienza, Manzotti ha proposto una teoria alternativa di coscienza, secondo la quale la coscienza non è un fenomeno generato dai nostri neuroni, ma è ciò di cui facciamo esperienza: gli oggetti che vediamo, tocchiamo e percepiamo – l’orchidea che ammiriamo alzando lo sguardo, la brezza che entra da una finestra aperta, il rumore del traffico in lontananza – non si trovano “dentro” di noi, ma costituiscono ciò che noi siamo in quel momento.
“Parlare del contenuto della coscienza significa semplicemente elencare il mondo che in una determinata situazione è costitutivo della mia esistenza”, afferma Manzotti, la cui teoria si basa su due tesi: noi non costituiamo un’entità separata dal mondo fisico, al di fuori di esso (poiché, osserva, sarebbe impossibile dimostrare il contrario); e nonsiamo il nostro corpo, bensì abbiamo un corpo.
“Non facciamo mai esperienza diretta del nostro corpo: non vediamo il nostro cervello, non sentiamo il sapore della nostra lingua”, prosegue il professore. “Quando percepiamo il corpo lo facciamo in modo indiretto, attraverso specchi o sensazioni localizzate. Quello di cui facciamo veramente esperienza, in modo diretto, è il mondo fisico.
Per questo, possiamo concludere che noi non siamo né il cervello né il corpo, ma la porzione di mondo fisico che, in un dato momento, costituisce la nostra esperienza.
La coscienza, quindi, non è dentro il cervello e non è un fenomeno separato dal mondo fisico: è il mondo stesso, così come si dà nella relazione con il corpo. La mia esperienza di una mela, ad esempio, è la mela stessa”.
Che si concordi con la teoria della coscienza proposta da Manzotti – difficile da rendere in maniera esaustiva ed efficace in poche righe, ma sviluppata nel dettaglio nel suo libro La mente allargata (Il Saggiatore, 2019) – o che si ritenga ancora sensato ricercarne le basi neurali all’interno del cervello, una cosa è certa: la coscienza rimane, ancora oggi, un enigma irrisolto. E la cassa di vino che Koch ha consegnato a Chalmers per onorare la scommessa persa non fa che ricordarcelo: nonostante le diverse spiegazioni filosofiche proposte nel corso dei secoli e le informazioni acquisite nel campo delle neuroscienze, non sappiamo ancora davvero cosa sia la coscienza, né dove cercarla.