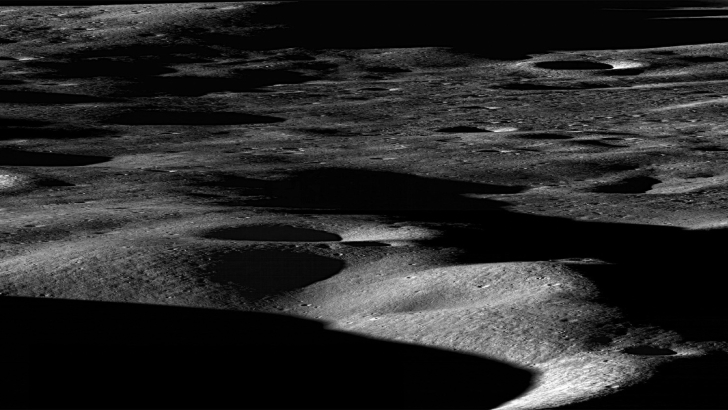Le porte dello spazio: la geografia dei lanci

Il centro di lancio NASA di Cape Canaveral. Foto: NASA
C’è un’infrastruttura fondamentale della nuova economia spaziale di cui si parla pochissimo. Tutti conoscono i nomi dei razzi, delle costellazioni di satelliti, delle missioni verso la Luna e Marte. Ma senza un punto da cui partire, nessuna di queste imprese potrebbe nemmeno cominciare.
Gli spazioporti – i luoghi da cui si accede fisicamente all’orbita – sono l’anello meno raccontato e più strategico della filiera spaziale. Sono le “porte” da cui passano la tecnologia, la politica e la sovranità. E nel mondo multipolare che sta ridefinendo anche la dimensione orbitale, possederne uno significa avere un vantaggio competitivo di primo livello.
La loro importanza si misura in modo inverso alla frequenza con cui se ne parla. Le immagini più spettacolari mostrano razzi che decollano, ma raramente si racconta dove avviene quel decollo, chi controlla la rampa e quali interessi ruotano attorno a quei pochi chilometri di cemento e acciaio. Eppure, è proprio lì – tra radar, torri di servizio e centri di controllo – che inizia la corsa allo spazio.
La potenza dei punti di lancio
Un razzo, per quanto sofisticato, è inutile se resta a terra. Serve un’infrastruttura che consenta di lanciare, monitorare, rifornire, recuperare e gestire in sicurezza una missione.
Eppure, mentre si moltiplicano gli annunci di megacostellazioni e nuovi vettori, gli spazioporti restano una risorsa limitata. Nel 2025 se ne contano tra 35 e 40 in tutto il mondo, ma solo una quindicina possono essere considerati pienamente operativi per lanci orbitali regolari. Gli altri hanno funzioni di test, suborbitali o commerciali emergenti.
Avere un proprio spazioporto significa controllare l’accesso allo spazio, ridurre la dipendenza da partner esterni e gestire le priorità nazionali e industriali. In altre parole: chi possiede la rampa, possiede il tempo. E nel mondo dei lanci, il tempo è potere.
Gli Stati Uniti e la geografia della potenza
Gli Stati Uniti restano la nazione con la rete più estesa e diversificata. Dal Kennedy Space Center e Cape Canaveral Space Force Station in Florida – dove si intrecciano i lanci NASA, SpaceX e ULA – fino alla Vandenberg Space Force Base in California, ogni sito è specializzato in diverse orbite: equatoriali, polari, solari.
Ci sono poi i complessi di Wallops (Virginia) e Kodiak (Alaska), oltre ai numerosi “commercial spaceports” autorizzati dalla Federal Aviation Administration, come Spaceport America o Mojave Air & Space Port, pensati per voli suborbitali e sperimentali.
Il risultato è un mosaico di infrastrutture che permette agli Stati Uniti di mantenere autonomia totale di accesso all’orbita, in ogni condizione e direzione. Nessun altro Paese dispone di un ventaglio così ampio di piattaforme e capacità.
Russia e Cina: la sovranità orbitale
Anche Russia e Cina considerano gli spazioporti un elemento di sovranità strategica.
Mosca controlla tre basi principali: Baikonur in Kazakistan, Vostočnyj nella regione dell’Amur e Pleseck più a nord. Baikonur, la più antica infrastruttura orbitale del mondo ancora attiva, ospita i voli con equipaggio delle Soyuz e continua a essere un simbolo dell’epoca sovietica, anche se operata oggi in regime di locazione.
La Cina, invece, ha costruito in meno di mezzo secolo una rete di quattro spazioporti principali – Jiuquan, Taiyuan, Xichang e Wenchang – più due nuovi complessi commerciali, tra cui il Hainan Commercial Spacecraft Launch Site, inaugurato nel 2024, e il porto marittimo di Haiyang, dedicato ai lanci off-shore.
In tutti i casi, il controllo è diretto e centralizzato: i lanciatori civili e militari operano sotto la stessa catena di comando, in una logica di integrazione totale tra industria e difesa. È il modello opposto a quello europeo, frammentato e spesso rallentato dalla burocrazia e dalle divisioni nazionali.
Asia: efficienza e ambizione
Nel resto dell’Asia la mappa si allunga rapidamente.
L’India, con il suo Satish Dhawan Space Centre a Sriharikota, ha dimostrato che è possibile costruire una capacità autonoma con risorse limitate e un forte indirizzo pubblico: da lì sono partite le missioni Chandrayaan verso la Luna e i satelliti per navigazione regionale.
La Corea del Sud, dal Naro Space Center, sta completando la serie di lanci del vettore nazionale Nuri, mentre il Giappone mantiene due basi operative – Tanegashima e Uchinoura – sotto la gestione di JAXA.
Più discreti ma non irrilevanti i casi di Israele, che dal poligono di Palmachim effettua lanci in direzione retrograda, cioè verso ovest, opposta alla rotazione terrestre: una scelta che riduce l’efficienza energetica ma serve a evitare che eventuali detriti ricadano su Paesi confinanti.
L’Iran, invece, utilizza il centro di Semnan per missioni scientifiche e satellitari a bassa quota.
L’Europa lontana da sé stessa
L’Europa, invece, continua a trovarsi a migliaia di chilometri dai propri lanci. Il Centre Spatial Guyanais (CSG) di Kourou, nella Guyana francese, è l’unico spazioporto pienamente operativo del continente, ma si trova nel Sud America.
La distanza geografica pesa: logistica complessa, trasporti via nave, costi elevati, vincoli ambientali e meteorologici. Ogni campagna di lancio richiede settimane di preparazione e dipende da rotte transatlantiche.
Il CSG, gestito congiuntamente da CNES, ESA e Arianespace, è la culla dei lanci europei – da Ariane 1 fino all’esordio di Ariane 6 nel luglio 2024 – ma rappresenta anche il paradosso di un continente che, pur dotato di una delle agenzie spaziali più avanzate del mondo, non dispone ancora di un proprio spazioporto operativo in territorio europeo.
Le conseguenze sono evidenti: dipendenza da vettori stranieri, ritardi accumulati, costi di trasporto elevati e una vulnerabilità strategica che mina la competitività industriale. Ogni chilometro di distanza dal punto di lancio si traduce in spese aggiuntive e in minore flessibilità, due fattori cruciali in un mercato dove la rapidità è ormai un requisito tecnico.
L’Artico come nuova frontiera europea
Per colmare questo vuoto stanno nascendo due iniziative potenzialmente interessanti.
In Norvegia, a oltre 69° di latitudine nord, è in fase di completamento Andøya Spaceport, primo sito continentale progettato per piccoli lanci orbitali verso orbite polari e sincrone. Il sito ha già ricevuto le autorizzazioni nazionali e prevede le prime campagne operative entro i primi mesi del 2026.
Ancora più simbolico è il caso svedese: lo Spaceport Esrange di Kiruna, inaugurato il 13 gennaio 2023 alla presenza del re di Svezia, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del premier Ulf Kristersson. È il primo complesso orbitale sulla terra ferma europea, costruito per micro-lanciatori e missioni scientifiche. La rampa LC-3 è completa, e i primi lanci orbitali sono previsti, anch’essi, nel 2026.
Accanto a questi siti UE, il Regno Unito ha sviluppato SaxaVord Spaceport nelle isole Shetland, già licenziato dall’ente regolatore britannico CAA (Civilian Aviation Authority), e Cornwall Spaceport, per voli orizzontali (cioè con decolli da una pista e non da una torre di lancio).
L’obiettivo comune è creare un network di infrastrutture che consenta all’Europa di ridurre la dipendenza da Kourou e garantire autonomia di accesso orbitale. Per la prima volta, l’Unione può immaginare una geografia spaziale interna, distribuita e complementare.
Il Nord Atlantico e il rilancio canadese
Anche il Canada si muove in questa direzione. Nella provincia della Nuova Scozia, la società Maritime Launch Services sta costruendo lo Spaceport Nova Scotia, progettato per ospitare lanciatori fino a 5 tonnellate.
Nel novembre 2025 il gruppo canadese MDA Space è entrato nel capitale della società con un investimento di 10 milioni di dollari canadesi, segnando l’interesse nazionale per una capacità di lancio sovrana. Il primo volo orbitale è previsto entro la fine del 2026.
In prospettiva, la fascia artica e nord-atlantica potrebbe diventare la nuova cintura di lanci dell’emisfero occidentale, con una rete di porti spaziali complementari e interoperabili.
L’Italia tra memoria e gestione futura
Anche l’Italia ha scritto un capitolo importante della storia dei lanci.
Negli anni Sessanta, l’ingegnere Luigi Broglio scelse la costa di Malindi, in Kenya, per costruire un complesso di piattaforme equatoriali da cui, tra il 1964 e il 1988, furono effettuati 27 lanci suborbitali e orbitali, incluso quello del satellite Uhuru, primo osservatorio a raggi X della NASA.
Oggi il Luigi Broglio Space Centre è gestito dall’ASI in cooperazione con la Kenya Space Agency: non effettua più lanci, ma opera come centro di controllo e ricezione dati (TT&C), fondamentale per missioni nazionali e internazionali. L’accordo bilaterale, ratificato nel 2020, prevede progetti di formazione e trasferimento tecnologico, e fa parte delle iniziative del Piano Mattei per l’Africa che potrebbero rilanciare il ruolo del sito nei micro-lanci equatoriali.
Sul fronte nazionale, l’Aeroporto di Grottaglie (Taranto) è stato designato da ENAC nel 2023 come primo spazioporto italiano, abilitato a operazioni orizzontali e suborbitali. La pista, una delle più lunghe d’Europa, è adatta ai velivoli di Virgin Galactic e ai futuri sistemi riutilizzabili europei.
L’Italia si trova così in una posizione peculiare: un passato pionieristico nel campo dei lanci, un presente di infrastrutture di supporto, e un futuro potenzialmente strategico se saprà investire nella riattivazione di Malindi e nel pieno sviluppo di Grottaglie.
Gli spazioporti come infrastrutture geopolitiche
Dietro la tecnica, c’è la politica. Uno spazioporto non è solo una base di lancio: è una infrastruttura critica che garantisce indipendenza tecnologica, attrazione industriale, competenze, occupazione qualificata e – sempre più spesso – funzioni di difesa.
Gli Stati Uniti li considerano parte delle “critical infrastructures”; la Cina li integra in una rete duale civile-militare; la Russia li protegge come siti strategici.
L’Europa, al contrario, è costretta a dipendere da operatori privati o da lanci da territori d’oltremare, con conseguenti ritardi e maggiori spese. Il ritardo nell’esordio di Ariane 6, l’uso di Falcon 9 per missioni europee e la carenza di capacità di backup mostrano quanto la mancanza di spazioporti sia un collo di bottiglia sistemico.
Una nuova corsa silenziosa
La corsa agli spazioporti è oggi parallela a quella per i vettori e le costellazioni.
Ogni Paese vuole un proprio sito di lancio: per la sicurezza dei dati, per le opportunità economiche, per non restare indietro nella catena globale dello spazio.
Nel nuovo equilibrio orbitale, chi controlla i punti di lancio controlla anche il ritmo della competizione.
L’Europa può ancora ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma solo se saprà costruire – nel proprio territorio – le basi concrete della sua autonomia spaziale.
Perché possedere uno spazioporto significa, in ultima analisi, disporre di un’infrastruttura che unisce politica industriale, tecnologia e visione strategica. E in un mondo in cui l’orbita è sempre più affollata, avere un punto da cui partire non è un dettaglio: è la condizione stessa per restare in gioco.