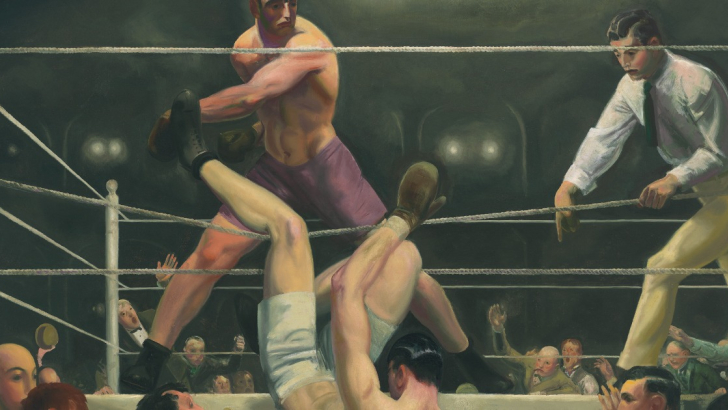Classici a rischio cancellazione? No ma…

Lincoln Memorial, Washington D.C. Foto: David Bjorgen (CC BY-SA 2.5)
No, nessuno dice ancora di togliere dai programmi Socrate e Cicerone, ma nelle università americane (e non solo) gli spazi per la cultura greca e latina sembrano restringersi. Le notizie non sono confortanti: Howard, uno più prestigiosi atenei ”historically black”, nonché alma mater dell’attuale vicepresidente Kamala Harris, ha deciso di chiudere il proprio dipartimento di Classics, mentre Princeton ha eliminato la conoscenza delle lingue greca e latina dai prerequisiti per iscriversi alle lauree in letteratura antica.
Notizie che hanno suscitato un forte dibattito negli Usa ma che soprattutto in Italia sono state risucchiate nella polemica sulla cosiddetta cancel culture: una ricostruzione che non vede d’accordo Mario Del Pero, docente di storia internazionale e di storia della politica estera statunitense presso SciencesPo a Parigi. “Partiamo dal presupposto che ci sono eccessi antipatici e gravi nei college americani, dove wokeness o politically correct a volte portano a un controllo quasi poliziesco del linguaggio in nome di una neutralità di fatto irraggiungibile nella vita reale – spiega Del Pero a Il Bo Live –. Detto questo sono molto irritato per come la questione viene riportata dai media italiani”.
Nel caso di Howard più che da motivazioni ideologiche la decisione dell’ateneo è stata dettata da problemi di budget e dalla scarsità di iscritti: “Spesso purtroppo nel clima culturale odierno gli studi classici appaiono meno attrattivi per gli studenti rispetto a quelli che affrontano tematiche come genere, sessualità e razza – continua lo studioso, che alla questione ha dedicato più di un intervento sul suo blog –. Nessuno però ha detto che Cicerone va ripudiato in quanto maschio bianco: a Princeton il tentativo è anzi di aprire la facoltà a un numero maggiore di persone. Certo la possibilità di conseguire una laurea di primo livello in classics senza conoscere greco e latino è problematica, ma in parte viene giustificata con il fatto che nel sistema scolastico americano soltanto gli studenti delle prep-school di élite ricevono una qualche preparazione in questo campo”. Con lo stesso provvedimento Princeton ha infatti attivato degli insegnamenti per recuperare l’eventuale gap in vista di corsi postlaurea o di dottorato.
“ La cultura classica è stata centrale per i padri fondatori degli Stati Uniti, ma anche nella formazione di Martin Luther King
Tutto a posto quindi? Non proprio, perché un problema sul ruolo dei classici sembra esserci. Un intellettuale influente come Cornel West, docente ad Harvard ed esponente di spicco dell’intellighenzia afroamericana, a proposito della scelta di Howard ha addirittura parlato di spiritual catastrophe, ricordando l’importanza degli autori greci e latini nella formazione di leader per l’emancipazione e i diritti civili come Frederick Douglass e Martin Luther King. Il problema, sembra suggerire l’intervento di West (che pure non manca di fustigare periodicamente le contraddizioni e le disuguaglianze della società americana) è di riconoscersi o no nella “cultura occidentale”, trattata “come irrilevante, dannosa, degna solo di condanna”. Dall’altra parte della barricata ci sono intellettuali come Dan-el Padilla Peralta, docente di storia romana proprio a Princeton, che vede la cultura classica – o meglio nel modo in cui questa viene intesa a insegnata in particolare negli Usa – come strettamente legata al mito dell’occidente e della “bianchezza” (whiteness), usato in passato per giustificare colonialismo, schiavismo e ingiustizia sociale.
“La cultura classica ha un ruolo centrale nella storia statunitense delle origini – conferma Del Pero –. Quella americana è stata una rivoluzione repubblicana, che ambiva a offrire un modello globale destinato secondo Jefferson a replicarsi in tutto il mondo: un repubblicanesimo che in questa visione era erede di quello antico. Banalmente si vede anche nell’architettura, dalla città di Washington al Campidoglio federale, tempio della buona politica e del confronto, ma lo stile neoclassico prevale anche nelle università e nei centri di educazione. Per questo più che attacchi alla cultura greco-romana posizioni come quella di Padilla sembrano tentativi di mettere in evidenza la contraddizione fondativa di un Paese che, pur appellandosi alla libertà e alle virtù, poggiava sulla schiavitù”. Una questione, quella dell’oppressione delle minoranze e in particolare dei neri, che non si è affatto conclusa con la fine della segregazione negli anni ’60: “Il cosiddetto razzismo sistemico esiste ed emerge da diversi indici: dal reddito all’istruzione, dalla sanità alle carceri. Solo negli ultimi anni la situazione è stata in parte corretta, grazie anche a strumenti loro volta problematici come le affirmative action”.
I rischi di cultural war insomma ci sono, e come al solito trovano nella scuola e nell’università un terreno privilegiato (anche se non esclusivo: si pensi alla questione intorno all’opportunità di inginocchiarsi prima degli eventi sportivi). Forse comunque nell’ennesima polemica sulla cancel culture c’è anche qualcosa di più: il ritorno prepotente alla politicizzazione degli spazi e del dibattito pubblico, a quel ‘primato della politica’ (o dell’ideologia) di cui si erano perse le tracce da qualche decennio. “Spero che certi eccessi rientrino ma credo che il parallelo con gli anni ‘70 ci stia – è l’opinione di Mario Del Pero –. C’è sicuramente più coinvolgimento: pensiamo solo all’ultimo voto americano, che ha visto la partecipazione di quasi 160 milioni di persone, 20-30 milioni in più rispetto al precedente record. Si tratta però di una politicizzazione in gran parte trainata da guerre culturali, che sono pericolose perché si costruiscono su assoluti non negoziabili. Una politica che invece di essere l’arte negoziato polarizza e divide: non a caso una certa destra alla Trump la cavalca perché fa il suo gioco”.