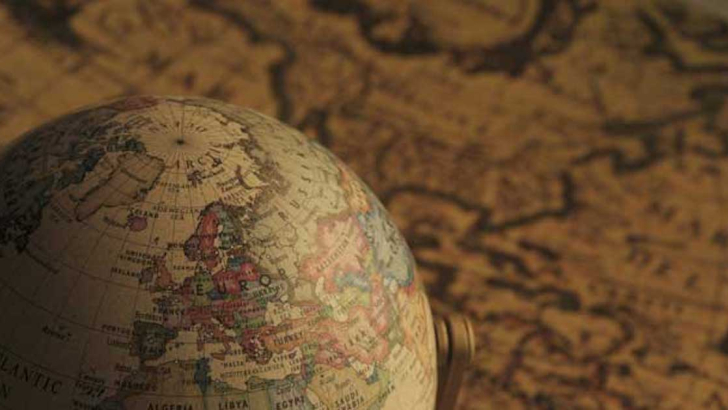Green to Grey. Sul lago di Garda, dove turismo e cemento divorano la natura

Piattaforma di costruzione di fronte alla riva di Desenzano, foto di Stefano Nicoli
A connettere Largo Goethe a piazza Castello c’è un unico collegamento: il ponte levatoio costruito alla fine del XIII secolo dalla famiglia Dalla Scala di Verona che costruì anche la fortezza. Siamo a Sirmione, sponda lombarda del lago, e quando l’afflusso turistico è ai massimi livelli, come durante l’alta stagione, anche solo attraversare il ponte diventa un’impresa snervante. Le immagini di questo stesso ponte preso d’assalto da masse di persone degne di un concerto da stadio nel primo weekend di maggio hanno fatto il giro della rete e dei telegiornali. Quel pezzetto di strada si è trasformato sempre più in uno dei simboli dell’overtourism che interessa tutto il lago di Garda. Tanto da far parlare perfino le autorità locali della necessità di ragionare su contromisure.
Ma non si tratta solo dei disagi di chi vive dove si riversano i turisti. L’aumento delle presenze si traduce necessariamente anche in un aumento dell’occupazione di suolo per fornire alloggi e servizi a chi viene a soggiornare sul Garda. Come raccontiamo in Green to Grey, un lunga inchiesta in diversi capitoli, cui abbiamo lavorato per mesi assieme a 41 colleghi di 11 paesi con lo scopo di misurare la quantità di natura perduta perché convertita in strade e cemento in tante regioni europee tra il 2018 e il 2023, guardando le coste del Garda dai satelliti si può facilmente notare come il grigio delle costruzioni abbia rubato sempre più spazio al verde della natura. Una natura che risente della massiccia presenza umana: rarissimi tratti di costa selvatici, sempre meno spazio per le specie animali che vivono attorno al lago e nelle sue acque. L’overtourism ancor prima di essere un problema sociale ed economico è soprattutto un’urgente questione ecologica. Anche perché, a dispetto del suo enorme valore naturalistico e paesaggistico, il lago di Garda ha pochissimi tratti protetti ed è dunque privo, perfino sulla carta, di quei meccanismi che dovrebbero garantirne una conservazione attenta. Almeno per ora.
Analizzando i dati raccolti da Zander Venter, ricercatore del Norwegian Institute for Nature Research (NINA), il centro di ricerca norvegese da cui è partita questa grande inchiesta collettiva, e incrociandoli con quelli che ci sono stati forniti da Emanuele Miccolis, dottorando in biodiversità all’Università di Palermo, risulta evidente che il principale lago italiano è protetto dalle varie leggi e direttive solo per una parte della sua costa: una piccola superficie sulla riva veneta e una parte più consistente in quella nordoccidentale, nel parco dell’alto Garda bresciano, che copre anche il tratto rivierasco tra i comuni di Salò e Limone.
Leggi anche l'introduzione alla serie Green to Grey. L’Europa distrugge il verde e diventa sempre più grigia
Un fatto che non sorprende, purtroppo. Perché è chiaro, se già è difficile proteggere le zone tutelate, come le storie raccolte dai nostri colleghi in Portogallo e Turchia dimostrano e come ci hanno spiegato i diversi esperti con cui abbiamo parlato, continuare ad aggredire un territorio che non ha alcuna forma di protezione nemmeno sulla carta è chiaramente assai più facile. Su questo, come vedremo, fa leva la proposta forse più originale e coraggiosa che abbiamo potuto incontrare in questo nostro percorso di inchiesta, quella di ottenere il riconoscimento di personalità giuridica per l’intero lago. Un’idea ardita, che ha pochi precedenti anche a livello internazionale, ma che potrebbe essere l’unica via per ragionare in modo integrato sull’intero ecosistema lacustre.
Ma facciamo un passo indietro. E cerchiamo di capire cos’è il Lago di Garda e com’è diventato il territorio che oggi conosciamo.
Grand Hotel Garda
Il primo albergo sulle rive del lago lo aprì nel 1881 Luigi Wimmer a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, ed è ancora in attività. Wimmer è stato uno dei Mille che fecero l’impresa con Garibaldi e la sua idea era di fondare una stazione climatica invernale per ospitare soprattutto villeggianti dalla Germania che potessero venire a svernare al sole, lontano dal freddo dell’Europa del nord.
Come scriveva nel 1897 Giuseppe Solitro, giornalista che si è interessato alla storia del Garda:
“Sull'aprirsi del settembre incominciano a farsi vedere nella regione i primi Tedeschi, da principio alla spicciolata, poi a piccoli gruppi, finalmente in grosse compagnie [...] Sul finir del dicembre la colonia è completa: gli alberghi, le ville riboccano, ma gli arrivi non cessano, ogni giorno porta altra gente, avida di cielo azzurro e di sole”.
Il turismo sul lago di Garda è inizialmente un’attività che coinvolge l’alta borghesia e l’aristocrazia che soggiornano in poche località. Il territorio è ancora piuttosto arretrato e privo di infrastrutture. Dopo l’inaugurazione nel 1852 della linea ferroviaria Verona-Brescia, con stazioni a Peschiera e Desenzano, bisogna attendere fino al 1929 per l’apertura della Strada gardesana occidentale, che collega i comuni della sponda lombarda. Per la Statale orientale, invece, bisognerà attendere il via con il Decreto Ministeriale del 27 marzo 1959. Nel frattempo, nel 1948 è stato inaugurato il nuovo Stabilimento Termale di Sirmione, che diventa uno dei simboli della ripresa dopo la guerra e dello slancio turistico della seconda metà del secolo.
Oggi i numeri sono profondamente diversi. Le presenze turistiche, e cioè i pernottamenti totali, nel 2023 hanno raggiunto quota 25 milioni, su tutte le sponde del lago, che interessano due regioni, il Veneto e la Lombardia, e la provincia di Trento. I dati ISTAT raccontano un trend molto chiaro: nei dieci anni tra il 2014 e il 2023, ultimo anno per il quale ci sono dati disponibili, l’incremento complessivo delle presenze turistiche è in media attorno al 30%, con picco maggiore sulla sponda veneta, caratterizzata da una grande presenza di camping, seguita da quella lombarda e trentina. I dati però non restituiscono una fotografia completa, perché tengono conto solo dell’utilizzo delle strutture ricettive commerciali: hotel, ostelli, b&b, appartamenti vacanze, residence.
Quello che non c’è, in questi numeri, sono i dati degli affitti, brevi o lunghi, di strutture non commerciali, che costituiscono però la maggior parte di quelle presenti su piattaforme come Airbnb. E dunque queste presenze, già così molto consistenti, non sono ancora quelle reali. E anzi è proprio quest’altro turismo che evidentemente continua a crescere e a porre un problema, se, come evidenziano le immagini satellitari da cui siamo partiti in questa inchiesta oltre alla nostra documentazione raccolta sul campo, si continua a costruire e non certo abitazioni per i residenti. La popolazione di Desenzano del Garda, per dire, è passata da 27mila a 29mila abitanti tra il 2011 e il 2021. Quella di Sirmione da 1000 a 6500 abitanti nel corso di tutto il ‘900 ed è arrivata a 8000 nel 2021.
Piccoli labirinti addormentati
Partendo dal database del biologo norvegese Zander Venter, del centro di ricerca NINA; poi verificato dal team di giornalisti di Green to Gray coordinato da Arena for journalism in Europe, abbiamo individuato una serie di siti in costruzione lungo la costa meridionale del lago. In particolare, ci siamo concentrate sul lato lombardo, influenzate anche dalle cronache di sovraffollamento, tra i comuni di Sirmione e Desenzano, e un mercoledì nel tardo maggio di quest’anno siamo andate a vedere con i nostri occhi di che costruzioni si tratta, assieme ai colleghi del Giornale di Brescia con cui abbiamo collaborato per questo capitolo della nostra storia. Dopo l’exploit del Primo maggio, il flusso turistico era in realtà molto leggero, e l’aria era quella dei preparativi per la stagione in apertura. Abbiamo documentato con fotografie e riprese con droni diversi complessi residenziali, palazzine e villette a schiera, addirittura sorprendentemente dotate di bizzarre piscine individuali, tutte piuttosto nuove o ristrutturate, ben rifinite ma senza negozi, bar, panifici. Oltre a queste case, perlopiù chiuse, non c’era nulla delle attività che di solito animano un quartiere dove vivono delle persone. Piccoli labirinti sospesi e addormentati.
Il turismo è cambiato nel tempo. Ma anche il turismo cambia il territorio e i suoi abitanti. “Fondamentalmente c'è stato lo spacchettamento del prodotto turistico. - spiega Francesco Visentin, geografo all’Università di Udine - Dai grandi alberghi di un tempo, che pure continuano a gestire le proprie strutture, adesso c’è anche questa illusione che tutti, attraverso le piattaforme, possiamo guadagnare dal turismo. Basta avere una proprietà, anche un piccolo capitale, una casa da affittare. Rimane però una questione di capitalismo estrattivo.”
Se nel 1950 viaggiavano 25 milioni di persone su una popolazione mondiale di 2,5 miliardi, i turisti erano sostanzialmente l’1%. Oggi, che siamo 8 miliardi, in viaggio ci vanno più di 1,5 miliardi di persone, cioè il 20-25%. Il fatto è che lo spazio a disposizione non cresce. “Non contempliamo il concetto di limite - sottolinea ancora Visentin - lo spazio nel Lago di Garda è quello. Se continui a costruire infrastrutture e ad attirare sempre più gente, aumenti solo il numero dei turisti che arrivano e non la vivibilità di un territorio.” Questo è un fenomeno che vediamo in molti posti ad alta intensità turistica. L’unico modo di far spazio per aumentare i turisti è espellere le persone che in quel luogo abitano, ci vivono, lo animano tutto l’anno. “A me fa sorridere lo slogan di Airbnb - conclude amaramente Visentin - quello che dice live like a local. Ma come vivi da local, se se ne sono andati via tutti?”
Turismo e sostenibilità: un ossimoro?
“Sirmione è una cittadina bellissima, dove purtroppo non c'è più posto - ci dice, molto accorato in videocall, Paolo Zanollo, responsabile locale del WWF di Brescia - Non c'è più posto, è inutile, non c'è più spazio. Dunque, continuare a chiamare turisti è veramente un suicidio. E invece si stanno ipotizzando metropolitane sull'acqua, battelli… ma non c'è più posto, basta!”
Se nuovi alloggi significano più turismo, è anche vero che c’è chi prova ad andare in una direzione diversa, proponendo il lago come luogo di turismo sostenibile, verde, sportivo. Come anche in altri casi, raccontati dai nostri colleghi europei nel corso di questa inchiesta, anche sul Garda negli ultimi anni si dà grande spazio e risonanza allo sviluppo di un turismo sostenibile: ciclovie, pareti per l’arrampicata, passeggiate lungolago e yoga sulle rive, un turismo per amanti della natura e dello sport. Ma la sostenibilità, in un ambiente fragile, è compatibile con il ritmo delle attività e delle presenze che stiamo registrando? Sono in tanti, proprio anche tra i gruppi e le associazioni ambientaliste, a richiamare la necessità di ragionare sull’offerta turistica a tutti i livelli, perché in un ambiente così complesso non esiste una proposta a basso impatto.
Lo sottolinea anche Francesco Visentin. “Il turismo funziona per inseguimento: non basta più solo la spiaggia, si aggiunge qualcosa per attirare nuovo turismo. Oggi il lago di Garda è diventato un hotspot turistico sportivo”, spiega il geografo.
Prendiamo dunque il caso della ciclovia, un’opera di cui si sta tanto discutendo sul lago e che ha trovato una forte opposizione perfino all’interno del mondo delle associazioni ambientaliste. La “ciclabile dei sogni”, come viene definita su diversi siti istituzionali, è una struttura metallica costruita a sbalzo sulla falesia, sospesa a 50 metri sul livello del lago, a fianco della Strada Statale 45bis Gardesana, con una passerella di 2,5 metri e una barriera d’acciaio sottile che consente una “vista mozzafiato”, percorribile anche di notte grazie a un sistema di illuminazione a led. Per ora il tratto aperto è di 12 chilometri, sulla riva occidentale tra Lombardia e Trentino, ma l’ambizione dei comuni è di completare l’intero anello di 140 km che consenta di fare in bici l’intero perimetro del lago. Come mai questo ipotetico capolavoro di turismo green incontra tanta opposizione? Rispetto ai visitatori mordi e fuggi che arrivano in automobile, dovrebbe essere preferibile favorire la mobilità dolce sui pedali. Il problema è che costruire su una falesia, oltre al consistente impatto visivo dal lago, e come vedremo nella seconda puntata di questa inchiesta anche quello sull’avifauna, pone anche un problema di sicurezza.
“Si tratta di falesie in movimento. Le frane ci sono. Frequentemente. - ci spiega ancora Paolo Zanollo - E proprio lo scorso anno, mentre facevamo una campagna sulla pericolosità di questa struttura, c’è stata la grossissima frana di Tremosine.” Nel dicembre 2023 la frana di Tremosine, è stata tanto consistente da portare alla chiusura di una delle strade sottostanti per settimane. Un evento avvenuto in assenza di precipitazioni intense e dunque attribuibile esclusivamente alla fragilità della costa rocciosa. E che, per la sua portata e i rischi conseguenti, ha generato un ripensamento sull’opportunità di proseguire nel disegno originario perfino nelle istituzioni locali.
La ciclopedonale, ci spiega ancora Visentin, può essere vista dunque come l’ennesimo servizio a favore dell’industria del turismo: non sarà una pista ciclabile che ridurrà il numero di automobili in circolazione, ma farà aumentare il numero delle presenze, attratte da questo nuovo servizio. Non si tratta di un servizio per permettere agli abitanti del lago di avere un’alternativa per i propri spostamenti, aumentando il benessere locale. Per fare questo, sarebbe necessario fare leva sugli altri trasporti, incentivando i trasporti pubblici. “Invece è chiaro - conclude Visentin - che si tratta solamente di un altro effetto della segmentazione dell’offerta turistica che in sé può anche essere sostenibile, ma inserita in questo quadro mostra la propria insostenibilità”.
Cancellare la natura
Aumenta la cubatura. Aumentano le attività proposte in riva al lago, sul lago, attorno al lago. E si trasformano le aspettative dei turisti. “Un turista in grado di valutare il reale livello di conservazione ambientale di un luogo è sempre più raro - ci spiega Osvaldo negra, zoologo e curatore del MUSE, il Museo delle scienze di Trento, che aggiunge - un turista può considerare gradevole qualcosa che da un punto di vista ambientale è invece profondamente alterato. Per esempio, ciclabili e passeggiate lungo le rive che vengono delimitate da roccioni costruiti che non hanno nulla a che vedere con l'originario assetto della riva. Una bella riva pulita, senza vegetazione scomoda. Finiscono i roccioni, comincia la passeggiata asfaltata o pavimentata in travi di legno e il tutto è molto gradevole, come se fosse il bordo di una piscina. È un po' questo anche il problema: spesso un paesaggio comodo per il turista è un paesaggio da cui molta parte della natura è stata cancellata.”
Partecipa anche tu
Vuoi contribuire a mappare la perdita di suolo per avere dati sempre più accurati? Zander Venter, il ricercatore di NINA, sta lanciando un nuovo progetto su scala globale per misurare la distruzione di boschi, foreste e terreni. E ha bisogno di aiuto da tutti. Per questo ha lanciato un progetto di citizen science, a cui puoi partecipare anche tu utilizzando una app per mappare e verificare i dati del tuo territorio. Tutte le informazioni le trovi qui: https://www.nina.no/english/globalnatureloss
Green to Grey è un progetto di data journalism investigativo avviato e coordinato da Arena for Journalism in Europe e dalla Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). È un progetto di inchiesta cross-border transnazionale che coinvolge: De Standaard (Belgio), Le Monde (Francia), Long Play (Finlandia), Die Zeit (Germania), Reporters United (Grecia), Facta (Italia), NRK (Norvegia), Gazeta Wyborcza (Polonia), Datadista (Spagna), The Black Sea (Turchia) e The Guardian (Regno Unito).
Il Norwegian Institute for Nature Research (NINA) ha fornito l’expertise scientifica per il progetto.
La metodologia completa è descritta da Léopold Salzenstein (Arena) e Zander Venter (NINA)
Questa serie di articoli pubblicati su Il Bo Live sono stati supportati da Journalismfund Europe e da IJ4EU Investigative Journalism for Europe.
Per tutte le storie pubblicate, vai su: greentogrey.eu