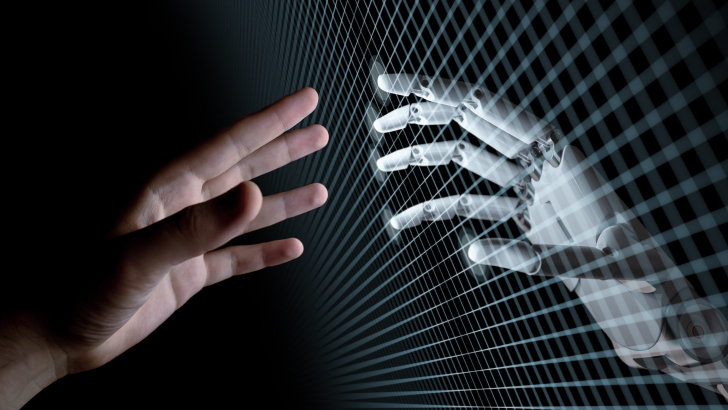Siamo troppi? Il dilemma demografico che non si può più ignorare

Siamo troppi: anzi no, il declino demografico è un pericolo. Quando si parla di popolazione si scatena una tempesta di opinioni discordanti, raramente informate. Del resto la questione demografica ne suppone e tocca molte altre: la sessualità, il rapporto uomo-donna e quello tra individuo e società, persino il ruolo dell’essere umano sul pianeta e, potenzialmente, nell’universo. Un tema sensibile e sfuggente, per questo politicamente esplosivo, dove i numeri rischiano di diventare armi. È questo il tema di Troppi. Conversazioni sulla sovrappopolazione umana e sul futuro del pianeta (Codice, 2024), finalista al Premio Galileo 2025, con il quale il giornalista scientifico e divulgatore Alfonso Lucifredi, tenta di affrontare uno dei grandi temi del nostro tempo. L’autore parte da un dato: nel 1977, anno della sua nascita, gli esseri umani erano circa 4,2 miliardi: oggi siamo più di 8, e le proiezioni delle Nazioni Unite parlano di 10,4 miliardi entro il 2100. Un balzo impressionante, anche se le curve di crescita stanno rallentando. I numeri da soli però non spiegano però tutto, perché la questione non è quante persone abitano il pianeta, ma come lo abitano.
Il libro è strutturato come una rassegna di grandi questioni, affrontate capitolo per capitolo grazie all’aiuto di esperti: l’impatto climatico, la produzione alimentare, l’equità sociale, la salute pubblica, le migrazioni, l’economia. Lucifredi non cerca risposte univoche, propone una pluralità di voci: scienziati, attivisti, esperti di statistiche e di biodiversità. Conrad Hackett, demografo del Pew Research Center, ridimensiona ad esempio l’idea di una crescita demografica inarrestabile. È vero che entro la fine del secolo si prevede un aumento di almeno un miliardo di persone solo nel continente africano, al tempo però stesso gran parte del mondo – comprese India, Cina e gran parte dell’Asia sud orientale – si trova già oggi al di sotto del cosiddetto tasso di sostituzione, tradizionalmente indicato in 2,1 figli per donna. Per non parlare dei Paesi europei, dove gli effetti del cosiddetto inverno demografico sull’economia e la società sono appena gli inizi. La crescita globale proseguirà ancora per qualche decennio, spiegano gli esperti, soprattutto per effetto del cosiddetto momentum demografico, ovvero dell’inerzia statistica dovuta alla struttura per età delle popolazioni, ma con ogni probabilità il picco sarà raggiunto tra il 2060 e il 2100. Da lì in avanti, il mondo potrebbe entrare in una fase di progressiva decrescita. Il punto, ancora una volta, è capire come ci arriveremo.
Gianluca Lentini, climatologo del Politecnico di Milano, delinea le conseguenze preoccupanti dell’aumento della popolazione sui cambiamenti climatici, i quali a loro volta provocano movimenti di popolazioni perennemente in cerca di risorse in esaurimento, mentre Mauro Mandrioli, biologo e docente di genetica presso l’università di Modena e Reggio Emilia, illustra come nuove tecniche agricole e tecnologie genetiche potranno aiutarci a sfamare una popolazione in crescita. Un passaggio provocatorio – utile a smuovere il dibattito – viene dall’intervista (pubblicata anche da Il Tascabile) a Les U. Knight, fondatore del Movimento per l’Estinzione Umana Volontaria (Voluntary Human Extinction Movement, VHEMT). Il suo slogan, “Thank you for not breeding”, riassume una proposta estrema: arrestare completamente la riproduzione umana per evitare ulteriori danni agli ecosistemi. Knight, anche se in maniera non violenta, rifiuta soluzioni moderate – come fermarsi a due figli per coppia – reputandole insufficienti di fronte alla crescita di 80 milioni di persone l’anno.
Lo stile del libro è piano e accessibile senza essere semplicistico, l’approccio divulgativo, teso fornire strumenti critici per orientarsi in un dibattito spesso distorto. Il tentativo è quello di disinnescare le dicotomie facili; non esistono infatti una sola narrazione, né un solo problema: se da un lato l’Africa subsahariana affronta una crescita demografica esplosiva, in gran parte del mondo industrializzato si parla invece di “inverno demografico”, con effetti a catena su welfare, lavoro e coesione sociale. Più che opporsi, queste due tendenze si incastrano in una dinamica globale: il problema, più che la quantità di persone, è infatti la qualità delle risposte politiche e culturali.
Forse il limite del libro più evidente – e al tempo stesso comprensibile – è che, volendo affrontare il problema da una prospettiva globale, dà in qualche caso l’impressione di trattare la popolazione umana come una variabile aggregata: una massa omogenea di item fungibili, in cui le persone possono sostituirne altre senza che nulla cambi. I numeri da soli però non bastano: la demografia è anche cultura, storia, memoria collettiva. “Volevamo delle braccia, sono arrivate uomini”, scriveva nel secolo scorso Max Frisch a proposito dell’immigrazione italiana in Svizzera, e oggi la questione si ripropone: nei Paesi ricchi mancano giovani, lavoratori e nascite, eppure l’idea di “rimpiazzarli” con migranti provenienti da aree più povere del mondo genera tensioni profonde, perché ogni spostamento umano porta con sé identità, linguaggi, sistemi di valori. Gli scontri – riconosce lo stesso Lucifredi – non sono solo economici, ma anche politici, culturali e simbolici.
La sovrappopolazione non è insomma solo questione di contare corpi: è un fenomeno complesso che chiama in causa il modo in cui organizziamo le città, produciamo energia e cibo, redistribuiamo la ricchezza e soprattutto immaginiamo la società in cui viviamo. Che in futuro non potrà più, per forza di cose, aderire a un modello di sviluppo predatorio e diseguale, con l’1% più ricco della popolazione mondiale che da solo emette più gas serra del 50% più povero. Troppi da questo punto di vista, come l’autore rivendica con onestà, è un libro che non contiene soluzioni ma che pone le domande giuste. Se davvero arriveremo a dieci miliardi di esseri umani, dovremo immaginare un mondo in cui tutti possano avere accesso a cibo, salute, istruzione e dignità senza compromettere la biosfera. Una sfida epocale ma non impossibile, se solo smettessimo di affrontarla come una statistica neutra o un’emergenza ideologica. Chissà.
Premio Galileo 2025
- Machina Sapiens di Nello Cristianini
- Storia naturale del tatto di Laura Crucianelli
- Corpo, umano di Vittorio Lingiardi
- Troppi di Alfonso Lucifredi
- Razze umane di Michele Pompei