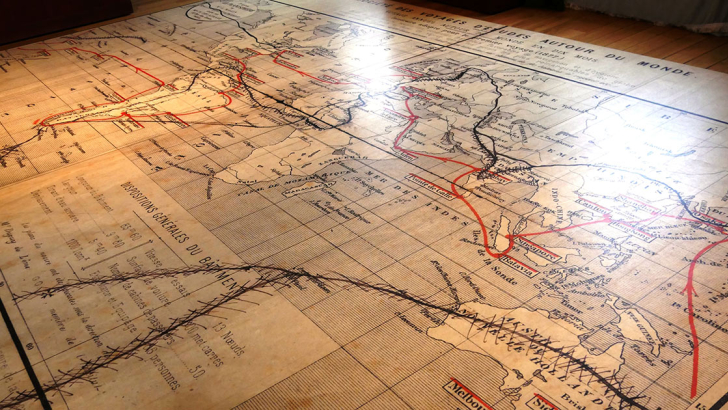Voglio andare a vivere in montagna

L’Italia delle terre alte. Il nostro Paese è un territorio montano per il 43,4% dei suoi comuni. Sono 661 i comuni tra gli 800 e i 1500 metri sul livello del mare, 2.202 tra i 400 e gli 800 metri d’altitudine, 3.471 sono considerati totalmente montani. Significa che in montagna vivono quasi nove milioni di persone. Dati che ci fanno capire come, forse, di montagna sarebbe corretto occuparsene di più e non solamente da un punto di vista turistico.
Ci sono regioni che hanno il 100% del loro territorio considerato montano e, come si legge nel rapporto Montagne Italia 2025 dell'UNCEM, cioè l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, "la condizione insediativa e socioeconomica delle montagne italiane presenta un quadro di assoluta evidenza che ne qualifica immediatamente, nella percezione diffusa, i tratti essenziali associandoli a una immagine di rilevante penalizzazione per la permanenza di residenze e di attività produttive. Questa evidenza sociale non riesce tuttavia a proporsi con altrettanta immediatezza come evidenza statistica e a identificare quindi una partizione territoriale del territorio nazionale che risulti indubitabilmente segnato dai tratti della montanità."
Su Il Bo Live una conversazione con Mauro Varotto, docente di Geografia all'Università di Padova e referente del corso di aggiornamento professionale RIMONT, pensato per favorire nuove residenzialità in montagna, fornendo strumenti utili per il reinsediamento e l'attivazione di nuove economie in aree montane marginali. Con il percorso NEWMONT, dedicato alle nuove forme di comunicazione scientifica, giornalistica e istituzionale sulle montagne oltre gli stereotipi, si inserisce nel progetto Orizzonte Montagna. "L'obiettivo è quello di offrire un'opportunità di riflessione sia per chi vive in montagna, sia per chi vuole andare a viverci, nel tentativo di mettere insieme queste due dimensioni - spiega Varotto a Il Bo Live -. La vera sfida sta nella mediazione, ovvero nella creazione di un collegamento tra le comunità di montagna, che spesso subiscono questi processi dall'esterno, e i nuovi abitanti o potenziali tali, che stanno cercando casa e vogliono informarsi".
E Varotto continua: "Oggi è necessario governare il cambiamento in atto. Sono sempre di più le persone interessate: è importante inserirle in una dinamica di collaborazione e cooperazione. Con questo percorso, noi consideriamo l'area triveneta: la Val Posina, nelle Prealpi vicentine, la Val di Zoldo, sopra Belluno, nel Cadore, e Tolmezzo, interessante come intersezione tra dinamiche di risalita e progetto di comunità [...] Le montagne interessate da questi fenomeni di ripopolamento non sono né quelle troppo turistiche né quelle troppo marginali: sono quelle che riescono a garantire servizi minimi essenziali. Qui non consideriamo le scelte di tipo eremitico, più sporadiche, a interessarci è la fascia intermedia, abbastanza prossima alla pianura, alle città”. E sulle motivazioni aggiunge: “Ci sono persone che scelgono di andare a vivere in montagna per realizzare un progetto di vita, facendo perno sulle risorse di una montagna tradizionale, un esempio potrebbero essere i nuovi giovani pastori, ed esistono persone che si spostano, muovendosi tra montagna e città, come faccio io del resto, con la residenza nel comune montano di Posina e il lavoro a Padova. Ovviamente le difficoltà ci sono ma vanno soppesate con le opportunità. Lo stile di vita non è lo stesso del centro di una città, non si hanno le stesse opportunità ma, in cambio, si riceve qualcos'altro".
Dunque, non una montagna semplicemente turistica, intesa come luogo di villeggiatura, ma un luogo da chiamare casa nel quale fondare e far crescere concretamente un progetto di vita. "Oggi le soluzioni più interessanti sono quelle in cui a un impegno per la montagna si affiancano attività professionali non associabili all'immaginario della montagna: con e dopo la pandemia, per esempio, la possibilità di lavorare da remoto ha spinto anche in questa direzione".

Per comprendere il tema del reinsediamento nelle terre alte si deve necessariamente tornare indietro nel tempo e considerare il fenomeno dell'abbandono dei comuni montani, che ha origini lontane. "L'abbandono della montagna inizia tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. In parte è dovuto a un incremento demografico, con condizioni igienico-sanitarie migliorate, una maggiore natalità e una minore mortalità: vi è un aumento del carico demografico ma non vi sono abbastanza risorse per sostenerlo - spiega Varotto -. Se da una parte esiste un sovrappopolamento, dall'altra vi è una economia che inizia ad assumere connotazioni di tipo industriale e attira la popolazione nei centri di pianura. La ricerca condotta negli anni Trenta del secolo scorso dall'Istituto nazionale di economia agraria offre una mappatura dell'abbandono: un fenomeno che si mostra intenso, già negli anni Trenta, nella parte occidentale dell'arco alpino italiano e resta dapprima potenziale nella parte orientale, dove invece inizierà tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, nel secondo dopoguerra, quando la pianura diventa più attrattiva, luogo di sviluppo che richiama popolazione. Oggi questo fenomeno dell'abbandono è ancora in parte presente, o meglio, da un lato vi sono comuni che continuano a perdere abitanti, principalmente a causa dell'invecchiamento della popolazione, ma vi sono anche fenomeni di ritorno, che andrebbero favoriti e incentivati. C'è bisogno di manutenzione e gestione della montagna, anche per il turismo, e vi è l'opportunità garantita da nuovi mezzi di comunicazione, la tecnologia, lo smart working che possono consentire di vivere in montagna, che non è la stessa da cui si è scappati".
A questi aspetti, che rendono più attraente la montagna, se ne aggiungono altri, fondamentali, sui quali oggi si fonda qualsiasi progetto di reinsediamento: la dimensione di micro-comunità, il contatto con la natura, il fattore climatico. Nel libro Migrazioni verticali (Donzelli), a cura di Andrea Membretti, Filippo Barbera e Gianni Tartari, ci si chiede se la montagna ci salverà. "L'indagine dei sociologi, che ruotano attorno all'università di Torino, parlano proprio della propensione a cercare una casa o stabilirsi in montagna nel prossimo futuro per sfuggire ai cambiamenti climatici, al calore estremo".
I dati sono online, disponibili su MICLIMI (Migrazioni Climatiche e Mobilità Interna della metromontagna padana)

Su un'idea di montagna da ripensare come luogo dinamico, sulla differenza tra abitare in montagna e abitare la montagna, sulle montagne di mezzo - "che sono qualcosa di più di un concetto altimetrico, qualcosa di più di uno spazio marginale, sono il luogo di una nuova medietas tra funzioni diverse, un nuovo progetto di vita per le contrade a venire" - e su esigenze e nuove visioni legate anche a considerazioni sul futuro del pianeta, si basa una riflessione scritta da Varotto per il sesto numero di Mappe del Touring club italiano, dedicato a La vita in alto, a cui affidiamo le conclusioni. "Abitare la montagna non significa semplicemente avere un domicilio in quota, possedere o frequentare con una certa assiduità un’abitazione - scrive -. L’azione dell’abitare si dilata e investe un perimetro più ampio, implica un investimento sulla montagna, presuppone un sentirsi parte dei luoghi, considerarli casa in termini larghi ed elettivi, farsi carico del loro destino, creare con essi un fascio di relazioni ambientali e sociali: la dimensione quantitativa o burocratico-amministrativa dell’insediamento cede così il passo a una dimensione qualitativa, più ricca ma anche molto più complessa da definire. Capire questa differenza è fondamentale alla vigilia di movimenti migratori verticali che sempre di più in futuro potrebbero interessare la montagna come via di fuga da città e pianure roventi a causa del global warming".

Riabitare la montagna: formazione, mediazione, facilitazione al reinsediamento nelle terre alte
Inserito in Orizzonte Montagna, progetto dell'Università di Padova coordinato di formazione e cultura per la montagna, il corso RIMONT (le iscrizioni sono in chiusura, il corso inizierà a settembre) si ispira a esperienze già realizzate in altre aree dell’arco alpino italiano per accompagnare la domanda di nuove residenzialità in aree montane, allo scopo di fornire strumenti per favorire il reinsediamento e l’attivazione di nuove economie in aree montane marginali.
Partendo da esperienze concrete della montagna veneta e friulana (Val di Zoldo, Val Posina, Carnia) verranno affrontate questioni di governance e gestione dei processi di ripopolamento, valorizzazione del patrimonio insediativo (disponibilità di alloggi, accesso a incentivi per ristrutturazioni), inserimento all’interno del tessuto economico e sociale dei territori (rapporti tra vecchi e nuovi abitanti, forme di cooperazione, accesso ai servizi). Il corso si offre come opportunità per una nuova alfabetizzazione alla montagna per aspiranti montanari, fornendo competenze trasversali di carattere ambientale, economico e sociale utili a favorire l’inserimento e l’integrazione nel tessuto economico, sociale e ambientale delle montagne del Triveneto.
Guarda gli episodi di "Dolomiti"