
Jannis Kounellis (1936-2017), "Resistenza e Liberazione", cortile di Palazzo Bo - Università di Padova
Hombre vertical in un mondo in cui spesso per andare avanti bisogna piegarsi: è l’immagine che emerge dalle pagine di Contro gli spiriti docilmente curvilinei (Cierre Edizioni, 2025), la monografia con cui Fabio Targhetta, storico della scuola presso l’Università di Macerata, racconta la figura di Adolfo Zamboni (1891-1960), protagonista della Resistenza padovana.
Un percorso, quello di Zamboni, che racchiude in sé più vite, tutte all’insegna della coerenza e del rigore morale, a costo di sacrificare il proprio particulare. Soldato ed eroe di guerra, ferito durante il primo conflitto mondiale e decorato con ben tre medaglie d’argento, insegnante di filosofia al Liceo Scientifico Nievo, raffinato traduttore e autore di manuali di successo, è per molti anni unico docente di scuola secondaria nella provincia di Padova a non essere iscritto né al partito fascista né ad alcuna delle sue organizzazioni. Scelta in qualche modo permessa dal valore dimostrato in battaglia, ma pagata con vent’anni di emarginazione e di occhiuta sorveglianza poliziesca. Dopo l’8 settembre diventa subito una colonna portante della Resistenza padovana, collaborando con figure di spicco come Concetto Marchesi ed Egidio Meneghetti e aprendo le porte di casa sua alle prime riunioni del CLN locale come esponente di primo piano del Partito d’Azione.
LEGGI ANCHE: La Grande Guerra attraverso gli occhi di uno studente
Imprigionato il 18 novembre 1944 e torturato dalla famigerata banda Carità, dopo la Liberazione gli viene conferito l’incarico temporaneo di provveditore agli studi, fondamentale nella sua visione per defascistizzare la scuola, uno dei fulcri della propaganda e dell’idea di società del regime. Una missione che sostanzialmente gli sarà impedito di realizzare, ed è qui che la sua vicenda assume una valenza che va ben al di là del suo percorso personale. Quello che sceglie di portare avanti è un compito difficile: garantire una vera epurazione degli insegnanti più compromessi con il fascismo in modo da restituire alla scuola un’impronta democratica; presto tuttavia il suo operato entra in contrasto con le dinamiche di potere della nuova Italia repubblicana, a volte troppo ansiosa di far calare l’oblio su un passato imbarazzante. "Zamboni viene così a trovarsi in una posizione scomoda: non ha padrini politici e rifiuta compromessi al ribasso”, commenta Fabio Targhetta, che nelle sue ricerche ha potuto consultare, oltre ai principali archivi pubblici, anche le carte personali preservate dal nipote del protagonista, Adolfo Zamboni Jr.
Il tentativo di impedire il reintegro indiscriminato di docenti ed ex funzionari troppo compromessi con il regime attira dunque su Zamboni l’ostilità di vari ambienti politici, inclusi quelli che dovrebbero sostenerlo: nel 1947 viene dunque rimosso dall’incarico di provveditore, a beneficio di un iscritto della prima ora al partito fascista e aderente alla repubblica di Salò, Paolo Biagini, prontamente reintegrato assieme a tanti altri nelle file di quella che dovrebbe essere la nuova scuola democratica e repubblicana. L’indignazione nella città è grande e lo stesso Zamboni protesta con veemenza: in una lettera aperta indirizzata al ministro della pubblica istruzione, Guido Gonella, denuncia il tradimento dei principi per cui ha lottato. Un’azione anche questa in linea con la dirittura morale del personaggio, ma che probabilmente brucia definitivamente ogni sua possibilità di carriera.
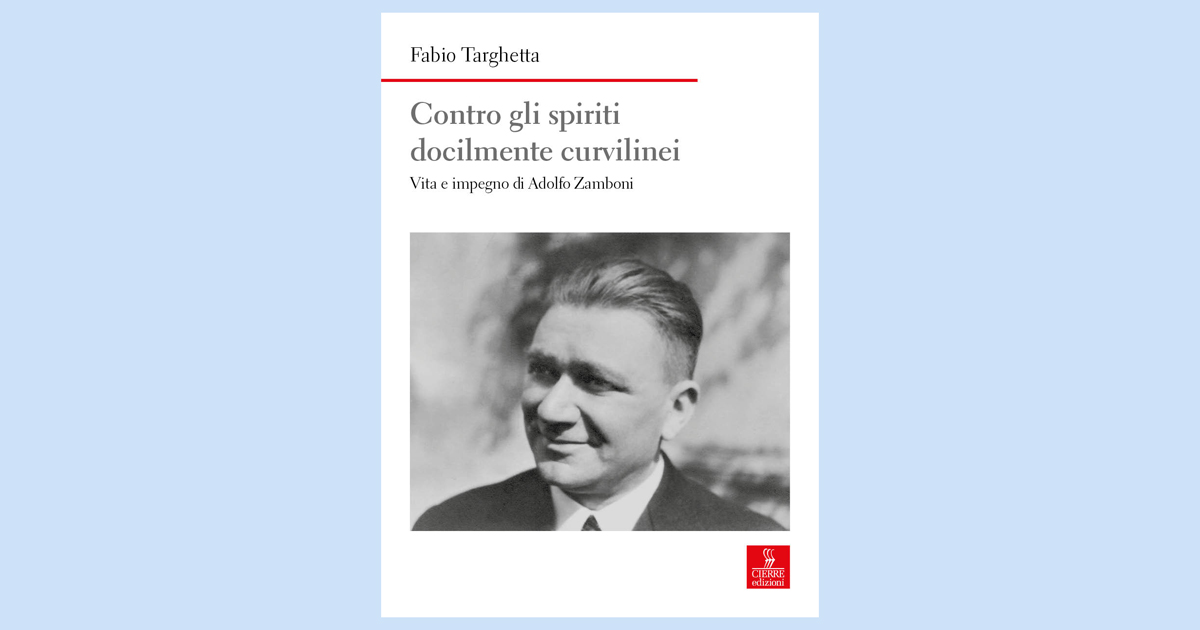
Così, dopo l’allontanamento dall’incarico, Zamboni torna all'insegnamento in quello stesso ambiente scolastico che per decenni lo ha a mala pena tollerato. Qui si dedica a formare le nuove generazioni mantenendo sempre il suo stile sobrio e riservato, senza mai accampare meriti o reclamare onori, peraltro ampiamente meritati. Morirà nel 1960, lasciando un'eredità morale ancora oggi attuale in una vicenda che getta luce su un passaggio decisivo della storia del nostro Paese. “In generale la scuola italiana non conobbe una reale discontinuità tra il fascismo e la Repubblica, sia in termini di personaggi, dato che non ci fu una vera epurazione, che di mentalità”, sottolinea Fabio Targhetta, che del tema si era già occupato nel libro Sui banchi di scuola tra fascismo e Resistenza (Padova University Press 2016), scritto con la storica Giulia Simone. “Del resto la macchina ministeriale ha tempi di cambiamento straordinariamente lunghi e Zamboni era un personaggio difficile da collocare, soprattutto in un Paese che voleva chiudere in fretta i conti con il passato”.
Questo non toglie forza e per molti versi attualità a una figura che purtroppo non ebbe modo di dare il contributo che avrebbe potuto alla nuova Italia democratica. “Fu un uomo estraneo alle ideologie dominanti dell’epoca e non poté contare su alcuna protezione politica, ma solo sulla sua forza morale – conclude lo storico –. Incarnava l’etica dell’impegno e del vivere civile al di fuori di ogni considerazione sul proprio tornaconto personale: un autentico patriota, se si vuol ricorrere a un termine oggi spesso abusato. Senza dubbio un esempio anche in un’epoca che, come la nostra, è spesso caratterizzata dal senso di smarrimento rispetto alla fine delle grandi narrazioni politiche”.
SPECIALE RESISTENZA A PADOVA
- Otto settembre 1943: la seconda Caporetto
- L'antifascismo di Concetto Marchesi
- Gli studenti che fecero la resistenza
- Kounellis a Padova: storia di un monumento incompreso
- L’attentato del 1944 a “Il Bò”
- Le sorelle Martini, partigiane e studentesse
- Il comandante “Renato”
- Mario Todesco, il martire mite
- Lodovico Todesco e gli studenti partigiani del Grappa
- Concetto Marchesi, il rettore sovversivo




